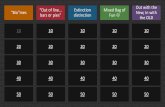RootsHighway Mixed bag #1
-
Upload
fabio-cerbone -
Category
Documents
-
view
232 -
download
8
description
Transcript of RootsHighway Mixed bag #1


SSSSSSSSOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRR IIIIIIII OOOOOOOO
numero numero numero numero 1111, , , , ottobreottobreottobreottobre 2002002002008888
RootsHighway’s Pick Il disco del trimestre
John Mellencamp …..3
Monthly Revelation Agosto - ottobre 2008 James Jackson Toth, Conor Oberst, Baseball Project, Ali Eskandarian, Don Chambers, Ry Cooder …..4
Second Hand Avvistati in questi mesi Marc Ford, Giant Sand, Lucinda Williams, Galdalf Murphy, Eleven Hundred Springs, Black Angels, JJ Grey & Mofro, Richie Havens, Last Man Standing, The Acorn, Buffalo Killers, David Vandervelde, Mandolin’ Brothers …..8
ClassicHighway Tracce dal passato, la ristampa Rodriguez …..15
Pneumonia Boxes, tribute & live records The Pogues …..16
BooksHighway I libri del trimestre Elmore Leonard, Jim Harrison, Richard Ford, James Lee Burke …..17
Folklore La monografia di Rootshighway Del Fuegos …..19

RRoooottssHHiigghhwwaayy’’ss PPiicckk Il disco del trimestre
JJoohhnn MMeelllleennccaammpp
LLiiffee DDeeaatthh LLoovvee aanndd FFrreeeeddoomm
[Hear Music/ Universal 2008] di Fabio Cerbone Nessuno sconto, nemmeno per se stessi: lo scorrere inesorabile del tempo, il senso di caducità della vita di un artista che ha ottenuto tutto o quasi, infine lo spettro della morte, sbattuto in faccia senza remore. Un incastro di ombre certo, ma anche di speranze, questo Life Death Love and Freedom, che non a caso decide di includere le ultime due parole: c'è sempre una luce in fondo alla strada, A Brend New Song da intonare per la tua famiglia, i tuoi desideri, la tua stessa nazione; c'è sempre una My Sweet Love (delizioso singolo in tono vogliosamente fifties) da inseguire, nonostante le incomprensioni, le parole non dette, i capricci del momento. John Mellencamp manda all'aria il "populismo" rock del recente passato, l'Our Country che gli aveva permesso, con una astuta mossa commerciale, di riportarsi ai piani alti delle charts americane con il precedente Freedom Road, per abbracciare il disco più scuro, denso, "d'autore" della sua carriera. Non è nuovo a queste sortite John Mellencamp, e lo dovrebbero sapere bene i suoi affezionati sostenitori: tra l'intimismo familiare di Big Daddy, un disco mai troppo compreso, e la ricerca dei fantasmi del folklore americano attuata in Rough Harvest e soprattutto in Trouble no More, la declinazione asciutta, spettrale, prevalentemente acustica di Life Death Love and Freedom non dovrebbe sorprendere più del dovuto. Anche se, con la produzione ovattata di T Bone Burnett, il minimalismo blues che avvolge molti di questi episodi, il disco si svela come il più intransigente della sua carriera, dimostrando finalmente che il rocker orgogliosamente blue collar nasconde da sempre una coscienza da folksinger degna erede di Woody Guthrie, di Bob Dylan, di Robert Johnson. Dalla confessione disarmante di Longest Days (Seems like once upon a time ago/ I was where I was supposed to be...But nothing lasts forever), l'artista John Mellencamp apre l'anima alle verità scomode del suo passato, ricordandosi di quello che è stato e non sarà più, perfino esorcizzando con cruda schiettezza la morte nel blues torbido di If I Die Sudden. La musica è vibrante nonostante la sua forma ossuta: le chitarre di Andy York e quelle dello stesso T Bone Burnett sono una eco che riverbera sul fondo di una antica vallata, la voce di John al centro dell'attenzione, per non perdere un solo momento il senso delle parole declamate. Folk music si diceva: nella selva di quella ancestrale visione, un po' apocalittica, appartenuta alla migliore tradizione degli Appalachi, tra una livida Young Without Lovers, una "fastidiosa" dichiarazione di intenti quale Don’t Need This Body ed infine una paludosa, sporca e bluesy John Cockers. Non solo introspezione e caratteri personali tuttavia, ma riflessi che ricadono come scintille sull'America intera, mai mancando di far sentire la propria voce sui mali

di queste martoriate stagioni politiche: con meno foga però, una consistenza quasi poetica che per John Mellencamp è una dimostrazione di grandissima maturità nel songwriting: qui nascono Without A Shot, nera come la pece, le paure minacciose di The County Fair e soprattutto la preghiera di Troubled Land, capolavoro di sintesi del disco che si affianca alla predica sudista di Jena, ispirata dalle odiose recrudescenze razziste svoltesi nella cittadina americana lo scorso anno. Fra la spessa coltre di perdita e morte l'appiglio di un ritorno a casa (A Ride Back Home, con la seconda voce femminile di Janas Hoyt) e la fiducia nelle cose più care (For The Children), mantenendo la bussola di una musica mai accondiscendente con il proprio mito, anzi scomoda e bruciante come un pugno nello stomaco. Life Death Love and Freedom è un piccolo miracolo artistico, il migliore raccolto che Mellencamp abbia saputo portare a casa in tempoi recenti
MMoonntthhllyy rreevveellaattiioonnss maggio - agosto 2010
JJaammeess JJaacckkssoonn TTootthh Waiting in Vain [Rykodisc/Audioglobe 2008] E’ veramente un enigma questo Waiting in Vain, sorta di esordio di James Jackson Toth con il nome di battesimo, per molto tempo nascosto dietro pseudonimi e progetti disorganici che mettevano in evidenza la sua natura di moderno freak. Un tempo infatti Wooden Wand & the Vanishing Voice, accorciato al semplice Wooden Wand, comitiva di sperimentazioni folk a bassa fedeltà e stramberie in dorore di psichedelia, la musica di Toth si è spesso celata dietro una maschera di provocazioni, ordinaria amministrazione per un newyorkese cresciuto fra le pulsioni del Village e la no wave degli anni più fertili del rock indipendente. Tanto è vero che l'ultimo sforzo in ordine di tempo era stato quel James and the Quiet prodotto insieme a Lee Ranaldo (Sonic Youth), in cui i segnali di un naturale, progressivo avvicinamento alla forma canzone si erano resi manifesti. Waiting in Vain è il "tradimento" definitivo, il salto verso un rock d'autore che sappia includere forma e sperimentazione, passato e presente, radici che scavano tanto nel lascito artistico dei sixties
quanto nelle più contemporanee riletteure di quell'eredità. Non piacerà a chi lo ha sempre visto come una delle possbili avanguardie del rinascimento indie folk di queste stagioni: eppure, grazie alla produzione "adulta" di Steve Fisk (nome storico dell'alternative rock) e alle incursioni delle chitarre di John Dietrich (Deerhoof) e Nels Cline (Wilco), grazie al basso di Shayde Sartin (Giant Sunflower Band) e alla batteria di Otto Hauser (Vetiver/Devendra Banhart), grazie soprattutto ai contrappunti vocali di Carla Bozulich e della compagna Jexie Lynn Toth, Waiting in Vain si materializza come uno dei dischi più misteriosi e seducenti di questo 2008. Buona parte del merito ricade sulla scrittura immaginifica, a tratti impressisonistica altre più severa e crudele di Toth, una penna di categoria superiore che si strugge fra il romanticismo di Doreen e le confessioni malate e maledette di Look in On Me, aprendo gli argini nella torrenziale, dylaniana Beulah The Good. Quello che resta, e non è certo un dettaglio, riporta tutto ad una fisionomia folk rock che riesce a suonare tradizionale senza scadere nella calligrafia: The Banquet Six sfiora ruvide spirali psichedeliche con la chitarra marziale di Nels Cline, Becoming Faust e The Park si agitano nervose con un'animosità punk, mentre Poison Oak e Midnight Watchman ribaltano ogni previsione addolcendosi dentro un profilo di ballata trasognata e morbida, che staziona a metà strada fra quello che fu la West Coast (si veda anche la dolcissima Do what You can) e le intuizioni dei Wilco, ai quali, a più riprese, Waiting in Vain non può fare a meno di accostarsi (Nothing Hides). Avrebbe voluto intitolarlo Becoming Faust - e sarebbe stato assolutamente appropriato, non c'è che dire - è

diventato invece Waiting in Vain, un disco che a detta dello stesso James Jackson Toth riguarda "il rapporto fra tentazione e redenzione e le diverse prospettive con cui le puoi osservare". C'era da aspettarselo, visto il palese accostamento alla mitologia di Robert Johnson, nonostante il blues come linguaggio codificato della tradizione americana sia soltanto un pretesto di fondo, una lontana eco che si stempera nello stile personalissimo di questo storyteller dall'animo inquieto, scuro, enigmatico. (Fabio Cerbone)
CCoonnoorr OObbeerrsstt Conor Oberst [Wichita/ Merge 2008] Il signor Occhi Brillanti ha gettato la maschera. A dieci anni esatti dall'esordio indipendente con il già convincente Letting Go The Happiness, uscito nel 1998 quando il nostro aveva la bella età di diciotto anni, Conor Oberst ha deciso infine di mandare in soffitta lo pseudonimo di Bright Eyes e di cominciare ad incidere usando solamente il suo nome di battesimo. Già questo dovrebbe essere un segno, visto che il cambio giunge quasi a consolidare una strada intrapresa dal 2005, quando con I'm Wide Awake, it's Morning, Conor/Bright Eyes aveva sterzato verso sonorità più "classicheggianti" e cantautoriali, lasciandosi alle spalle gli esordi più sperimentali e lo-fi e duettando perfino con Emmylou Harris. Conferme le avevamo avute poi con il live Motion Sickness, ancora del 2005, in cui il vecchio materiale veniva rivisitato con una vena decisamente roots, con aperture verso il country, e soprattutto grazie al successivo Cassadaga, uscito un anno fa, che si innestava nel percorso tracciato da Dylan e da Gram Parsons, passando per i Waterboys. Era inevitabile, quindi, aspettarsi un album che proseguisse su questo sentiero e, almeno stavolta, Conor non ci lascia affatto spiazzati. Questo lavoro è infatti un disco di cantautorato classico, dylaniano, semplice e diretto e che mette al centro non i suoni, come spesso avveniva negli album a firma Bright Eyes, ma le canzoni. E bisogna riconoscere che Oberst di come si scrive una canzone se ne intende, eccome.
In più, anche la voce mostra una crescita importante, non è più così cantilenante ed incerta come agli esordi, ma si è fatta più sicura ed al contempo più aspra, dylaniana appunto. A tratti, pare addirittura di sentire Tom Petty, come nel bel rock and roll trascinante I Don't Wanna Die (In the Ospital), o nella lirica Moab (in cui Oberst canta che "Non c'è niente che la strada non possa curare", quasi una dichiarazione di intenti), nei cui solchi pare davvero di intravedere l'ombra del biondo della Florida e dei suoi Spaccacuori. Altrove, invece, il songwriter di Omaha si avvicina di più a una scrittura meditativa che si ricorda da vicino il piglio più intimista di un Josh Ritter o addirittura la malinconia degli ultimi lavori di Bonnie Prince Billy, come nella nostalgica Cape Canaveral, che apre il disco, o nella latente tristezza della conclusiva Milk thistle, che Oberst chiude mestamente con la frase "Se dovessi andare in Paradiso sarei infernalmente annoiato come un bambino in lacrime sul bordo di un pozzo". E non è un caso che l'album si concluda in questo modo così buio. Infatti, in tutte le tracce si legge una inquietudine di fondo, data dallo sgretolamento del mito americano e di tutte quelle promesse e quei sogni che l'amministrazione Bush sta prendendo a picconate ormai da anni (non dimentichiamo che Oberst è stato protagonista del Vote For Change tour). In Lenders in the Temple, scarna ballata per chitarra acustica con una linea d'organo alle spalle a conferirle tensione, Oberst usa la metafora evangelica dei mercanti nel tempio accanto ad immagini quasi apocalittiche, che culminano con il mesto atto d'accusa "Cancella te stesso e sarai libero", questa insoddisfazione si fa opprimente, mentre altrove, come nella brillante Souled out!!!, dall'atmosfera molto seventies, o nella citata Cape Canaveral, Oberst sembra sottolineare con disincantato distacco il tramonto di un'epoca, quella dei sogni, della "promised land" e del mito americano. Insomma, ci troviamo per le mani un disco pieno di tensioni, di pensieri, di tristezze, di cadute (molte) e di improvvisi moti di orgoglio (un po' meno) da ascoltare possibilmente, noi italiani, con le liriche davanti per coglierne appieno la profondità e i moti dell'animo che Conor Oberst, ormai uno dei grandi songwriter di questa generazione, induce nell'ascoltatore più attento. (Gabriele Gatto)

TThhee BBaasseebbaallll PPrroojjeecctt Vol.1: Frozen Ropes and Dying Quails [Blue Rose/ IRD 2008] Una passione e un amarcord sportivo che si trasformano, nelle mani di due songwriter, nell'omaggio più curioso che il rock'n'roll abbia tributato al baseball. Nasce infatti dalla reciproca stima artistica fra Steve Wynn e Scott McCaughey, ma soprattutto dalla comune condivisione di miti e leggende di questa saga tutta americana, la costruzione di una sorta di romanzo musical-sportivo che attraversi il tempo passato, gli eroi dell'adolescenza, le figure di culto e persino gli outsiders e i perdenti per leggere nelle loro gesta, fra vittorie clamorose e altrettante cadute, la trama della vita stessa, gli scherzi riservati del destino, la gloria di un momento. The Baseball Project ha preso forma senza tentennamenti, dopo qualche fugace incontro lo scorso anno negli studi casalinghi di McCaughey a Portland, potardosi appresso la voglia di condividere sensazioni, memorie, fanatismi: una settimana di ridefinizione dei testi, di alcune idee reciproche, la naturale propensione a coinvolgere gli amici e i compagni più vicini (Linda Pitmon dietro i tamburi, Peter Buck dei REM a cesellare con chitarre e mandolini), mettendo in piedi un quartetto che possiede la fragranza di una rock'n'roll band estemporanea eppure vivacissima. Vol.1: Frozen Ropes and Dying Quails è apparso da subito un disco non soltanto efficacissimo nella sua struttura lirica, ma anche effervescente nell'ordito musicale, rinfrescando quelle radici folk rock da cui tutti i nomi coinvolti nel progetto provengono. Steve Wynn appare infatti più disinvolto che mai, assai più elettrizzato rispetto alla sua ultima prova solista, dando corpo al suo livido rock notturno in Gratitude (For Curt Flood), baloccandosi con il folk rock in spagnolo di Fernando e la sbandata country punk di Harvey Haddix, o ancora il terso vibrare di Long Before My Time e la perfetta conclusione con il brontolio di feedback e distorsioni in The Closer, ode agli specialisti del finale di partita, giocatori dal sangue freddo chiamati a chiudere con la zampata vincente l'intero incontro. McCaughey (dagli Young Fresh Fellows ai Minus 5 passando per i REM, una carriera da gregario di lusso la sua) allunga la falcata con le sue rievocazioni sixties, quel pop imbrattatato di garage rock
(The Death of Big Ed Delahanty) che nelle mani di un chitarrista come Peter Buck accresce ulterioremente il suo appeal, oscillando fra la tradizione di una Satchel Paige Said dal sapore dylaniano e quella Jackie's Lament che sembra resuscitare Byrds e Tom Petty in un colpo solo. Era d'altronde palese fin dalla partenza con Past Time che The Baseball Project sarebbe stato qualcosa di più di un semplice divertissment fine a se stesso: c'è intesa fra gli atleti in campo ed è gioco facile ammettere che il quartetto ha messo a segno il suo personale home run. Anche perché, nonostante vi sia la concreta possibilità che non abbiate mai sentito parlare di Ted Williams, Curt Flood, Leroy Paige, Willie Mays o Harvey Haddix, The Baseball Project vi apparirà comunque un romanzo popolare a suon di rock'n'roll, fitto certamente nella sua anedottica (tantissimi i riferimenti storici e le date presenti nei testi), ma meno che mai cattedratico e presuntuoso nella sua esposizione. È il contraltare della musica a rendere Vol.1: Frozen Ropes and Dying Quails un racconto coinvolgente, da leggere e sentire tutto di un fiato: la cura dei dettagli, la confezione cartonata con tutte le liriche e le introduzioni personali che chiariscono con pochi tratti le scelte di Wynn e McCaughey non fanno altro che accrescere il valore di queste cronache dal mondo sempre un po' troppo specialistico e lontano del baseball, almeno per la maggior parte del pubblico italiano. (Fabio Cerbone)
AAllii EEsskkaannddaarriiaann Nothing to Say [Wildflower/Audioglobe 2008] Qualcuno proverà a convincervi, e magari a distrarvi, sul fatto che il tratto più significativo di Ali Eskandarian sia la sua biografia: una vita errante, a suo modo "esotica", quella che ha portato un ragazzo di origini iraniane, figlio di un militare cacciato dal regime dopo la morte dell'Ayatollah Khomeini e rifugiato politico con l'intera famiglia prima in Germania e poi negli Stati Uniti, in giro per il mondo. Certo, notare i dettagli di questa storia ha un senso preciso, se non altro per sottolineare come quella strana forma di melting pot da sempre generata nel rock sia in grado soprattutto di fornire un senso di libertà preciso a chiunque abbia voglia di confrontarsi con esso. C'è ben altro però nella

musica di Ali Eskandarian, a cominciare dal fatto che lui - ragazzo americano a tutti gli effetti, è nato in Florida e cresciuto a Dallas prima di finire a suonare nella coffee houses di New York - dell'antica terra persiana ha soltanto un ricordo sfumato, che ritorna sottilmente nelle salite improvvise della sua vibrante vocalità, in qualche esplicito omaggio (il finale con Eastern City) e in altre soluzioni interpretative che si mischiano al sostrato folk di Notthing to Say. Un esordio che la newyorkese Wildflower ripesca dalla più totale indipendenza (le registrazioni del disco risalgono al 2006) per farne una delle più limpide raccolte di stagione, accodato a quel rinnovato gusto "dylaniano" che in questo 2008 aveva già passato al vaglio Pete Molinari. Rispetto al ragazzotto inglese, i capelli arruffati e il volto inquieto di Ali Eskandarian sembrano sondare un terreno meno ripiegato sul revival e attento semmai alle tonalità aspre del songwriting: insomma una personalità persino più spiccata, in cui il folk rock serve come base di partenza per mettere a nudo l'anima di un folksinger fragile e rude al tempo stesso, a metà strada fra il suono rurale della generazione Americana (Waking Up is Hard To Do) e le spirali più ardite di un menestrello alla Tim Buckley (Nobody). Conquista, in tutto questo gioco di rimandi, la semplicità disarmante delle melodie, lo scandire scarno della chitarra acustica di Ali, intorno alla quale però il bravissimo Rob Friedman (produttore del disco, già al fianco dell'ex Del Fuegos Dan Zanes ) innesta deliziosi ricami di lap steel, resonator, organo, pianoforte e accordion, impastando le sonorità di queste ballate, così eterne e soffuse, con le tonalità di una musica sinceramente old time. In tal senso esemplare è la melodia di Memphis, storia guarda caso di un vagabondo che cerca disperatamente di far rivivere la memoria della sua città: riassume l'ingenua bellezza delle composizioni di Eskandarian, che difficilmente potranno essere scambiate per una furbesca rapina dei modelli di riferimento. Questo assunto lo potremmo estendere all'intero Notyhing to Say: a meno che abbiate un cuore di pietra, fareste meglio a lasciarvi avvolgere dalla flessuosa e carezzevole melodia di All We Do, dal crescendo di una tersa Black Tar Man, forse la più sottilmente pop del disco, dalle scosse folk blues di una spietata Government Meat che succhia linfa vitale dal Sud e ancora dalla cruda dichiarazione contenuta in una nervosa Johnny Goes to War. Quest'ultima non sarà forse uno stralcio di poesia in musica, ma basterebbe quel War Yeah urlato in maniera liberatoria a metà brano o meglio ancora lo schiaffo di un verso quale "nineteen years old with 23 kills" per testimoniare la scorza solida e robusta di Ali Eskandarian. Un inaspettato incontro, una sorpresa da tenersi stretta. (Fabio Cerbone)
DDoonn CChhaammbbeerrss && GGooaatt Zebulon [Warm Electronic 2008] Si definisce un "surrealist reporter", calandosi nei panni delle voci più oscure dell'America, scrivendo dalla loro prospettiva e raccontando storie che sono intrise del mistero tipico della letteratura sudista e dei suoi luoghi topici. Sullo stesso tortuoso percorso, con quell'inevitabile senso del gotico, che hanno affrontato in questi anni band quali Sixteen Horsepower e Handsome Family, ma con un accento più smaccatamente da folksinger ed un suono che non disegna di sporcarsi le mani nel fango del southern rock, Don Chambers è un piccolo segreto della scena di Athens (in giro dal '91 come leader dei Vaudeville), che ha tutto il diritto di prendersi il suo momento di gloria. Zebulon arriva infatti sulla scia di Don Chambers and Goat (2005) e I Got the Recollection of the Blood of the Lamb (2007), dischi che hanno suscitato qualche pettegolezzo in sede locale, ma non hanno trovato platee e attenzioni oltre i confini del Dirty South. Oggi che alla produzione da una mano il ben più famoso collega Patterson Hood (Drive By Truckers), c'è la possibilità che su Chambers si accendano i riflettori: noi stessi ci accodiamo volentieri, scoperchiando un songwriter dalla voce al catrame, un Tom Waits perso lungo le rive del Mississippi, ma soprattutto uno scrittore vivido e intenso che infila nei suoi versi narrazioni dalla strada. Il viaggio come elemento di scoperta, di esperienza, ma anche di timori e incertezze, magari sconfitte: Zebulon è colmo di personaggi, luoghi (a partire dall'omonima cittadina che da il titolo al disco), dettagli di un'America fuori quadro. Curioso che queste canzoni siano state metabolizzate e persino perfezionate a Berlino, dove Chambers ha risieduto per un breve periodo prima di fare ritorno nella sua terra: eppure le atmosfere plumbee e mittleuropee di Ghostly Leg e della splendida Send me No Angels, le stesse che spesso hanno impastato la produzione di David Edwards (Woven Hand, 16 Horsepower) sembrano proprio avere trovato una sorta di compromesso. Dal canto loro i Goat - l'ottimo Patrick Hargon alle chitarre,

Matt “Pistol” Stoessel alle pedal steel, Bandon McDearis alla batteria e percussioni, Fritz Gibson al basso - dosano sporcizia rock e effuzioni folk finendo spesso per adattarsi come un guanto alla vocalità di Chambers, addolcita dal contraltare femminile della collega di etichetta Liz Durret: è lei ad ammansire ulteriormente le morbide effusioni country di Highwater (con una splendida accoppiata di steel e pianoforte a comandare la melodia) e quella più folkie di Friar's Lantern. Insieme alla chiusura, impalpabile e quasi spirituale di Bind my Wounds, costituiscono l'angolo di paradiso di Zebulon, il volto angelico che resta avvolto dalle fiamme minacciose di tutto ciò che lo circonda, ballate nere e pioviginose che esaltano l'aria da precicatore di Don Chambers. Conjuring a Dead Rabbit, ad esempio, tira in ballo Lewis Carroll e siamo già dentro l'America più ancestrale, anche se il piatto forte incombe con gli stridori elettrici e il banjo pestifero di Open the Gates, in cui la filosofia rock di Patterson Hood deve avere giocato un ruolo non indifferente. Le è gemella Fire in the Kitchen, che sarebbe forse piaciuta al Tom Waits di Mule Variations. Pain The Moon è un canto solitario e funereo che abbraccia idealmente la successiva I Can Waltz, walzer sinistro e dall'eco lontana ripreso nel finale con This I Know, altra prova di country noir in cui la tradizione viene evocata fra gli spettri più inquietanti. Zebulon non è certo un disco di sconvolgente rottura: per queste strade infatti sono passate molte, troppe facce in tempi recenti. E tuttavia è davvero difficile trovarvi un minimo difetto di personalità: Don Chambers ha una voce riconoscibile, che si bagna in fiume di tradizioni sudiste da cui attingere senza timori. (Fabio Cerbone)
EExxttrraa ttrraacckk
RRyy CCooooddeerr I, Flathead [Nonesuch/ Warner 2008] Piace la ritrovata prolificità di Ry Cooder, dopo anni di speleologia nei meandri della musica
popolare di mezzo mondo. E piace la sua ostinazione nel proporre progetti che non siano solo raccolte di canzoni da inserire in playlist, ma opere con una loro autonoma coerenza. Il gatto Buddy non ha ancora finito di fare le fusa, ed ecco il terzo concept in quattro anni. Questa volta Cooder indossa la maschera di Kash Buk, musicista anni '50, appassionato di motori e di corse hot rod. E' lui, il flathead del titolo (che più o meno sta per "zuccone", ma flathead nel gergo delle corse clandestine di quegli anni è anche il nomignolo dato a un tipo di motore fai-da-te), protagonista di un viaggio nel tempo nell'America di metà '900, nell'epoca del rhythm & blues che diventa rock & roll, delle corse lanciate sulle strade della California nel cuore (o nel culo, se preferite) del sogno americano. Per scoprire che sessant'anni dopo di quel sogno è rimasto ben poco. Cooder ce lo racconta anche in un romanzo dallo stesso titolo, che ci auguriamo di vedere tradotto in italiano (niente meno che un mix di Steinbeck e Pynchon, a quel che si dice). Come accade in questi casi, più che la meta è il viaggio che conta, e i compagni incontrati per strada: personaggi surreali, alieni, musicisti country e freak di varia natura. Uno sguardo nostalgico su un periodo in cui "la stranezza era la norma", secondo le parole dello stesso autore. La musica naturalmente è parte fondamentale di questa eccentricità, mescolando con la consueta perizia nel dosare gli ingredienti un pizzico di follia post-moderna a quel suono vintage che Cooder e i suoi complici (più o meno i soliti: tra gli altri, Flaco Jimenez, Jim Keltner, il figlio Joachim, il trombettista John Hassell) maneggiano come nessun altro. Troviamo così le fragranze mariachi di Drive Like I Never Been Hurt di fianco a un numero "stonato" (nel senso di Jagger & Richards) come Waitin' For Some Girl; il centone di citazioni del Johnny Cash periodo Sun (si intitola proprio così: Johnny Cash) e l'omaggio a Bobby Bare di 5000 Country Music Songs, in mezzo a ballate dai contorni western (Spayed Kooley), danze da border (Filipino Dance Hall Girl) e numeri di adrenalina rock come Ridin' With the Blues. In Fernando Sez sembra persino di sentire un'eco balcanica che ci stupirebbe, se non avessimo a che fare con il musicista con le orecchie più aperte del pianeta. Tutto perfetto, dunque? In realtà il disco sconta in parte la sua natura narrativa: due intermezzi recitati infatti rompono l'equilibrio dell'album e ne allungano la durata senza aumentarne l'appeal. Di contro, il già citato Ridin' With the Blues, in cui Cooder torna a svisare sul manico della Stratocaster come non faceva dai tempi di Get Rhythm, è purtroppo solo un assaggio che viene sfumato dopo 3 minuti (lasciandoci con l'acquolina in bocca, in parte soddisfatta dal successivo Pink-o-Boogie, sostenuto da un grande lavoro di slide). Trona Girl poi, unico brano non cantato in prima persona (la voce è di Juliette Commagere), è una chiusura davvero un po' debole, con quei suoni da Twin

Peaks di frontiera. Insomma, nell'attesa di leggere il romanzo, ci troviamo tra le mani un album che ha il sapore di un capolavoro incompiuto. E che, ad accontentarsi, si rivela "solo" l'ennesimo ottimo
lavoro di quello che, probabilmente, è il più importante musicista roots (nel senso ampio del termine) in attività. Vi basta? (Yuri Susanna)
SSeeccoonndd HHaanndd avvistati in questi mesi
MMaarrcc FFoorrdd & The Neptune Blues Club [Provogue/ Edel 2008] Ci sarà un motivo se i migliori dischi dei Black Crowes hanno un debito non relativo con l'apporto di Marc Ford, chitarrista versatile (ha suonato a lungo anche con Ben Harper e ha prodotto, tra l'altro, anche Mescalito di Ryan Bingham) musicista con molti orizzonti ancora inesplorati. Concluso (questa volta, così sembra, in modo amichevole) anche il secondo passaggio nella famiglia Robinson (che ha prodotto soltanto dei gran bei concerti) e lasciato il posto con Ben Harper a Michael Ward (già con John Hiatt e Wallflowers) Marc Ford si è rituffato nella sua carriera solista sfoderando una dozzina di canzoni dense di blues, chitarre, psichedelia, rumori dal garage e dallo spazio, ma soprattutto tanto, tantissimo rock'n'roll o come dice lo stesso Marc Ford "rock and roll, perché ci tengo a distinguere: il roll è la parte dove c'è dentro il blues". The Neptune Blues Club non lo smentisce nemmeno per sbaglio e il rock'n'roll scorre oliato in ogni angolo del motore (Locked Down Tight, dove le chitarre giocano di sponda con l'armonica, e Go Too Soon, dove alla velocità di Jerry Lee Lewis vengono aggiunti i licks di Chuck Berry). A conti fatti, è fin troppo chiaro che Marc Ford è uno strepitoso chitarrista che attraversa le canzoni con lunghe scie psichedeliche, peraltro attitudine che conserva dai tempi dei Burning
Tree (e che a suo tempo ha sviluppato anche nei Blue Floyd, tributo ai Pink Floyd realizzato con Allen Woody dei Gov't Mule, giusto per dire la compagnia), ma qui si rivela anche un buon cantante e di certo un ottimo leader capace di interpretare situazioni eteree (Freedom Fighter), torbidissimi blues (Don't Get Killed, Spaceman, Mother's Day) e persino una grande soul ballad come quella Keep Holdin' On che chiude il disco. C'è dell'altro, comunque: in Shame On Me, puro Rolling Stones style, Marc Ford gioca a fare il Ron Wood con la slide sul canale sinistro e Keith Richards con i riff su quello destro, un modo saggio di usare lo studio di registrazione e la relativa tecnologia, ma sono Main Drain e Last Time Around Again le canzoni che possono rivelargli un futuro da protagonista. Main Drain ha il groove di Dr. John (e anche la voce si avvicina da quelle parti) e chitarre bollenti, mentre Last Time Around Again è una grande canzone in cui sembra di sentire un incrocio, non del tutto improbabile, tra i Jayhawks, i Counting Crows e Black Crowes ovvero quello che è sempre mancato ai Golden Smog. Per il resto, le chitarre e gli amplificatori sono maltrattati come non si sentiva da parecchio tempo e tra gli invitati al Neptune Blues Club, Anthony Arvizu alla batteria, Bill Barrett all'armonica, Mike Malone alle tastiere, Stephen Hodges, percussionista (già con Tom Waits) e John Bazz al basso, un tempo con i Blasters. Bella compagnia per Marc Ford e per The Neptune Blues Club, che è il suo disco migliore, degno di stare tra America e Three Snakes And One Charm. Roba pesante. (Marco Denti)

GGiiaanntt SSaanndd proVISIONS [Yep Roc/ IRD 2008] Ho amato i Giant Sand di un amore sciocco, incondizionato e adolescenziale, il tipo d'amore che si può riservare a chi è capace di rileggere uno dei capisaldi della tua educazione alla musica - il patrimonio delle radici americane - attraverso un'ottica talmente personale da farti sentire assoluto protagonista del tuo tempo e del suo erratico divenire. Mi era però sembrato che la band, in anni recenti, fosse più o meno diventato un prolungamento difficilmente decifrabile delle ossessioni e dei mutevoli umori del leader Howe Gelb: in concomitanza con l'amichevole allontanamento dei Calexico, i Giant Sand, così come i dischi solisti di Gelb licenziati a seguito di un lavoro folle, struggente e geniale quale Hisser (1998), avevano finito col tramutarsi in una pubblica seduta di terapia costellata di opere inevitabilmente oscillanti tra la curiosità effimera e la mediocrità conclamata. Questo perchè a partire dall'ultimo capolavoro del gruppo - l'imperdibile Glum del '94 - ad aver preso il sopravvento era stata la logorrea di Gelb; una verbosità sempre interessante, certo, e talmente storta e lunare da conquistargli più di prima i favori della stampa indie, eppure spesso parimenti sconfortante nella propria penuria di grandi canzoni e punti di riferimento tradizionali. Piace quindi trovarsi a constatare, in un misto di sorpresa e gratitudine, che Provisions è l'album più "classico" realizzato dai nuovi Giant Sand di Howe Gelb da parecchio tempo a questa parte. Non sarà nuovo, non sarà inaudito né troppo progressista, perlomeno non quanto ci si poteva aspettare rispetto all'ultima decade di carriera del gruppo, ma suona lo stesso maledettamente solido, rotondo ed ispirato, soprattutto nello sgocciolare di pianoforte della toccante Spiral o nel visionario impasto di slide e chitarre steel che contrassegna l'incedere inquieto di Pitch & Sway. Se le tastiere sono come di consueto affidate al solo Gelb, stavolta ad arricchire i dettagli dell'ordito sonoro ci sono tre danesi consapevoli del fatto loro, ovvero Anders Pedersen (sei corde), Peter Dombernowsy (tamburi) e Thoger T. Lund
(basso), e il solito codazzo di amici e collaboratori che va dalla chitarra sbuffante di M. Ward (nel country à la Johnny Cash di Can Do) alle voci inconfondibili di Isobel Campbell (ascoltate il rosario di talkin' e paesaggi cooderiani dell'iniziale Stranded Pearl) o Neko Case (controcanto perfetto nel country-rock da manuale di Without A Word). I fan dell'ultim'ora potrebbero lamentarsi del fatto che sì, le allusioni stilistiche di Provisions sono in genere assai prevedibili: un po' di allucinato Neil Young di qua (Belly Full Of Fire, Muck Machine), country stravolto di là (The Deseperate Kingdom Of Love), Lou Reed in sbornia rootsy nel mezzo (World's End State Park, Out There), senza dimenticare botte psichedeliche, rock'n'roll in libertà (la stupenda Well Enough Alone), accelerazioni improvvise e code dissonanti assortite. Ma chi apprezza i brani destinati a durare si faccia avanti: questo è un album da ascoltare a lungo. Bentornati. (Gianfranco Callieri)
LLuucciinnddaa WWiilllliiaammss Little Honey [Lost Highway 2008] Pronti…partenza…via! Riff...batteria…hey, il basso! Dov'è il basso?... Stop!... ok, ripartiamo subito… di nuovo riff… batteria… basso… partiti!... vai Lucinda, tocca a te: "ho trovato l'amore che cercavo stando dietro una chitarra elettrica, è un amore vero, è un amore vero"…ecc...ecc... Ecco, questa è la cronaca del primo minuto di Little Honey, e basterebbe per parlarne per pagine e pagine. Lucinda Williams è tornata, e anche in fretta stavolta, con l'urgenza di dire poche e semplici cose: che sta bene, che ha smesso di rimuginare sulle proprie sofferenze e, soprattutto, che ha voglia di suonare tanto rock. Un messaggio chiaro da quei primi versi di Real Love, dove la soluzione di tutto era sempre stata lì, dietro una chitarra. Ma si poteva iniziare benissimo dalla fine del disco per ricevere la stessa comunicazione, dalla cover di It's A Long Way To The Top, un titolo che nel 1975 per gli allora esordienti AC/DC suonava come una speranza (poi avveratasi) di poter suonare rock and roll per una vita, ma che oggi appare quanto mai autobiografico anche per lei, che

al top, libera di fare rock and roll, ci è arrivata davvero dopo una lunga strada. Se era apparso palese che West le fosse servito soprattutto a svuotare l'anima da tutte le disperazioni, Little Honey arriva per riempirla di nuovo con il campionario d'ordinanza di una musicista rootsy: tanto country sempre (Well, Well, Well tira in ballo addirittura Charlie Louvin), ma anche molto blues (Heaven Blues), gospel (la lunga Rarity) e persino soul (Tears Of Joy è una sorta di country-soul, la suadente Knowing sciorina una inaspettata sezione fiati). Stili, idee, suoni prima ancora che canzoni, è questa la grande novità portata da Little Honey nella carriera di Lucinda Williams, un disco nato per essere suonato prima ancora che ascoltato, dove la chitarra di Doug Pettibone è libera di essere protagonista indiscussa e di toglierle spazio in Honey Bee, e la sezione ritmica David Sutton e Butch Norton pompa ritmo pestando selvaggiamente come sul palco. Ed è anche il suo primo disco auto-celebrativo, evidente in quell' omaggiare la sé stessa che fu recuperando schegge impazzite perse nel tempo (la strascicata Circles and X's è del 1985), oppure lasciando che un mostro sacro come Elvis Costello incasini la melodia di Jailhouse Tears per glorificare la propria ammissione nel gotha del rock che conta. E in questo turbine di esercizi di stile, persino le sue tipiche ballate struggenti (Little Rock Star, If Wishes Were Horses e l'acustica e bellissima Plan To Marry) acquisiscono una insolita leggerezza. Little Honey non sarà mai ricordato come uno dei suoi dischi più rappresentativi, non ha lo spessore dei suoi predecessori e ne conserva persino alcuni difetti (ad esempio l'eccessiva prolissità), ma è il disco dove per la prima volta Lucinda non si atteggia a fare la rocker vissuta e non ostenta più le proprie cicatrici, ma fa semplicemente la rock-singer. E un disco così non serviva solo a lei. (Nicola Gervasini)
GGaannddaallff MMuurrpphhyy && tthhee SSllaammbboovviiaann
CCiirrccuuss ooff DDrreeaammss The Great Unravel [High Noon 2008] “I fantasmi dell'Americana si sono radunati tutti qui, per sognare insieme e nel sogno trovare un modo di riportare in auge la speranza che un tempo era parte di noi." Joziah Longo - voce, chitarra, armonica e songwriter dei Gandalf Murphy & The Slambovian Circus Of Dreams, nome giocoso di una band che merita d'essere presa molto sul serio - non me ne vorrà se per avviare questo commento ho preso licenza d'adottare le prime battute di Desire, brano d'apertura di The Great Unravel, un disco in cui il sogno gioca un ruolo importante: sogno di speranza, sogno di amore e fratellanza, temi di cui sono impregnati i testi, sogno di un mondo senza preconcetti dove - come nel ritornello della title track - Longo ci invita a preparare la mente al viaggio, a lasciare spazio al grande dipanamento; unravel è dipanamento della matassa ma anche uscire dall'intrico, svelare l'inganno dell'America d'oggi per tornare a Slambovia, terra di realtà e fantasia - magica come un romanzo di Mark Helprin - nella valle del fiume Hudson, regione al cui folklore la band - che vive a Sleepy Hollow nello stato di New York - in quasi dieci anni di attività si è ispirata più volte. I testi di Joziah - uno dei migliori songwriters in circolazione a detta di qualcuno che se ne intende come Garth Hudson della Band, ma tra gli estimatori si contano artisti eterogenei quali Neil Young e Rufus Wainwright – auspicano un'America che rinnovi i suoi valori ricuperando il senso di comunità, di appartenenza, invocano un ritorno alle origini della società statunitense - The Great Unravel di cui sopra - invece la musica del suo Circus è matassa intricata e di arduo dipanamento perché se è vero che i fantasmi dell'Americana sono presenti in gran numero (da Hank Williams, Dylan e la Band passando per Petty, Grateful Dead e CSNY) è altresì vero che la paletta musicale non si esaurisce qui e certo risalta un forte elemento psichedelico (Pink Floyd ma anche Incredible String Band) e forse la definizione migliore dei Gandalf Murphy l'ha già trovata qualcun

altro quando ha detto: se Dylan fosse stato uno dei Pink Floyd. La citata Desire s'avvia con la voce di Longo discretamente seguita dalla fisarmonica di sua moglie Tink Lloyd (non solo fisa ma anche violoncello, theremin e glockenspiel) e il desiderio è che si torni alla "terra di latte e miele, terra dove non si ha paura, costruita sull'amore e non sui soldi, terra aperta a tutti". L'album non ha riempitivi, i dodici brani alternano ballate mai banali sia nella struttura ritmica che nell'arrangiamento a canzoni dove spiccano gli umori psichedelici della band (Summer's Day, Clear Channel e l'eccellente title track) in cui brilla il lavoro di Sharkey McEwen alla chitarra (elettrica, slide e acustica nonché mandolino e piano) mentre il tutto è sostenuto dalla sezione ritmica di Chen Longo - figlio di Joziah - al basso e Tony Zuzulo che oltre ai tamburi provvede agli effetti sonori. Quattro anni fa il Circus aveva stupito con Flapjacks From The Sky - album immenso per ambizione e riuscita - The Great Unravel, terzo capitolo di questa storia, è lavoro più compatto ma d'identico spessore: una bella conferma meritevole d'uscire dai confini del New England dove sono popolarissimi anche grazie alle loro celebrate esibizioni dal vivo. (Maurizio Di Marino)
EElleevveenn HHuunnddrreedd SSpprriinnggss Country Jam [Palo Duro 2008] Il barattolo di Country Jam degli Eleven Hundred Springs è fatto rigorosamente in casa e soprattutto porta il marchio del Texas, non ci si può sbagliare dunque sulla sua denominazione di origine controllata. Oltre tutto, a garantirne la qualità, c'è la produzione del maestro Lloyd Maines. Un mix irresistibile per gli appasonati del genere che prevede contaminazioni fra western swing, honky tonk, rockabilly e suono outlaw, lo stesso portato in auge in questi decenni da gente quale Dwight Yoakam o Derailers, i nomi più affini che mi sono saltati alla mente al primo ascolto di Country Jam. Soprattutto dei secondi, che guarda caso incidono per la stessa scuderia della Palo Duro, gli Eleven Hundred Springs sembrano portare avanti il testimone, dosando tecnica e preparazione
storica, suonando vintage e credibili per chiunque pensi che la country music non sia una sigla da tirare per la giacchetta e stravolgere a piacimento. Quindi possiamo dormire sonni tranquilli: la musica di Matt Hillyer (voce e chitarre) e Steve Berg (contrabasso), i due fondatori della band nel lontano 1998, è quanto di più fedele si possa ascoltare oggi nel campo del più puro "conservatorismo" country, visto che l'accordion che apre la border song Texas Afternoon, l'arrembante hillbilly rock (come l'avrebbe chiamato Marty Stuart, un altro punto di riferimento) di Every Time I Get Close to You e l'honky tonk di Whose Heart Are You Breaking Tonight sono una bella presa di posizione. Gli Eleven Hundred Springs non si vergognano di apparire fuori moda, anzi danno proprio l'impresione di voler salvaguardare la specie da presunti cowboy "nashvilliani" che dal genere hanno preso in prestito solo i vestiti e i cappellacci (non fate troppo caso però alla foto sul retro, che li vede banchettare allegramente con cibo ad alto rischio di infarto). Loro ci credono ancora e grazie alla steel di Danny Crelin, bravissimo, al fiddle di Jordan W. Hendrix e alla batteria di Nark Reznicek (nel frattempo rimpiazzato da Brian Ferguson) imbastiscono una Grand Ole Orpy in miniatura che fa scorrere quaranta minuti di rievocazione country in grande stile. Nove i brani originali, ma fareste fatica a distinguerli dai ripescaggi passati: giusto l'immortale Don't Stop the Music (George Jones, e chi altrimenti?) non può passare inosservata, mentre il western boogie di V-8 Ford Boogie e l'old fashioned Rocket 88 (con il sax di Robert Lockard) mi hanno riportato alla giovialità dei primi lavori di Joe Ely. Veniamo ricondotti nel più puro revival delle Texas Dancehalls e dello stile honky tonk (Fallin' off the Wagon, Ten to Life, la seconda che zompetta come il migliore Johnny Cash periodo Sun), senza dimenticarsi di omaggiare i "ribelli" dei '70, tra cui spicca il lascito di Waylong Jennings (impossibile non notarlo in I Never Crossed Your Mind e You Can't Hide from Your Heart). Nominati come best band, best album, best country/roots act e best male vocalist ai tradizionali Dallas Observer Music Awards di quest'anno, gli Eleven Hundred Springs potrebbero essere il vostro piatto preferito sul menù country di stagione. (Davide Albini)

JJJJ GGrreeyy && MMooffrroo Orange Blossoms [Alligator/ IRD 2008] Il dado l'aveva tratto con l'ottimo Country Ghetto dell'anno scorso, ma la marcia di JJ Grey trova in Orange Blossom un'altra decisiva milestone. Un viaggio nato con due dischi intitolati ad un unico ensamble (Blackwater e Lochloosa, usciti a nome Mofro), ma proseguito con quel singolo nome messo prima di quello del gruppo, quasi a voler diventare protagonista indiscusso, nonostante Orange Blossom tradisca la persistenza di una vera e propria band. E il trip, che agli esordi era nato dal mondo delle jam-bands e della nuova psichedelica americana, riparte da dove si era fermato con il disco precedente, dal sud, dalle paludi della Florida e dal riff alla Fogerty della title-track che apre il disco. Gli sviluppi però abbandonano la campagna e il mondo dei bianchi che ascoltano musica nera, per buttarsi direttamente nel ghetto, quello vero stavolta, quello di città. Queste dodici canzoni trasudano funky e soul dai pori di una sezione fiati imponente, onnipresente e persino sovrastante, o dalle tastiere sempre più rivolte al soul del meraviglioso Adam Scone, e nella stessa voce di Grey, usata sempre più su tonalità basse. Sono brani che cercano il ritmo urbano attraverso il secco e preciso drumming di Anthony Cole, sia quando si gira sui ritmi vertiginosi di Ybor City, sia quando ci si butta nei deliziosi uptown-soul She Don't Know e The Truth. Il gioco dei rimandi e delle citazioni potrebbe continuare all'infinito in un disco del genere, ma quella dei JJ Grey & Mofro non è una semplice derivazione, né tanto meno una mera imitazione, ma una ricerca che approda ad un risultato che è solo loro, e porta un marchio di fabbrica riconoscibilissimo. Questo è il primo grande obiettivo raggiunto da Orange Blossom, un cd che cementa su sfondo nero la definitiva maturazione di un nome che può essere a questo punto citato come uno dei capostipiti di una nuova rifondazione del soul-rock bianco, nobile tradizione che non trovava una band così rappresentativa dai tempi della Average White Band o dei Rare Earth. I ragazzi hanno evidentemente consumato vinili di black-music anni '70 in dosi massicce per
pensare di poter proporre nel 2008 il jookhouse funk di On Fire, di lasciarsi andare alle improvvisazioni alla Parliament di Move It On, o di cullarci con il front-porch-soul finale di I Believe (In Everything). O ancor più pescando Everything Good Is Bad, un brano dei 100 Proof (Aged in Soul), un trio che visse solo lo spazio di tre misconosciuti album, scoperti alla fine degli anni '60 dal fiuto marketing del team di produttori Holland-Dozier-Holland. Rispetto a Country Ghetto, Grey si è concentrato meno sulla scrittura e più sugli sviluppi stilistici, se è vero che qui tutto sa un po' di calcomania del mondo Stax e Motown in chiave southern, ma nonostante una indiscutibile sudditanza di ispirazione, Orange Blossom porta nelle nostre case la perfezione di un suono che non vorremmo mai perdere. (Nicola Gervasini)
RRiicchhiiee HHaavveennss Nobody Left to Crown [Verve Forecast 2008] Se tanto mi da tanto, Richie Havens avrebbe potuto tranquillamente vivere di rendita, dopo quel grido liberatorio di Freedom improvvisato sulle note di Motherless Child che aprì ufficialmente le danze del festival di Woodstock, lontano ormai quasi quarant'anni. Non lo ha fatto, anche se certamente le classifiche non hanno contribuito a rendere giustizia a questa voce rubata al soul e assunta dal folk a tempo indeterminato. Un mito, in un certo senso, un artista e un uomo che ha sempre lottato per i diritti dei più deboli, strapazzando la chitarra e prestando i suoi versi a beneficio di una protesta universale, per questo senza tempo. Nativo di Brooklyn e cresciuto tra i sospiri del Greenwich Village, Havens non è mai sceso a compromessi. Nobody Left To Crown, titolo emblematico, segna il suo ritorno alla mitica Verve Forecast per la quale incise Mixed Bag nel 1967 e Something Else Again l'anno successivo, due tra i suoi migliori album di sempre. Segue i già buoni Wishing Well e Grace Of The Sun, entrambi usciti nel nuovo millennio, ma possiede qualcosa in più. Lo stile è quello che gli conosciamo, chitarra sporca e voce che non mostra segni di stanchezza nonostante i suoi quasi settant'anni, una manciata di buone canzoni, alcune ottime, divise tra nuovi brani

usciti dalla sua penna e cover di tutto rispetto. Lo aiutano musicisti rodati e affidabili come Walter Parks (chitarra), la bravissima Stephanie Winters (violoncello), Keith Christopher (basso) e Shawn Pelton (batteria). Molto belle le ballate, tipiche del suo repertorio più classico, dall'iniziale The Key, un folk-rock dalla linea melodica che respira l'aria dei giovani arrabbiati del tempo che fu, fino a We All Know Now, un superbo ritratto di quell'imprinting sociale che purtroppo oggi la musica ha perso. Nelle liriche affiora un impulso comunicativo ancora intenso, che se riverbera echi politici un po' in controluce affonda le sue ragioni nelle difficoltà del vivere, frutto innanzitutto di una cattiva gestione del bene comune. Così If I e la title track, che sembra camminare tra le strade di Woodstock alla fine di un pomeriggio autunnale, invitandoci a riflettere, mentre l'istinto soul sprigiona tutta la sua energia nell'interessante (Can't You Hear) Zeus's Anger Roar, che tracima inclinazioni gospel adatte allo scopo. Fates è invece un blues interessante, come azzeccatissima è la cover di un brano degli Who, Won't Get Fooled Again, un rock blues raccontato con il cuore. Tra gli altri prestiti sono da segnalare The Great Mandala (The Wheel Of Life), tratta dal repertorio di Peter, Paul & Mary, Lives In The Balance di Jackson Browne (già ripresa, tra l'altro, in un suo precedente album) e One More Day, una bellissima ballata interpretata da Sinead O'Connor all'interno della colonna sonora del film "Veronica Guerin". Non male infine Standing On The Water, un soul-blues di Andy Fairweather Low, e Hurricane Waters dei Citizen Cope, con echi seventies e un passo leggermente ipnotico. (David Nieri)
TThhee BBllaacckk AAnnggeellss Directions to See a Ghost [Light in the Attic/Goodfellas 2008] Monolite impenetrabile e nerissimo questo Directions to see a Ghost dei texani Black Angels, banda neo-psichedelica che sembra rinnovare i fasti di una tradizione locale ormai divenuta mitologia del rock'n'roll, inevitabilmente richiamando a sè come numi tutelari i 13th Floor Elevators di Rocky Erickson. Nel frattempo però sono trascorsi quarant'anni di follie e sperimentazioni con il lato più onirico di questa musica e sarebbe quindi riduttivo
proporre la semplice equazione appena annunciata. Il sestetto dei Black Angels, da Austin TX., riparte dalle visioni cosmiche del passato per filtrarle attraverso quintali di feedback e movenze dark che sono semmai figlie della stagione post punk, di certo Paisley Underground ad esempio, ma soprattutto della sponda inglese incarnata dai Jesus & Mary Chain o ancora meglio dagli Spaceman 3. Con questa girandola di nomi abbiamo stretto forse un cappio intorno al collo di una band che in verità si balocca con le sue influenze evocando tutti e nessuno, avendo la faccia tosta di spiattellare settanta minuti di roboanti cavalcate lisergiche che si avviluppano su se stesse, implodendo ed esplodendo a seconda dei casi. Directions to See a Ghost, secondo capitolo dopo l'esordio del 2006 Passover, promette quanto dichiara nel titolo stesso, infilandosi in una fitta boscaglia dove i riff ossessivi delle chitarre (Christian Bland e Nate Ryan) si imbrattano con il muro degli organi (lo stesso Alex Maas, anche voce principale, basso e sitar) e soprattutto la primitiva insistente presenza dei tamburi di Stephanie Bailey. L'effetto è straniante, angoscioso, ma una volta entrati nelle spirali della torbida You on The Run si rimane conquistati dall'onda sonora creata dalla band. Due principalmente i poli opposti dei Black Angels: le cadenze lente e magnetiche di brani quali Scienze Killer, Vikings e The Return da una parte, le fughe e gli stridori elettrici delle angoscianti Mission District e Never/Ever dall'altra, con l'eccezione di una Doves che potrebbe persino definirsi il loro momento pop, in senso lato si intende. È peraltro la sorprendente, già citata, Never/Ever ad imporsi come il manifesto dell'intero lavoro, con quel suo cambio di marcia e quelle intersezioni fuori moda fra chitarre, sitar e organo, in una scintillante coda finale che pare inghiottire in un solo boccone Velvet Underground (il nome della band deriva da una loro canzone, Black Angel's Death Song), Doors e i citati 13th Floor Elevators. Non le sono da meno tuttavia Deer-Ree-Shee, forse la più infatuata dai colori della stagione del flower power e You in Color. Prese in blocco concorrono a formare la spessa coltre che avvolge l'ascolto di Directions to See a Ghost: e d'altronde sarebbero sufficienti i sedici interminabili minuti della conclusiva Snake in the Grass per tracciare le linee del loro universo: ritmica tribale, un lancinante rumore di fondo, chitarre che viaggiano al contrario, una voce che mormora da una caverna, ripetendo un mantra da ipnosi. (Fabio Cerbone)

LLaasstt MMaann SSttaannddiinngg False Starts & Broken Promises [Wildflower/ Audioglobe 2008] Nel 2007 un disco indipendente esce seguendo i canali distributivi che portano ai soliti pochi intimi, ma un anno più tardi finisce per essere ristampato e ridistribuito sulla scorta di un passaparola convinto e costante. E' una storia che sta cominciando a diventare usuale, ma potremmo definirla come una moderna garanzia di qualità nel mare magnum delle pubblicazioni di questi anni. La stampa specializzata d'oltremanica (ma anche quella americana) ha passato l'estate a tessere elogi per questo False Starts and Broken Promises dei Last Man Standing, una band che, a dispetto del nome, più che ad un immaginario da film di Walter Hill, sembra uscire da un sogno felliniano. La loro particolarità è quella di essere un collettivo di nove musicisti che gira intorno alla carismatica figura di Max Vanderwolf, un'accolita di zingari che viaggia con un circo itinerante dove è possibile ammirare non la donna barbuta o l'uomo più alto del mondo, ma bensì il "fallimento umano" o la "paura di sé stessi". Siamo alla metafisica dell'estetica circense, un Grand Guignol dell'umanità dove Max sguazza con grandi doti da imbonitore. Lui stesso descrive la sua musica come una "colonna sonora della rovina umana", e le canzoni che compongono questo esordio sono una galleria di miserie e debolezze, gettate come freaks da deridere in pasto al pubblico pagante. Quello che più ci interessa notare è che False Starts and Broken Promises è un disco davvero intrigante, un concept d'altri tempi modernizzato con intelligenza e con anche qualche canzone memorabile (Everything Must Go o The Climb ad esempio). Vanderwolf gioca molto sul mix tra vecchio e moderno, passa dalle spigolature alla White Stripes di Queen Kong e Bar Room Floor ad un brano come Waiting So Long, che sa di Bowie a caccia di ragni di marte fino al midollo. Oppure si dimostra pienamente conscio delle regole delle migliori opere del rock britannico, inventandosi un tema portante con cui aprire e chiudere il disco, e concedendosi lo scoppiettante finale di quasi otto minuti di Go Home, tra assoli di chitarre acide, suoni tronfi e imponenti, e un coro finale che fa tanto Tommy degli Who. I Last Man Standing non si fanno proprio
mancare nulla in questi 43 minuti: fiati, archi, percussioni, riff da rock anni settanta, sax suadenti, chitarre flamenco, intermezzi di samba. C'è da rimanere storditi ai primi ascolti, ma alla fine il tutto sembra quadrare, nonostante uno sguardo più severo potrebbe trovare più di una incongruenza e ingenuità. Ma la naiveté del progetto deve essere letta come un punto di forza, così come i mille rimandi ad altre esperienze del rock devono essere apprezzati come la realizzazione di una sorta di Vaudeville del 2000, e non visti come una mancanza di personalità o originalità. Anche perché Vanderwolf ha tutta l'aria di chi necessita di caos e disperazione per tirare fuori il meglio di sé…la maturità potrebbe anche fargli male. (Nicola Gervasini)
BBuuffffaalloo KKiilllleerrss Let It Ride [Alive/ Goodfellas 2008] Il suono bastardo dei Buffalo Killers se ne frega del manierismo e se ne esce come un disco anni settanta, power-trio con due fratelli per il basso e la chitarra, quasi fossimo tra i Cream e l'Allman Brothers Band, deviando per i Black Crowes (forse il gruppo a cui somigliano di più). Non tiriamo in ballo i giovani Kings of Leon nel nostro gioco di rimandi, che di quelli questo sound è ormai un ricordo fermo al solo primo album. I Buffalo Killers invece, al secondo di tal fatta almeno ci sono arrivati. Loro sono i Gabbard bros., Andrew alla sei corde e Zachary con quattro, J. Saabali alla batteria per un cd più idoneo ad ascoltarsi su vinile, tant'è che un'edizione limitata dello stesso se ne viene fuori in lp, espansa di un concerto, bonus tracks di una serata all'Orpheum Theatre di Los Angeles. E allora Let it Ride si lascia correre davvero, con quello stile elettrico e pastoso, sporcato di una voce annegata in vortici di psichedelia, comprensibile fin dalla copertina dei ragazzi un po' barbuti, tardo-capelloni che giocano al rock'n'roll. Sia pur questa la filosofia di Dan Auerbach dei Black Keys, che ha prodotto l'album grondante di "sudismi", matrice hard-blues di certo qual rock dannatamente datato. Ma che piace ancor sentire, quasi fossero gli Zeppelin senza ancora avere un nome, o una qualsiasi garage-band destinata alla rivoluzione. I Buffalo Killers

entrano in campo così, con quell'aria da "quasi famosi" ad aprire i concerti degli stessi Black Crowes o Black Keys, ma quanto mai apprezzabili in tutta la loro veste di "non arrivati". Sfoderano grumi d'overdrive impaludati in Get Together Now Today o nella title - track, dove la chitarra "barrisce" letteralmente alla maniera di Slow-hand su di un impasto bi-vocale tendente al falsetto: Let It Ride è emblematico dei riferimenti del gruppo, e potente; If I Get Myself Anywhere corre dietro alla batteria come un rock'n'roll visionario e lisergico; It's a Shame sta tra Politician e Born Under a Bad Sign come le nuvole tra il sole e la terra. Ma non dimentichiamo neppure i paesaggi folkie cristallizzati nei richiami acustici di Give And Give o Heart In Your Hand come facevano i Led Zeppelin di Over The Hills And Far Away o dell'altrettanto consacrata Misty Mountain Hop. I Buffalo Killers hanno assimilato quella lezione, e quando l'ultima Black Paper svela persino dei cenni grunge che finora avevamo solo supposto, ci accorgiamo che, quando non sono annacquate, le ceneri del mito fumano ancora. (Matteo Fratti)
TThhee AAccoorrnn Glory Hope Mountain [Bella Union/ Self 2008] Dal gelido Ontario, ecco un disco ideale per scaldare il cuore nei piovosi pomeriggi dell'autunno che verrà. Gli Acorn sono un quintetto che ruota attorno alla carismatica figura di Rolf Klausener, mezzo sangue honduregno, innamorato tanto del folk americano quanto delle sue radici sudamericane. Dopo una manciata di ep che hanno attirato l'attenzione dell'universo indie e costruito un buon seguito in Canada e in Nord America, gli Acorn arrivano al debutto ''lungo'' grazie alla Paper Bag. Glory Hope Mountain è anzitutto un concept album, come si usava (stra)fare negli anni settanta, dedicato alla tormentata vicenda della madre di Klausener, Gloria Esperanza Montoya; di cui appunto il titolo è una primitiva traduzione. Un disco, dunque, che se nelle liriche segue una sua personalissima strada, cioè quella di raccontare la difficile esistenza della madre del leader, altrettanto fa nella musica. Lo fa mescolando gli idiomi del folk psichedelico dei tardi sessanta ai
dialetti moderni e imbastardendo il tutto con spezie dal sapore orientale e africano. Motivo per cui Glory Hope Mountain appare un disco eterogeno solo nei dettagli, presentendo altresì un "corpus" di dodici canzoni che scorrono l'una dentro l'altra senza soluzione di continuità. L'apertura è affidata a una simbolica Hold Your Breath, in cui la voce tenorile di Klausener soffia su un tappeto di chitarre acustiche e percussioni. Un equlibrio cristallino sembra regnare per tutta la canzone a testimoniare la volontà di rendere ogni momento del disco un quadro compiuto in sé e, al tempo stesso, un elemento di un affresco più grande; appunto il ritratto della vita di Gloria Esperanza Montoya. Flood, la seconda traccia, riprende laddove Hold Your Breath ci aveva lasciato: in quel terreno per niente ostile dove pascolano band come Iron and Wine, Animal Collective, Wilco e Decemberist (giusto per restare nei tempi moderni). Il rischio è quello di ripetersi e, alla lunga, di stancare. Ma gli Acorn mettono nel conto il loro possibile limite e si affidano alla fantasia disseminando il campo di piccole mine sonore. Succede già al terzo episodio, Even While You're Sleeping, dove una chitarra distorta si insinua nel mezzo di una litania dal sapore orientale a rendere il tutto ancor più magico. Il gioco funziona e il gruppo va avanti senza più alcun timore procedendo tavolta per sottrazione (Glory, Oh Napoleon) e altre volte per saturazione (Antenna), giungendo al termine di un disco che, giustamente, negli States ha già accesso le fantasie di molti. Se gente come Fleet Foxes o My Morning Jacket ha già conquistato la prima pagina, non si capisce perché ciò non dovrebbe accade prima o poi con gli Acorn ai quali manca senza dubbio un po' di "hype", ma non certo le idee e i sentimenti. L'unico vero limite degli Acorn, casomai, sta nel non lasciarsi mai andare del tutto. Ascoltare Glory Hope Mountain tutto di fila è una bella esperienza, ma alla fine resta un po' d'amaro in bocca a pensare di cosa sarebero capaci questi canadesi se dimenticassero un po' di indie e un po' di pop e si buttassero a corpo morto sul folk e, soprattutto, la psichedelia. (Francesco Meucci)

DDaavviidd VVaannddeerrvveellddee Waiting for the Sunrise [Secretly Canadian 2008] Capitava spesso, ai tempi in cui le grandi catene multinazionali non spadroneggiavano ancora soffocando i piccoli distributori, di entrare in un negozio e di venire affascinati dalle note di un disco mai sentito prima. Questa "illuminazione improvvisa" spesso e volentieri portava all'acquisto immediato, a scatola chiusa, del disco in questione e dava luogo ad una doppia soddisfazione: in primo luogo per la sua qualità musicale, in secondo luogo per l'imprevedibilità della propria scoperta. Per fortuna, ogni tanto, questa magica esperienza capita ancora. Nella fattispecie, è stata un'atmosfera molto Younghiana, con una bella coda di chitarre elettriche che ricorda di molto le cavalcate del loner canadese, ad attirare le attenzioni di chi scrive. La canzone si chiama Lyin' in Bed, ed il disco in questione è Waiting for the Sunrise di David Vandervelde. Di questo cantautore-polistrumentista ci eravamo già occupati in passato, quantunque né l'esordio The Moonstation House Band né, soprattutto, l'apparizione (molto attiva, per altro) in This Magnificent Defeat di Jay Bennett fossero particolarmente memorabili. Con questo secondo lavoro solista, però, David, originario di Nashville, compie un balzo in avanti decisamente notevole. E' un disco pop questo Waiting for the Sunrise ma, signori, ce ne fossero di dischi pop così! La produzione è affidata all'ex Wilco Jay Bennett che distilla intelligentemente i suoni, avvolgendo le canzoni con morbide atmosfere seventies e spargendo pizzichi di psichedelia a rendere più sapido il tutto. Il resto lo fanno la voce e le canzoni di Vandervelde. Le canzoni, appunto, sono il punto di forza di questo album: immediate, fresche e semplici senza per questo essere banali. L'aria che si respira lungo tutte le dieci tracce è rilassata e talvolta rimanda, anche nello stesso brano, al sole della California ed alla pioggia di Liverpool (da leggersi Beatles, ovviamente), come in Old Turns, ricca ballata in cui riecheggiano allo stesso tempo sia John Lennon che i Beach Boys. Altrove, come già detto, è l'ombra di Neil Young a vagare nascosta fra le note: sia lo Young balladeer (Need for Now) sia il cavaliere elettrico (la Lyin' in bed di cui sopra,
decisamente il brano più rock di tutto il disco). Tutte le canzoni, comunque, a partire da California Breeze, che sembra un singolo di altri tempi, alla breve title track posta in chiusura, andrebbero ricordate per la loro brillantezza ed immediatezza. A volte malinconiche, a volte serene come un tramonto autunnale, rivestite come sono di chitarre acustiche, organo hammond e pianoforte elettrico, le tracce di questo Waiting for the Sunrise brillano di una luce intensa e particolare. La luce di chi crede ancora che in una canzone pop si possano mettere in musica espressioni che toccano l'intera gamma dei sentimenti umani. Magari Waitin' for the Sunrise non riuscirà a risolvere quel guazzabuglio che è la vita ma, se avrete bisogno di un momento di ristoro bè, qui lo potrete trovare, eccome. (Gabriele Gatto)
MMaannddoolliinn’’ BBrrootthheerrss Still Got Dreams [Studiottanta/ Fortuna 2008] In (quasi) trent'anni di carriera, i Mandolin' Brothers hanno collezionato sì e no un paio di dischi e non perché non sappiamo cosa dire o come fare, ma perché si tratta di veri music lovers per cui suonare è un'arte e una via di fuga nello stesso tempo, per cui se va fatta, bisogna farla bene. La bellezza di Still Got Dreams si spiega così: con la cura artigianale e certosina dei suoni, più naturali dell'aria della pianura, e con un gusto che arriva da sterminate collezioni di dischi (in vinile, va da sé) e da una rinnovata curiosità. Non c'è solo rock'n'roll in Still Got Dreams, c'è anche il Vietnam e la guerra di Saigon direttamente dall'incubo di Apocalypse Now, con tanto di citazione (ormai classica) dal film di Francis Ford Coppola e gioca sulla confusione tra un Delta (quello del Mississippi, che ispira il sound) e l'altro (quello del Mekong) che è alla base della canzone. Prima sorpresa del disco, che viene seguita dalla fisarmonica (molto europea) che apre la dedica dylaniana (non l'unica, a dire la verità: bisogna associargli almeno Nothing You Can Do) di Went To See The Poet. Anche qui i Mandolin' Brothers giocano a mischiare le carte in tavola aggiungendo alla fisarmonica una squillante chitarra acustica. L'intreccio tra le passioni americane (tutte dichiarate senza alcuna remora) e gli arrangiamenti spostati

verso l'Europa (ancora la fisarmonica nella toccante Carton Box) è la vera novità nella lunga carriera dei Mandolin' Brothers ed è anche una nota originale, e molto personale, capace di proiettarli verso ipotesi e orizzonti fin qui inaspettati. E' altrettanto vero che chiudono il disco citando spudoratamente Bo Diddley (è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare) in I'm Ready, ma il nocciolo di Still Got Dreams sembra di capire va cercato tra Faded Photos, Scarlet, The Promise o Insane (con i
suoi cori da favola) dove i Mandolin' Brothers vanno ben oltre le proprie radici che, come è noto, affondano nel blues e nel rock'n'roll e sono innaffiate da torrenti di birra ad ogni cambio di stagione. Consigliatissimo, anche perché i loro avvocati si chiamano Zimmerman e Ginsberg, gente che sa come si difendono i sogni da quella brutta roba che è la realtà. (Marco Denti)

CCllaassssiiccHHiigghhwwaayy tracce dal passato: la ristampa
RRooddrriigguueezz Cold Fact [Light in the Attic/ Goodfellas 2008] Questo ragazzo messicano, figlio di Maria e Ramon, immigrati messicani nella Detroit operaia del dopoguerra, appartiene di diritto alla categoria dei reietti, destinati ad una "sconfitta di culto", al ruolo scomodo di inafferrabile e misterioso musicista di cui tramandare le gesta confuse dal tempo. Cold Fact ritrova infatti un posto al sole grazie a questa curatissima ristampa della Light in the Attic, che dedica al songwriter di origini chicane una lodevole confezione cartonata con lunghi essay firmati da Kevin Howes e Stephen Segerman sulla vita del protagonista, note interne dei musicisti coinvolti nel progetto e tutti i testi acclusi. È una vaso di Pandora che regala davvero, senza paura di sembrare retorici e sin troppo indulgenti, il piacere di una riscoperta inattesa, fianco a fianco con una manciata di ballate stralunate, naif, un folk rock che si tinge di giocosa psichedelia e piccole trovate produttive, mai fuori misura rispetto all'essenza stessa del songwriting di Sixto Rodriguez. Il quale resta un menestrello impacciato e dall'anima freak, così disarmante nell'esposizione della sua musica da apparire fuori luogo e fuori tempo, capitato veramente per caso sulla scena. Così si è svolta anche la sua folle, adorabile carriera: un esordio, Cold Fact, rimasto un oggetto curioso e ignorato, un secondo capitolo ancora più incompreso (presto ristampato), eppure una fatomatica, assurda seconda possibilità ricevuta in terra australiana e poi in Sud Africa, dove l'album, seguendo un passaparola incessante, diverrà disco di platino.
Rodriguez affronterà negli anni ripetute tournè in queste terre, riempiendo palazzetti interi (nelle sortite australiane dei primi anni '80 i suoi concerti saranno aperti dai Midnight Oil) e nel frattempo restando un perfetto sconosciuto in patria. L'attrazione fatale di Cold Fact risiede sicuramente in questo strano gioco di destino e successo imprevedibile, ma oggi che lo si può ascoltare con imparzialità a quarant'anni quasi dalla sua concezione (fu registrato nel '69 nella stessa Detroit) andrebbe rimessa al centro la sua portata artistica, niente affatto marginale. Rodriguez ne esce infatti rinsaldato nel ruolo di folksinger
smarrito fra le turbolenze e le tensioni sociali di quell'epoca: ruba il talkin' blues a Bob Dylan e lo ribalta secondo una sua personale visione, la stessa che sembra accomunarlo a personaggi "fuori sincrono" come Skip Pence o Rocky Erickson. Non tanto a livello strettamente musicale - seppure vi siano numerosi punti di contatto nella frenesia psichedelica di Only Good for Conversation e nella magia di Hate Street Dialogue - quanto nell'atteggiamento stesso di mostarsi ricettivo e travolto dai cambiamenti di un preciso momento storico. Da qui nasce un piccolo manifesto quale Sugar Man, canzone simbolo di Rodriguez che corteggia l'immaginario psichedelico della controcultura e delle droghe, inventandosi una dolcissima ballata acustica "disturbata" da fischi e "buone vibrazioni". Fautori di questi arrangiamenti che lambiscono la Detroit funk della contemporanea Motown

per affiancarla alle bizzarre fondamenta folkie di Sixto Rodriguez sono il leggendario Dennis Coffey (chitarrista, talent scout e collaboratore storico dell'etichetta regina della black music) e il produttore Mike Theodore (qui arrangiatore della parti orchestrali e della sezione fiati): dall'idea di catturare le canzoni di Rodriguez in solitaria (troppo timido, suonava spesso di spalle sia in studio che in pubblico) e poi costruirvi intorno un suono risulta un disco per nulla posticcio: la fantasia soul della splendida Crucify Your Mind, il Dylan ripassato fra lisergiche caramelle folk rock in Inner City Blues (nulla a che fare con marvin gaye, anche se...), Establishment Blues e Rich Folks Hoax, la straniante filastrocca di Gommorah (A Nursery Rhyme), l'incantevole tocco dei fiati in Forget It. Storie come quella di Sixto Rodriguez rappresentano immancabilmente l'essenza stessa di quell'avventura che ci ostiniamo a chiamare rock'n'roll, che non è fatta solo di stelle, prime donne, grandi affreschi e poderosi colossal, si sarà capito ormai, piuttosto di una immensa marea di outsider, cani sciolti, sfortunati avventori. Cold Fact sarebbe potuto diventare un classico di quegli anni "confusi" ed eccitanti a cavallo della rivoluzione magica del flower power, ne possiede la stessa ingenuità e freschezza. Così non è stato, ma si sa che gli oggetti di culto riescono a volte a diventare più immortali di qualsiasi classico riconosciuto: è la legge oscura del rock'n'roll. (Fabio Cerbone)

PPnneeuummoonniiaa boxes, tributes, live records…
TThhee PPoogguueess Just Looke Them Straight in the Eye and Say… Poguemahone!!! [Rhino box 5CD 2008] PROLOGO
Alla fine del concerto, vuoi per l'orario, vuoi per il putiferio che avevano scatenato, qualcuno ebbe la non brillante idea di togliere la corrente, senza che fosse arrivata Fiesta. In questi casi, si sa, è il pubblico a andare fuori di testa (e lo era già abbastanza), ma quello che lasciò tutti a bocca aperta è che gli stessi Pogues, uno spiritato Shane McGowan per primo, non smisero un attimo di urlare, sbracciare e spaccare quello che trovavano a portata di mano pur di riavere le luci. Anche la crew, composta da minacciosi e mastondontici roadie ad un certo punto occupò tutto il palco rendendo così chiaro il concetto che se non fosse arrivata Fiesta non ci sarebbe stato più nemmeno quel
posto, e così (infine) Fiesta fu, per sempre. Qualche anno dopo all'inizio di un altro concerto, Shane McGowan è seduto sulla pedana della batteria, beve attingendo da una damigiana e si alza per cantare (si fa per dire) solo nei ritornelli. Gli altri si guardano attoniti cercando di capire cosa sta succedendo, cosa bisogna fare. Una strofa la canta uno, un pezzo di canzone la canta un altro, la musica regge fino a un certo punto, Shane McGowan si alza ancora una volta, si avvicina al microfono, lo guarda, torna alla damigiana e non si alza più e, anzi, prima della fine del concerto è steso sul palco, ma intanto, in un modo o nell'altro, i Pogues sono andati avanti. In queste due istantanee c'è un po' tutta la storia che invece il boxset dei Pogues racconta in cinque (magici) dischi.
IL DISCO Non sono stati nemmeno capaci di sciogliersi, i Pogues, come se il gruppo vivesse di vita propria (certo, da un punto di vista artistico dopo Hell's Ditch, un gran disco ancora oggi, non è successo granché, ma questo è un altro discorso). La storia dei Pogues è quella di un gruppo che non è riuscito a considerare la parola "fine" e che ha moltiplicato i suoi sforzi, magari in modo disordinato e confuso, ma sempre molto creativo, lasciando aperte le porte agli amici e al mondo intero. Suonavano Afro-Cuban Be-Bop per dirla con Joe Strummer, fiabe di NYC dal sapore molto dickensiano, poesie di Garcia Lorca, fieste e shanties, tradizionali irlandesi, London Calling, Eve Of Destruction, I Fought The Law, insomma un universo lirico e poetico sterminatissimo. Nessuno (salvo forse i Los Lobos) dei loro coetanei ha avuto le visioni e il coraggio dei Pogues (soltanto i Waterboys nel fugace e irripetibile momento di Fisherman's Blues) che hanno generato uno stile in anticipo sui tempi che poi è diventato una vera e propria attitudine a cui non sono estranee nemmeno le Seeger Sessions di Bruce Springsteen. Stile non è proprio la parola giusta, vale (forse) il termine spirito (da non confondere con spirit, visto il tenore di

vita dei Pogues): inarrestabili, irascibili e caotici, sono stati un'esperienza folle e unica, anche per quella leggerezza, quell'allegria e quell'umiltà con cui si muovevano, come se conoscere tutta quella musica (e suonarla) e bersi una dozzina di pinte (tanto per cominciare) presentassero lo stesso grado di difficoltà, per loro prossimo allo zero. Ora, i box, le antologie e i cofanetti e le ristampe a volte riepilogano e aggiungono (spesso solo una tiratina a lucido) ma difficilmente, pur illuminando carriere parallele o nascoste, riescono a portare qualcosa di diverso. Invece i Pogues sono stati generosi e innovativi anche in questo sputando fuori in un colpo solo tutte le loro identità, comprese quelle meno conosciute e rimettendosi in un'altra prospettiva. Molto importante, perché scorrendo il centinaio di canzoni di questo cofanetto (in gran parte inedite) si scopre e si riscopre quanto i Pogues abbiano dato, ricevendo in cambio molto poco. Ecco, se mai servisse, qui si fa un po' di ordine e si rimettono i Pogues nel posto che meritano. Tra i più grandi di sempre. (Marco Denti)

BBooookksshhiigghhwwaayy i libri del trimestre
EEllmmoorree LLeeoonnaarrdd Tutti i racconti western (Einaudi, pp.676) "Mi guardai attorno, in cerca di un genere che mi consetisse di imparare a scrivere e, allo stesso tempo, di vendere quello che scrivevo". Onesto prima di tutto, ma non prendete le parole di Elmore Leonard come il segnale di una letteratura di serie b, tutt'altro: maestro indiscusso di crime fiction, noir e altri generi e sottogeneri, amato incondizionatamente da Hollywood, che ne saccheggerà spesso e volentieri il catalogo, in Tutti i racconti Western lo scrittore americano avvalora le tesi di un mondo dimenticato e "operaio", lo stesso in fondo da cui usciranno autentici outsiders come Jim Thompson, lontano dall'Accademia e a maggior ragione palestra di fuoriclasse. Trenta racconti scritti in gran parte a cavallo fra gli anni '50 e '60 e pubblicati originariamenbte dalle più importanti riviste del settore, pulp magazine ante litteram (Argosy, Dime Western, Zane Grey's Magazine fra gli altri) che rappresentano un corpo unico fatto non solo di leggenda, ma anche di minuziose descrizioni storiche, di costumi, volti, paesaggi che costituiscono il codice indispensabile per decifrare i contorni misteriosi e senza tempo del West. Arizona, New Mexico, i confini di un mondo da civilizzare in cui si muovo figure solitarie, romantiche, che si fanno mito nella polvere del deserto, fra i massicci montuosi e le piste dei pellerossa. Ci sono fuorilegge impenitenti, cercatori d'oro, sceriffi, semplici soldati spesso collocati sullo sfondo dei ricordi della Guerra di Secessione, ma soprattutto il ricorrente scontro fra uomo bianco e Apache:
mitologia, certo, ma raramente retorica, una scrittura vivissima, realista, che non abbraccerà forse il pessimismo e la crudezza del western rivisitato alla Cormac McCarthy, ma non è nemmeno consolatoria e benevola come i lungometraggi (Quel Treno per Yuma e I Tre Banditi qui presenti) che l'industria cinematografica prenderà in prestito. (Fabio Cerbone)
JJiimm HHaarrrriissoonn Ritorno sulla terra (Rizzoli, pp.281) La morte di Donald, un uomo che amava la vita come la terra, schiude una rete di legami, di affetti, di storie che sono qualcosa in più di una famiglia e rappresentano la vera anima e il senso ultimo dell'esistenza. Nell'assecondare l'attesa dell' inevitabile, Donald, sua moglie e i figli, una famiglia che regge più sull'idea di condivisioni e di storie, piuttosto che su quello della parentela, ricostruiscono intere vite. "A me piacciono le storie con dentro le persone" dice uno di loro e sembra più una confessione di Jim
Harrison che della voce di uno dei personaggi perché agganciando ricordi su ricordi non riprende forma soltanto la vita del predestinato, ma anche quella di tutte le altre esistenze che, in un modo o nell'altro si sono intersecate con la sua. Come il coro di un tragedia, le voci dei personaggi si sovrappongono, una dopo l'altra, senza soluzione di continuità, a creare una sinfonia, una "sola" voce che racconta il sogno, la realtà, la vita, la morte: quando mangiano, quando viaggiano (due delle attività fondamentali per i personaggi del romanzo) è uno scorrere di tentativi, di emozioni, di

ricerche, un modo di restare legati alla terra, all'anima di chi se ne va, ma anche a se stessi, come se fosse l'insieme a determinare la personalità, e in fondo l'anima stessa. Tra i i libri più belli e intensi di quest'anno, persino coraggiosi nel ribadire la libertà di morire che poi, questa è l'arte del romanzo, la stessa di vivere. (Marco Denti)
RRiicchhaarrdd FFoorrdd Lo stato delle cose (Feltrinelli, pp.676) La lunga epopea di Frank Bascombe, il personaggio di Richard Ford che era comparso la prima volta come Sportswriter ed era tornato per Independence Day, si conclude sulla costa del New Jersey. E' il giorno del Ringraziamento, l'inverno comincia a farsi sentire e anche gli anni passati hanno cambiato tutto e niente, difficile scoprirlo perché "non è che vediamo la parte e il non il tutto: noi proprio non vediamo, né la parte né il tutto". Frank Bascombe si è sposato una seconda volta, ha scoperto di essere malato, si è messo in proprio (con un socio di origini tibetane) e riga dopo riga sembra ripetere, con quel tono proprio di Richard Ford (suadente, ossessivo nei dettagli e premuroso nei confronti del lettore) "I don't wanna fade away". La citazione è quasi obbligatoria perché ancora più di Independence Day (come è ovvio fin dal titolo), Lo stato delle cose sembra ispirarsi a piene mani da The River: non è soltanto il New Jersey o la vita dentro le macchine ("Perché succedono tante cose in macchina? Che sia l'ultimo spazio intimo che ci è rimasto?" si chiede ad un certo punto Frank Bascombe) che sono gli stessi di Bruce Sprigsteen ma anche quell'attitudine a raccontare le storie un pezzo alla volta, cercando di focalizzare minuscoli particolari e nello stesso tempo grandi emozioni per giungere ad una poesia della quotidianità che dice, infine "la giornata è passata intatta. Non è una cosa da dare per scontata". Così viviamo oggi, e Lo stato delle cose è uno dei pochi capolavori che riesce ancora a narrarlo
con passione e lucidità. (Marco Denti)
JJaammeess LLeeee BBuurrkkee L’urlo del vento (Fanucci, pp.420) Katrina e Rita hanno cancellato una città, una storia un mondo, ma dentro l'apocalisse si celano migliaia di episodi di violenza, ferocia e arroganza, a partire dall'incapacità del governo federale di comprendere la dimensioni degli eventi. Nel ricostruirli James Lee Burke non si perde niente della cronaca di quei giorni e ci costruisce un episodio della saga di Dave Robicheaux che è la parte centrale di un ciclo dedicato alla fine di New Orleans. La missione di Streak alias Dave Robicheaux questa volta è davvero impossibile perché salvaguardare la giustizia o la morale o un minimo sindacale di separazione tra bene o male quando "la gente non ne può più. A volte non ne può più e ha paura" è già difficile e faticoso e nei giorni di Katrina è diventato impossibile. Così nei meandri del disastro e attraverso i tormenti di Streak, James Lee Burke eleva un atto d'accusa preciso e dettagliato, persino accorato in più di un passaggio e per niente velato dalla realtà romanzesca. "Non si può ricostruire un mondo a pezzi" scrive James Lee Burke guardando New Orleans attraverso gli occhi di Dave Robicheaux e dei suoi colleghi, ma c'è qualcosa di più che in quei giorni si scopre ed è che "Noi americani siamo una razza a sé stante. Crediamo nella legge e nell'ordine, ma crediamo anche che i veri crimini vengano commessi da una classe separata di persone, che non ha niente a che fare con le nostre vite o il mondo di comportamenti ragionevoli e rispetto reciproco a cui apparteniamo". Quando poi quella "classe" coincide con il governo, l'Urlo del vento può solo fare paura. (Marco Denti)

FFFFFFFFoooooooollllllllkkkkkkkklllllllloooooooorrrrrrrreeeeeeee la monografia di Rootshighway
TThhee DDeell FFuueeggooss ”Play this record loud”
di Yuri Susanna Boston nella prima metà degli anni '80 cercava di resistere come poteva: la scena hardcore andava compattandosi intorno all'influsso dello straight edge di Washington, mentre la ricerca post punk poteva vantare la fondamentale esperienza dei Mission of Burma e nell'underground c'era chi guardava ai sixties, come i Lyres e i sottovalutati Neats. E poi c'erano i Del Fuegos, i migliori cantori delle notti in città. In pista dal 1980, i due fratelli Zanes (Dan, ugola d'asfalto e ghiaia, le cui corde vocali paiono bagnate nello stesso whisky che si consuma in casa Richards, e Warren, chitarra ritmica di pochissime buone maniere), insieme al bassista Tom Lloyd e al batterista Steve Morrell, si fanno venire i calli sui palchi dell'East Coast prima che la Slash, etichetta benemerita con sede sull'altra costa, si accorga di loro - pare su segnalazione di Dave Alvin - e li affidi alle mani di un giovane produttore dal futuro pesante, Mitchell Froom. Il sodalizio partorirà tre album che sbalzano nella pietra (nel vinile, cioè) una piccola grande leggenda del rock di serie B (solo in termini di budget, non certo di qualità), prima che il mancato successo, gli scazzi tra i fratelli o più semplicemente il destino, che vuole gli eroi e le garage band invise agli dei, smembri il quartetto. Rimasto nelle mani di Dan e del bassista Tom Loyd, vale a dire i due membri originari, il gruppo troverà comunque il modo di chiudere la sua avventura con uno dei capolavori meno celebrati (ma niente paura: siamo qui per rimediare) del decennio. Fin qui la storia. Ma come spiegare a chi non c'era, a parole, cosa hanno rappresentato quelle canzoni di tre/quattro minuti, come trasformare la storia in epos? Proviamoci. I Del Fuegos sono stati, in anni di fede sotterranea e clandestina per un certo tipo di musica, un santino da appendersi al collo, un'icona della devozione verso un rock'n'roll da consumare sull'asfalto bagnato da luci al neon, tra il garage sotto casa e il bar all'angolo, semplice e appagato della sua dimensione romantica e ingenua, e propulso da una spinta ritmica che prende alle viscere e fa muovere le gambe. I sogni e la carne. Il desiderio e il sudore. In dimensione umana, da pub. Mentre chi cantava di essere nato per correre gonfiava i muscoli negli stadi, i Del Fuegos riportavano quell'ideale sulla terra, per viverlo in prima persona ogni venerdì sera nel locale più rumoroso della città. Questo per l'etica. Per quanto riguarda l'estetica, il gruppo incendiava (nomen omen) le polveri di un rock da strada dai nobili padri, da Springsteen ai Creedence, da Tom Petty ai Mink Deville. E gli Stones, naturalmente: quelli della prima british invasion, degli album da 30 minuti o anche meno, dei riff micidiali e del rhyhm & blues spogliato di tutti i fronzoli. Senza dimenticare la scena di Detroit, la rilettura bianca e sporca del soul della motorcity operata nel decennio precedente da brutti ceffi come Bob Seger, e che a Boston aveva conosciuto le gesta della J. Geils Band. Gli show dei Fuegos erano un esplosione di furore e ritmo che faceva tremare tutti i vetri dell'isolato; se non ci credete, fate un giro per la rete: troverete blog di attempati padri di famiglia che ricordano ancora oggi con ardore e commozione i glory days della band. Arriveranno anche in Italia, per promuovere Smoking in the Fields, nel 1989, e forse qualcuno che sta leggendo queste righe se li ricorda. Qui da noi il gruppo dei fratelli Zanes trovò subito terreno fertile per il proprio culto: più dei Replacements, band per molti versi affine, che, forse per le loro origini punk, non furono subito capiti

e apprezzati dal pubblico italiano, i Del Fuegos vennero presto "adottati" dai tradizionalisti più illuminati come profeti di un modo di intendere il rock che sembrava sulla via dell'estinzione, l'avamposto difensivo di una musica che nutre i sogni facendo prima muovere il culo. "Una musica che si è sentita mille volte e che si accetta sempre con la stessa indulgenza soddisfatta con cui si mesce un bicchiere del proprio vino preferito: si conosce il gusto, ma ogni volta sembra più buono. E poi fa sempre lo stesso effetto." (1) Di loro restano quattro album che sono un monumento di rock diretto e semplice, ma allo stesso tempo ricco di sfumature e risonanze. Un poker mancato - la terza carta del mazzo, Stand Up, non è esattamente un asso, ma neanche un "due" come era sembrato ai tempi - che ora, grazie al lavoro della Wounded Bird, è di nuovo disponibile quasi interamente (manca ancora all'appello Smoking in the Fields) in Cd.
(1) Cosi scriveva Mauro Zambellini, maestro di sensibilità e immaginario per un intera generazione di scrittori rock, sul numero di marzo 1986 di un Mucchio a quei tempi ancora "selvaggio" (di nome e di fatto)
:::: IIll ccaappoollaavvoorroo
Smoking in the Fields [RCA 1989] 1. Move With Me Sister //2. Down in Allen's Mills //3. I'm Inside You //4. Headlights //5. Breakaway //6. Dreams of You //7. The Offer //8. Part of This Earth //9. Stand by You //10. Lost Weekend //11. No No Never //12. Friends Again
Rimasti in due, Zanes e Lloyd chiudono l'avventura dei Del Fuegos reclutando a bordo il chitarrista Adam Roth e il batterista Joe Donnelly e affidando il timone al produttore Dave Thoener, che riprende il discorso dove il gruppo l'aveva interrotto con il fallimentare Stand Up. Vale a dire da una scrittura rock classica, fatta di riff di chitarra quadrati ma mai banali, aperture armoniche da grandi spazi e un pulsare ritmico da pub-rock ad alto tasso di negritudine. Smoking è il capolavoro che gli album precedenti lasciavano intuire, undici canzoni in cui il potenziale di songwriter di Zanes si realizza pienamente, con un suono finalmente ricco ma non sovraccarico, in cui i fiati, gli archi, le coloriture delle tastiere non rallentano, anzi esaltano l'andamento dei pezzi. Il disco è tutto quello che il rock (almeno quello "ufficiale") negli anni '80 non è stato. Non che sia una colpa, è chiaro, nessun moralismo: semplicemente la storia aveva preso un'altra strada. I Del Fuegos, senza nostalgia ma con una grande coscienza delle radici che li
sostengono, nel loro canto del cigno riportano la musica alla sua dimensione corporea, carnale, ad un'urgenza espressiva che pochissimi dischi di quegli anni sono in grado di raggiungere, soprattutto all'interno di una dimensione così "classica". Come degli esiliati sulla strada maestra: gli Stones del loro capolavoro sono il referente immediato di questa festa di sudore e passione, cui sono invitati anche due reduci della più grande pub-band di Boston prima dei Fuegos, Seth Justman e Magic Dick della J. Geils Band (in evidenza nelle bolgie rock'n'roll di Headlights e Lost Weekend). I fiati, che nel disco precedente foderavano la scarsa stoffa delle canzoni, qua sono la miccia che fa esplodere la danza di strada di Move With Me Sister e accompagnano la corsa di Dreams of You, The Offer e No No Never, mentre I'm Inside You è la ballata che ogni band di adolescenti che dopo la scuola attacca gli ampli alla presa del garage del babbo sogna di scrivere nella vita. Prima del commiato ai vecchi compagni di strada di Friends Again, dedicata a Warren, c'è anche lo spazio per sentire la voce di Rick Danko fare capolino in Stand by You. Un disco che ogni volta restituisce la stessa carica della prima volta che si è fatta scendere la puntina sui suoi solchi e fa scoprire sempre qualche particolare nuovo (l'avevate notata voi la tromba mariachi nel finale di Down in Allen's Mill?). Tutte le qualità di un capolavoro, insomma.

:::: DDiisscchhii eesssseennzziiaallii
The Longest Day [Slash 1984]
Un album che inizia con Nervous and Shakey e Backseat Nothing non si capisce come non possa essere considerato un classico della musica americana. Eppure, i Del Fuegos non sfondarono né con questo primo tentativo, già maturo e compiuto, né con i successivi. Il loro romanticismo in giubbotto di cuoio era fuori posto non solo rispetto all'edonismo dei tempi, ma anche rispetto al tardo ribellismo punk e all'angst di quella generazione X che stava per uscire allo scoperto. La storia della loro breve esistenza si consuma tutta fuori tempo, insomma. Importante in questo esordio il lavoro di Mitchell Froom, di fatto il quinto membro della band, che trafigge i pezzi con stilettate di hammond e, soprattutto, mantiene il suono grezzo e immediato senza farlo suonare sporco o impastato, giocando in studio con echi e riverberi per dare quel tocco particolare (poco anni '80, in fondo) agli anthem dei ragazzi. Come se le canzoni fossero registrate in un garage, e non al Sound Factory di Los Angeles. La voce di Dan Zanes è già perfetta, arrochita dalle sigarette e dalle serate passate a urlare sui palchi di mille pub, cercando di sovrastare le voci degli avventori e il casino prodotto dalla sezione ritmica. Oltre al dittico iniziale, si segnalano la title-track, Mary Don't Change, la pettyana Call My Name e Missing You, una delle rare incursioni in territori country del gruppo. Rolling Stone li vota miglior nuova band del 1984 (che porti sfiga?) e Have You Forgotten qualche anno dopo finirà nella colonna sonora del cult-horror demenziale "I Was a Teenage Zombie" (in Italia "I ragazzi del cimitero"). Prima delle registrazioni il batterista Steve Morrell è sostituito da Woody Giessmann.
Boston Mass. [Slash, 1985] Chi legge queste pagine e ha più di trent'anni quest'album lo possiede e l'ha quasi sicuramente consumato. Probabilmente in vinile. Magari "bucato". Perché i sogni di rock'n'roll in quegli anni, prima che Ligabue li rendesse (nazional)popolari, finivano presto in saldo. Ma non per questo valevamo meno, anzi. Questo è il disco che ci ha fatto correre tutti, sul battito irresistibile di Don't Run Wild e sul filo dell'elettricità frenetica di It's Alright, brano capace ancora oggi di buttare giù i muri di qualsiasi locale. Il canovaccio è lo stesso del disco precedente, così come il lavoro di Froom sui suoni, ma il gruppo in pochi mesi ha affinato soprattutto l'arte della composizione: non c'è un pezzo rinunciabile in Boston, Mass. In particolare, Dan Zanes è cresciuto come autore di ballate: come resistere al cuore gonfio di Fade to Blue o al romanticismo da vicolo male illuminato di Coupe de Ville? E poi, perché farlo? Menzione speciale per Night on the Town, tre minuti di poesia notturna avvolta dalla calda coperta di un hammond. Stavolta il mondo che conta sembra davvero accorgersi di loro: Springsteen in una pausa del tour di Born in the USA li raggiunge sul palco di un club in North Carolina ed esegue con loro Hang on Sloopy e Stand by Me. Alla Slash circolano un po' di soldi e il gruppo gira anche un paio di video: quello di I Still Want You (altra ballatona che stringe lo stomaco) - immagini sgranate e virate al blu dei neon, - manda il singolo in classifica (87mo posto della Billboard Hot 100) e riceve un buon airplay anche in Europa, in particolare in Spagna (!). Infine, la birra Miller li sceglie, riprendendoli live, per un commercial. Ma i fratelli Zanes non sono Nick Kamen, e non sarà uno spot a cambiar loro la vita.

Stand Up [Slash, 1987]
Il gruppo cerca di prendere il sogno per la coda, e sfrutta l'hype che cresce intorno al nome della band: al numero dei fans illustri si aggiungono anche Fogerty e Petty, che li chiama ad aprire il tour del 1986 insieme ai Replacements (riuscite a immaginare che razza di show potessero essere?) e partecipa alle sessions del nuovo album. Froom questa volta cerca di arricchire di sfumature il suono, di aggiungere colori a una tavolozza che in realtà aveva già tutte le tinte necessarie per i quadri, naif e fauve, che i Fuegos dipingevano tanto bene. Il rischio è quello di snaturare il suono della band, di trasformarla da un ensemble di impatto live a qualcosa d'altro, né carne né pesce. In realtà l'idea di esplorare il lato soul della scrittura di Zanes non è di per sé sbagliata, come dimostrerà nei fatti Smoking in the Fields. Manca però in Stand Up il senso della misura: il disco è infarcito di backing vocals, fiati e session man (James Burton, Alex Acuna e Merry Clayton - la voce femminile di Gimme Shelter - i nomi dal cachet più alto) che non rendono sempre un buon servizio alle canzoni. Canzoni che sono in fondo il vero punto debole dell'album: dopo anni di concerti in giro per l'America Dan arriva all'appuntamento con il terzo fondamentale disco col fiato un po' corto, ed il suo songwriting risulta appannato. La produzione sovrabbondante non fa che aumentare questa sensazione, dando l'idea che sia necessario riempire i vuoti di ispirazione con paillettes e lustrini. Sia chiaro: se uscisse adesso, un album così, forse lo troveremmo disco del mese di Rootshighway, ma allora, dopo le due gemme che l'avevano preceduto, la delusione fu davvero forte. Tanto che molti non si accorsero del valore comunque innegabile di brani come la funkeggiante Wear it Like a Cape, A Town Called Love o la stoniana Long Slide. E New Old World non è poi così male, anche se sembra un brano di Robert Plamer. Il duetto con Petty in I Can't Take This Place passa invece inosservato, allora come oggi. Al termine del tour Warren e il batterista Woody Giessmann molleranno il colpo
:::: IIll rreessttoo
Dan Zanes Cool Down Time [Private, 1995] Dan prova a rimettersi in strada, con l'aiuto di un raffinato torturatore di tamburi come Jerry Marotta e del solito Mitchell Froom, ormai diventato un nome di grido. L'album del ritorno è profondamente segnato dalle sonorità del produttore: se avete presente i dischi di metà anni '90 di Los Lobos, Richard Thompson o della consorte Suzanne Vega, non dovrete fare uno sforzo troppo grande per immaginarvi cosa vi aspetta. La sorpresa è che le canzoni di Dan funzionano anche in questa veste di raffinato minimalismo, quasi jazzy in alcuni momenti (No Sky), con arrangiamenti segnati più dal battito dei bassi rotondi e pieni e dalle incursioni dell'organo che dal volume delle chitarre (Zanes scopre la leva del tremolo della sua Fender e ne ricava suoni carichi di suggestione…). Tested è un bel rock da corsa in auto, mentre All Time Girls scuote il fantasma di Buddy Holly, Rough Spot aggiorna il verbo dei Creedence alle notti dei '90 e ballate come Darkness Before Dawn e Carelessly hanno il sapore agrodolce dei sogni lasciati maturare troppo. Un disco dalla forte impronta notturna, che rivela sfumature più intime della voce del suo autore e una maturazione nei temi delle liriche e mantiene ancora oggi il suo fascino, ma che non vende nulla e il cui insuccesso convince Dan, diventato padre proprio quell'anno, a prendere un'altra strada. Una strada le cui tappe sono 8 album di "family music", canzoni per bambini che ricostruiscono la carriera del musicista, gli procurano uno spazio su Disney Channel e tour festanti in giro per i teatri d'America. "Non c'è nulla che rimpiango del mondo del pop. Credo che ciò che ho sempre desiderato sia essere amato dalla gente per cui faccio musica, ed in questo senso ottengo molto più appezzamento ora che mai. (…) Senza contare che non torno a casa puzzando di fumo e nessuno più rovescia birra sulle mie scarpe."

Warren Zanes Memory Girls [Dualtone, 2003] "Brother" Warren non è rimasto certo inoperoso dopo avere abbandonato il gruppo al suo destino: una laurea con dottorato in Arti Visive, e una cattedra alla Manhattan's School of Visual Arts farebbero pensare che il più giovane dei fratelli Zanes sia stato il primo a mettere la testa a posto. Ma la nostalgia è canaglia e la voglia di ritornare nel giro della musica lo ha spinto prima a registrare alcuni brani con la complicità dell'ex Morphine Billy Conway, poi a lavorare in studio con i Dust Brothers (Beck e Beastie Boys, tra gli altri) per un album che per problemi legali vedrà la luce un paio d'anni dopo la sua registrazione. I giorni degli strumenti caricati in fretta sui furgoni e dei pub lungo la strada sono davvero lontani: Warren è ora un maturo gentleman un po' dandy, con ancora la faccia da adolescente ma gusti musicali ormai adulti. L'album ha un feeling pop un po' blasé, un cocktail con appena qualche lontano sapore degli ingredienti roots e garage dei tempi che furono. Insomma negli anni '90 Warren ha avuto modo di sostituire i poster di Keith Richards e Joe Perry sopra il letto con quelli di Phil Spector e Burt Bacharach. L'album ha comunque i suoi momenti, e conta anche qualche apparizione di vaglia (Patty Griffin, Emmylou Harris). Non dispiace la melodia di First on the Moon, ruffiana quanto basta, e la cartolina dalla Senna di Did You Recognize My Love, mentre If You Could Stay aggiorna Getting Better dei Beatles e Have You Once Recalled the Days riporta alla mente il flirt con il soul orchestrale di Paul Weller ai tempi degli Style Council. Ma la voce di Warren manca di incisività e personalità, e tutto scorre senza lasciare troppo il segno. Il ragazzo comunque ci prende gusto, e nel 2006 fa uscire un secondo capitolo. Se vi capita tra le mani nel reparto dei cd usati di qualche negozio fateci un pensierino, ma non state a perderci il sonno.
:::: RRiieeppiillooggoo ((DDiissccooggrraaffiiaa)) - The Del Fuegos The Longest Day (Slash, 1984/ Wounded Bird, 2008) Boston, Mass. (Slash, 1985/ Wounded Bird, 2008) Stand Up (Slash, 1987/ Wounded Bird, 2008) Smoking in the Fields (RCA, 1989) The Best of the Del Fuegos: The
Slash Years (Warner Bros., 2001) - compilation dei primi tre album (il primo è riportato per intero, più 8 canzoni da Boston e 2 da Stand Up)
- Dan Zanes Cool Down Time (Private, 1995)
- Warren Zanes Memory Girls (Dualtone, 2003) People That I'm Wrong For (Dualtone, 2006)

RootsHighway Mixed Bag Trimestrale PDF del web magazine RootsHighway
www.rootshighway.it
RootsHighway 2008
RootsHighway Mixed Bag Trimestrale PDF del web magazine RootsHighway –
www.rootshighway.it
Direzione e coordinamento: Fabio Cerbone - [email protected]
Collaboratori e testi di: Davide Albini, Massimo Baraldi, Gabriele Buvoli, Gianfranco Callieri, Fabio Cerbone, Gianni Del Savio, Marco
Denti, Maurizio di Marino, Matteo Fratti, Gabriele Gatto, Nicola Gervasini, Roberto Giuli, Stefano Hourria, Carlo Lancini, Giovanni Manzoni, Ruggero Marinello, Francesco Meucci, David Nieri, Yuri
Susanna, Gianni Zuretti