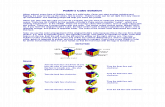themenheft_4_10_it
-
Upload
euro26-schweizer-jugendkarte-ag -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
description
Transcript of themenheft_4_10_it

twen
Libertà e responsabilità
Noi siamo la SvizzeraL’intervista: cosa tiene ancora unita la Svizzera oggiLa tradizione è trendy: di moda lo jodel e la lotta svizzeraSalome Hofer: presidente del consiglio comunale a 24 anni
Gli argomenti del momento

2
Tipicamente svizzero
Cosa rende speciale la Svizzera, cosa è tipico? L’abbiamo chiesto, fra gli altri,
al re della lotta svizzera Kilian Wenger.
Kilian Wenger, 20Re della lotta svizzera 2010Horboden im Diemtigtal/BE
Siamo un popolo aperto e amichevo-le: trovo che svizzere e svizzeri siano proprio così. Caratteristici del nostro Paese sono, fra l’altro, la natura e il
clima, che io apprezzo molto: bello e stabile. Non si muore dal caldo tutto l’anno e l’alternarsi delle stagioni è ben visibile. In Svizzera inoltre, rispetto ad altri Paesi, stiamo molto bene, siamo ricchi: ognuno ha un tetto sopra la testa e mangia tutti i giorni. La lotta svizzera è tipica del Paese: è uno sport rude nel quale però i concorrenti si sfidano con grandissimo rispetto.
Sarah Jane, 25CantanteRothenfluh BL
T ipicamente svizzero è il nostro franco. E il fatto di averlo ancora. Lo sono però anche i nostri paesaggi. Secondo me non esiste un posto più
bello della mia patria, l’Oberbaselbiet. È lì che ricarico le batterie quando mi capita di stare via a lungo. Tipici del nostro Paese sono anche naturalmente i nostri rinomati prodotti: per esempio gli orologi e, soprattutto, la cioccolata. Quando mi trovo
all’estero, immancabil-mente, mi si parla di questo. Trovo gli svizzeri molto autentici, disponibili e generosi: con il cuore in mano.
Lisa Stoll, 14Suonatrice di corno delle AlpiWilchingen SH
La particolarità della Svizzera è di offrire tutto quanto si possa desidera-re: in Ticino ci si sente come al mare. E dove vivo praticamente si hanno
le montagne davanti alla porta di casa. Preferisco vivere in campagna, per i magnifici paesaggi e la grande pace. Molto tipico della Svizzera è naturalmente lo strumento che suono: il corno delle Alpi. Amo il suo timbro profondo e tranquillo.
Ascoltando il suono di un corno delle Alpi si pensa subito alle nostre montagne.

3
Caratteristiche tipicamente svizzere
34,5 %
Inchiesta rappresentativa condotta nel 2008 dalla Konso, su incarico della rivista «Beobachter». Intervistate 826 persone dai 15 anni.
Made in SwitzerlandGli svizzeri sono ingegnosi: che si tratti del mouse per il PC, del pelapatate o del velcro,
molte invenzioni ormai indispensabili nella vita di tutti i giorni sono state realizzate in Svizzerao da svizzeri sparsi in tutto il mondo.
Jens-Rainer Wiese, 47Consulente IT e bloggerIn Svizzera da 10 anni
Gli svizzeri stanno alla larga dai litigi. Detto negativamente: perseguono l’armonia a tutti i costi. Detto positivamente: sanno
creare il consenso. Tutto viene soppesato alfine di trovare soluzioni che piacciano alla maggioranza. Poi ci sono gli equivoci nati dall’abitudine svizzera di non esprimersi in modo diretto: perfino la critica più dura è talmente addolcita, da ridursi alla fine a un gentile consiglio. I tedeschi sono più diretti, dicono pane al pane e vino al vino. Tipicamente svizzera per me è la differenza fra cortesia e amicizia. I rapporti interperso-nali sono generalmente improntati ad una perfetta cortesia. Ma con l’amicizia non
hanno niente a che vedere. I tedeschi scam-biano questa cortesia per amicizia – e raccontano all’interlocu-tore tutta la loro vita.
Victorinox. Altri esempi di ingegnosità targata CH: la Swatch, lo spazzolino elettrico, ... – la lista è ancora lunga, le idee brillanti sono tipicamente svizzere!
Addirittura la nostalgia è un’invenzione svizzeraLa nostalgia di casa, dal tedesco Heimweh: «desiderio ar-dente e doloroso di luoghi conosciuti, della patria lontana» (Lessico storico della Svizzera), è un concetto coniato in Svizzera. La prima testimonianza scritta risale al 1651. All’estero si parlava allora della malattia degli svizzeri, il «mal du Suisse» o «Schweizerheimweh». A soffrirne i soldati svizzeri, in servizio lontani da casa. Nel 18o secolo il professore di medicina Theodor Zwinger ne attribuì la causa ai cosiddetti «Kuhreihen», caratteristici canti di ri-chiamo delle mucche per la mungitura. Secondo Zwinger questi canti avrebbero risvegliato nei soldati una vera sma-nia di casa, invitando alla diserzione. Venne dunque proi-bito agli svizzeri di intonare i loro canti alpini all’estero.
Una giacca senza chiusura lampo? Impensabile. La cerniera, identica a quella impiegata ai giorni nostri, fu inventata da un sangallese, tale Martin Othmar Winterhalter. E Adolph Rickenbacher,
nato a Basilea e emigrato a L.A., è responsabile del chiasso che in tutto il mondo i musicisti fanno con le loro chitarre elettriche. Nel 1930, con un partner americano, realizzò il primo pick-up elettromagnetico per chitarre; le «Ricken-backer» vengono prodotte ancora oggi. Lo sci-lift ad ancora è un’invenzione dell’ingegnere zurighese Ernst Constam, il mouse nacque nella ditta romanda Logitec e Internet vide la luce al CERN di Ginevra. Di made in Switzerland è piena la cucina: la pressa per aglio è un’idea di Karl Zysset, fondatore della Zyliss, il pelapatate di Alfred Neweczerzal di Davos e l’anatra WC è figlia di Walter Düring e di sua moglie Vera (Düring AG, Dällikon). L’inconfondibile coltellino svizzero è frutto dell’ingegno di Karl Elsener, coltellinaio di Svitto e fondatore della
Discreti, riservati, modesti: dai risultati di un’inchiesta,le svizzere e gli svizzeri si vedono così.
discreti, riservati, modesti
24,0 % amichevoli, simpatici
18,5 % puntuali
12,1 % laboriosi, diligenti, grandi lavoratori
7,1 % ospitali
Caratteristiche tipicamente non svizzere
11,9 % aperti, disponibili8,6 % gaudenti, rilassati
7,9 % disordinati, sporchi
5,3 % risoluti, sicuri di sé
4,4 % spacconi, presuntuosi

4
L’intervista
Cosa tiene unita la Svizzera?Direi i soldi, la libertà e il percorso
storico comune. Il denaro è sempre sta-to un importante motivatore. Le tre di-verse regioni culturali hanno compre-so ben presto che se non fossero rimaste unite sarebbero sempre state semplice periferia: la parte più a nord dell’Italia, il meridione della Germania e uno sperduto territorio della Francia. Esse-re uniti si traduceva allora in una pri-ma, interessante fonte di guadagno: i pedaggi alpini e l’esportazione di be-stiame. L’idea di libertà unisce pure fortemente la Svizzera. Nella democra-zia diretta, nelle votazioni popolari trova, ora come nel passato, la sua espressione ideale, traspare però an-che dal volersi isolare da tutto il resto. La Svizzera prende le distanze?
In tutte le regioni, il desiderio di isolarsi dalle culture vicine dominanti – Germania, Francia e Italia – gioca un ruolo cruciale. I ticinesi si isolano dall’Italia culturalmente e territorial-mente. In Romandia l’atteggiamento è diverso: non esiste confine culturale, anzi direi che troviamo piuttosto un’unità. Grande è invece la distanza tra i romandi e la Francia se conside-
riamo la salvaguardia dell’autonomia federale. Dal 20o secolo, la Svizzera te-desca si è allontanata moltissimo dalla Germania. Prima non era così. Fino al-lo scoppio della prima guerra mondia-le la Svizzera tedesca si vantava dell’unione culturale con la Germania e soprattutto con il Baden-Württem-berg. Quali erano e sono dunque le dif-ficoltà per questa Svizzera?
Sicuramente le barriere linguisti-che, a tutt’oggi l’ostacolo più grande al-la convivenza. Lo vediamo molto bene nelle votazioni, per esempio in quella per l’adesione all’UE, che evidenziò la spaccatura linguistica. Poi il regionali-smo, che risale al vuoto lasciato dalla nobiltà locale nel Mittelland durante il 12o e 13o secolo. Di fatto i nostri nobili si combatterono l’un l’altro, stirpi e ca-sate si estinsero a causa della massic-cia partecipazione alle crociate oppure perché, come gli Asburgo, lasciarono il territorio. Solo i Savoia si imposero nel sud, ma rivolsero il loro interesse all’Italia, mentre gli Asburgo si ritira-rono in Austria. Il risultato da noi fu un vasto territorio privo di sovranità, che certo permise l’instaurarsi del si-
stema confederale ma che favorì pure molti singoli interessi. Ancora oggi i cantoni ne sentono il peso. Inoltre, ti-pica per quei tempi, vorrei ricordare la Vecchia guerra di Zurigo del 15o seco-lo, quando i zurighesi, combattuti da svittesi e bernesi, si allearono agli Asburgo. Solo in seguito venne vietato ai cantoni di stringere al contempo al-leanze con confederati e nobili. Gli eserciti di mercenari erano però anco-ra permessi. Con tutti i problemi ad es-si connessi. Nel 16o secolo, nelle Cam-pagne italiane del nord Italia, mercenari svizzeri combatterono con-tro mercenari svizzeri.Malgrado tutto diventammo unanazione: come?
Il passaggio fu graduale. Era neces-saria una volontà comune. Cultural-mente la Svizzera non fa alcun senso, ma economicamente sì. Da qui il con-cetto di comunità fondata sulla volon-tà: si decise di restare uniti per poter approfittare di certi vantaggi derivanti dalla posizione geografica. Fondamen-tale pure il concetto di libertà: non si dimentichi che siamo una delle socie-tà più liberali in assoluto. Dal 1970 ab-biamo segnato una svolta, adottando
Claude Longchamp, storico e sociologo
«La Svizzeraè unita.»L’idea di libertà, che fortemente traspare dalla democrazia diretta, mantiene ancora saldamente unita la Svizzera, sostiene Claude Longchamp.

5
valori molto liberali, per esempio per quanto riguarda la convivenza omosessuale, l’aborto, il consumo di droga o il suicidio assistito. Traspare chiaramente una grande libertà e individualità di pensiero. Alle altre nazioni pare spesso impossibile che la Svizzera funzioni. Comunità fondata sulla volontà?
Questa comunità non si rifà ad una lingua, vedi l’unità culturale della Germania, oppure ad un evento, la rivoluzione francese, bensì ad un passato comune. Il classico cemento di una comunità fondata sulla volontà era il patriottismo: l’identificazione in sé stessi, nella Svizzera, nella sua condizione di garante dell’indipendenza. Il patriottismo, come inteso nel 19o secolo, oggi non esiste più.Cosa l’ha sostituito?
Un patriottismo diviso in tre varianti: la prima vivace e nazionalista, molto più conservatrice rispetto al passato. La componente nazionalista è simile, ma gli stimoli innovativi sono quasi del tutto assenti ed è la tradizione ad assurgere a valore centrale. Una reazione alla globalizzazione. D’altra parte abbiamo l’internazionalismo individualista e progressista, che saluta molto favorevolmente la globalizzazione. Riscontriamo questo atteggiamento più sovente nelle fasce alte della popolazione, in persone di elevato status sociale, che vedono nell’apertura opportunità personali di sviluppo e carriera e aspirano ad una veloce adesione all’UE. Fra i giovani notiamo una forte polarizzazione: da un lato, giovani aperti ad una carriera da qualche parte nel mondo e che si distanziano così dalla Svizzera. Dall’altro, quelli che considerano gli stranieri una concorrenza e si identificano nel nazionalismo conservatore.E la terza variante?
Fra questi poli c’è uno spazio vastissimo, denominato swissness, che attraversa e domina tutte le generazioni: un atteggiamento aperto e al contempo tipicamente svizzero, che considera la Svizzera un modello di successo, sia politico sia economico. Come nel 19o secolo, la swissness enfatizza valori politici centrali quali la democrazia diretta, il federalismo o il sistema di milizia. Oggigiorno la de
mocrazia diretta è ancora l’elemento più forte, mentre il sistema di milizia mostra tutti i propri limiti. La swissness attinge ad entrambi i poli: è aperta all’internazionalismo, ma resta saldamente ancorata alla Svizzera. Nei rapporti con l’Europa, la Svizzera ha optato per il compromesso, scegliendo la via degli accordi bilaterali. Restare svizzeri, soprattutto culturalmente, ma orientarsi economicamente all’Europa. Interessante: non sono stati i due poli ad imporsi, bensì la terza variante. Cosa rende così forte la democrazia diretta?
È la più vivace, e per me la più promettente, di tutte le istituzioni; con forti radici storiche e che tuttavia ha conservato tutto il suo potenziale fino ad oggi. Come sempre, il 50 % di tutte le votazioni popolari a livello mondia
le ha luogo in Svizzera. All’estero la cosa scatena reazioni opposte. Alcu ni vedono nella democrazia diretta un’istituzione primitiva, retaggio dell’antica società germana, e ormai superata mentre altri ne ammirano la forza e la capacità di trovare soluzioni. Se a Stoccarda le 60 000 firme contro la realizzazione della nuova stazione fossero state prese sul serio, si sarebbe evitato un bel pasticcio.Lei afferma che il sistema di milizia non è più lo stesso?
Secondo studi recenti, i parlamentari svizzeri dedicano dal 60 al 100 % del loro tempo lavorativo all’incarico parlamentare. I consiglieri nazionali e agli Stati fanno della politica una professione nella misura del 90 %. E un comune su tre fatica a trovare candidati per gli organi legislativi locali. Quali le cause?
La mobilità è enormemente aumentata, una buona fetta di popolazione, dal 10 al 30 % a dipendenza del cantone, è pendolare e non lavora nel cantone di residenza, molti traslocano per il lavoro. Le antiche relazioni all’interno
del comune si dissolvono lentamente. 30 anni fa queste relazioni erano ancora molto salde. Le conseguenze per l’impegnopolitico e volontario?
Il volontariato non è più visto come il compito di una vita, bensì come un incarico temporaneo. Si è disposti a dedicare alla comunità una parte della vita se un argomento ci colpisce, la vita nel quartiere, i richiedenti l’asilo, migliori condizioni quadro nell’economia. Per forse 10 anni si partecipa alla vita politica, poi si passa ad altro. Oppure a 60 anni si decide di non più realizzarsi nel lavoro o nei soldi ma attraverso l’impegno per la comunità.Fra 100 anni la Svizzera esisterà ancora?
E il mondo ci sarà ancora? Dipende dalla capacità della Svizzera di dare risposte adeguate alle importanti in
novazioni tecnologiche. Visto che la nostra società sembra avere molta affinità con la tecnica e possiede scuole superiori di rinomanza mondiale, come i politecnici
federali di Zurigo e Losanna, il Paese saprà adattarsi senza problemi alle novità. In quanto alle grandi incognite del futuro, traffico e energia, la Svizzera è ben posizionata. Per questo sono convinto che sì, la Svizzera esisterà ancora.
Claude Longchamp (1957)Lo storico e politologo è presidente del CdA e presidente della direzione del gfs.bern, nato dalla «Schweizerische
Gesellschaft für praktische Sozialforschung». L’istituto è molto conosciuto per le analisi dei risultati delle votazioni. Inoltre Longchamp è titolare di una cattedra presso le Università di Zurigo e S. Gallo e insegna alla Zürcher Hochschule di Winterthur.
«La chiusura verso Germania,Francia e Italia gioca un ruolodeterminante.»

6
Le «Respekt-Patrouillen» hanno individuato i punti nevralgici della città di Zugo e dei comuni limitrofi. Erano presenti laddove sovente si verificano risse, atti di violenza, schiamazzi, danneggiamenti e vandali-smi.
Sguinzagliati 50 volontariMa cos’hanno di straordinario queste pattuglie, che i vener-dì e sabato sera di bel tempo girano per i centri a gruppi di due o tre persone? Sono tutte composte da volontari – tran-ne un o una agente di polizia in borghese per ogni pattuglia. Per il progetto si sono annunciati donne e uomini dai 21 ai 70 anni, fra i quali docenti, pensionati, formatori di adulti, educatori ecc., in totale ben 50 volontari.
Marcare presenzaL’idea delle «Respekt-Patrouillen» è la ricerca del dialogo con i giovani, come spiega il segretario del progetto Kurt Wi-pfli, responsabile per i giovani presso la polizia di Zugo. «Li abbiamo sensibilizzati sulle problematiche dei rifiuti e del disturbo della quiete pubblica.» Altri obiettivi delle pattu-glie contraddistinte dalle T-shirt rosse: trasmettere valori quali rispetto e consapevolezza per l’ambiente, evidenziare malcostumi, infondere fiducia e sicurezza. Wipfli: «Le pat-tuglie hanno mostrato che non solo la polizia bensì anche i normali cittadini possono girare nei centri.» La repressione invece era esclusa. Stando a Wipfli, in situazioni critiche le pattuglie potevano cercare di appianare il contrasto. Se le cose però si fossero messe male, vi sarebbe stato l’intervento delle pattuglie di polizia.
Presi sul serioUna dei volontari era Tharsini Mangalarupan, assistente di cura in formazione, che durante l’estate ha accompagnato le
pattuglie quattro volte. Tharsini viene dallo Sri Lanka ed è giunta in Svizzera 14 anni fa, parla dunque tamil – un van-taggio per il lavoro della pattuglia. Lei e altri volontari pro-venienti dai Balcani si sono intrattenuti con i giovani di di-verse nazionalità nella loro lingua madre. «Il progetto ha portato qualcosa. Grazie alla nostra presenza, i giovani si sono sentiti presi sul serio», questo il bilancio di Tharsini «abbiamo chiesto loro cosa li spinge ad agire in certi modi, cosa manca a Zugo e quali sono le loro proposte di migliora-mento per la città.» Perché ha preso parte al progetto? «Mi piace lavorare con i giovani», racconta, «specialmente dare sostegno ai giovani immigrati. Inoltre la prevenzione della violenza è importante per me.» Motivo: la ventiseienne è impegnata in un progetto di assistenza a bambini e giovani. Durante i colloqui, Tharsini ha appurato che spesso questi giovani sono vittime della violenza.
Meno violenzaAnche se un bilancio definitivo dell’attività delle «Respekt-Patrouillen» non è ancora stato fatto, il risultato può già es-sere considerato un successo. Gli atti di violenza sono dimi-nuiti, afferma Kurt Wipfli, a Zugo regna un’atmosfera più distesa. Inoltre il tema del coraggio civile è più sentito – so-prattutto grazie all’impegno dei volontari!
Le «Respekt-Patrouillen» fanno parte del progetto triennale «Uniti contro la violenza», lanciato dal Canton Zugo nel 2009. Il progetto vuole prevenire la violenza e contribuire a migliorare la lotta a quest’ultima. La decisione sull’opportunità di riproporre le pattuglie nel 2011 non è ancora stata presa. Si deciderà entro la fine dell’anno in corso.
contro la violenzaVanno dove si incontrano i giovani: a Zugo e dintorni,nell’estate del 2010, ogni weekend di bel tempole cosiddette «Respekt-Patrouillen» hanno marcatopresenza. Il loro obiettivo: prevenire la violenza,cercare il dialogo, essere presenti sul territorio.Il loro motto: «Osservare invece di volgere lo sguardoaltrove».
Volontari

7
5,0
4,4 2,7
3,0 5,1
1,0 2,3
3,9
4,3 2,7
1,3 3,1
5,8
11,4
La Svizzeranon sarebbe nientesenza volontariato
«Niente», risponde sorridendo Herbert Ammann della Società svizzera di utilità pubblica (SGG) alla domanda: cosa sarebbe la Svizzera senza il volontariato?
Poiché: «Ogni società vive di prestazioni volontarie.» Per meglio comprenderlo,
basta considerare gli ambiti, pressoché infiniti, nei quali dei volontari sono attivi. Senza alcuna ricompensa allenano bambini e giovani speranze dello sport. L’assistenza e l’accompagnamento di anziani e malati è pure affidato a volontari, proprio come l’impegno politico comunale o le sezioni di partito locali. È grazie al volontariato che si hanno feste di paese, di quartiere e nella parrocchia, campi di vacanza per bambini e giovani, assistenza e aiuto ai bisognosi, lezioni di musica nelle filarmoniche, ascolto e appoggio presso il Telefono amico, musei minuscoli ma aperti regolarmente al pubblico, sentieri puliti e curati ... e molto altro ancora. Perfino i grandi eventi non potrebbero avere luogo senza volontari: l’annuale gara sciistica del Lauberhorn dipende dal contributo dei volontari, proprio come gli Europei di calcio del 2008. In poche parole: praticamente in tutti i campi della vita ci vogliono volontari disposti a dare una mano.
Lo sport attira il maggiornumero di volontariPartecipazione ad attività istituzionali di volontariato, divise per tipo e sesso, in percentuale della popolazione residente
Associazioni sportive
Associazioni culturali
Organizzazioni caritatevoli
Istituzioni ecclesiastiche
Associazioni diverse
Servizi pubblici
Partiti politici, cariche pubbliche
n Donne n UominiFonte: Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS): lavoro non retribuito 2007, © BFS
700 milioni di orenon pagate
Il totale delle ore di lavoro volontario è enorme: l’Ufficio federale di statisti-ca stima l’impegno in 700 milioni di ore l’anno.
Praticamente il dato corrisponde alle ore di lavoro pagate in un anno a tutti i
collaboratori dei settori sanitario e sociale messi assieme (2006: 706 milioni di ore). I 700 milioni di ore di volontariato sono divisibili in due: una metà a favore di enti istituzionali, volontariato informale per l’altra. Per i volontari ciò equivale ad una mezza giornata di lavoro non pagata per settimana (circa 13 ore mensili per il volontariato istituzionale e 15,5 per quello informale).
Uno su quattro fa del volontariato
In Svizzera, una persona su quattro presta volontariato in organizzazioni oppure istituzioni.
Ciò significa che circa 1,5 milioni di persone sono attive nel campo del
volontariato. Gli uomini si impegnano maggiormente rispetto alle donne negli ambiti cosiddetti istituzionali (28 % a 20 %). Ma abbiamo anche attività non pagate dette informali. Inteso è tutto il lavoro volontario prestato al di fuori di enti istituzionali: aiuto ai vicini, custodia e cura di bambini, cura, assistenza e servizi a parenti e conoscenti non residenti nella medesima economia domestica. Il 21 % della popolazione presta questi servizi a terzi, ciò corrisponde a circa 1,3 milioni di persone. In questo campo le donne (26 %) sono nettamente più attive degli uomini (15 %).

8
Detto altrimenti: la studentessa ventiquattrenne prepara le ri-unioni mensili del parlamento comunale, le presiede – e si ri-
trova così, quale presidente, a capo di un parlamento di 40 persone, uomini e donne, che nella maggior parte dei casi potrebbero essere i suoi genitori, se non addirittura i suoi nonni.
Non ha paura, vista la sua giovane età, di non essere presa sul serio? «Natu-ralmente ci ho riflettuto», confessa lei, «d’altra parte mi sono chiesta se le ca-pacità per questo tipo di incarico deb-bano necessariamente dipendere dall’età. Certamente i rapporti si com-plicherebbero se mi atteggiassi a nipo-tina con i membri più anziani del consiglio. La stessa cosa avverrebbe comportandomi da Rambo, quella che crede di fare tutto meglio.» Non esita a fare domande, approfittando così dell’esperienza politica delle e dei consiglieri più anziani. Inoltre non si è trattato di un salto nel buio. Da due anni Salome Hofer partecipava ai la-vori del consiglio. Ha così avuto il tempo e l’opportunità di conoscerli a fondo e prepararsi all’incarico.
Disposta al compromessoÈ stata eletta e chiamata a presiedere il consiglio con 37 voti su 38. Un ri-sultato eccellente. Il suo modo di fare ha sicuramente contribuito al largo consenso: «Credo di avere una specie di fascino che ispira collaborazione», dice di sé, «inoltre non sono una com-battente bensì una paladina del com-promesso gradito alle parti.» Cresciu-ta a Riehen, già attiva nella società di atletica leggera e nei lupetti, è impe-gnata nel Carnevale e dispone così di una grande rete di conoscenze.
Ambasciatrice del suo comuneL’incarico comporta dei doveri piutto-sto inusuali per l’età di Salome Hofer. Rappresentare Riehen, che con i suoi oltre 20 000 abitanti conta fra i 35 co-muni più grandi della Svizzera, segna-tamente ad eventi ufficiali. Che si trat-ti di premiazioni, inaugurazioni, raduni, festeggiamenti per il 1. agosto o trasmissioni televisive girate nel «suo» comune come «Donnschtig-Jass», Salome Hofer incarna la Riehen ufficiale. E questo la diverte un mondo: «Entro in contatto con persone che al-trimenti non avrei mai conosciuto.»
Nella politica da quasi 10 anniSalome Hofer è impegnata politica-mente da quasi dieci anni. A 15 anni prese parte per la prima volta alla Ses-sione dei giovani a Berna, a 17 entrò a fare parte del gruppo organizzativo della sessione e ne divenne presidente per due anni. L’interesse per la politica è nato in famiglia: «A casa si parlava di tutto», ricorda, «per molti anni mio padre è stato membro del partito socia-lista e i miei fratelli sono pure molto interessati alla politica.» Ha sempre amato leggere molto, «volevo sempre sapere tutto. In più adoro discutere e confrontarmi con altri punti di vista.»
Le stanno a cuore la formazione e posti di tirocinio per tutti, ma deside-ra anche sostenere le proposte per il tempo libero destinate ai giovani. Sa-lome Hofer non ritiene però che in questo ambito la città debba necessa-riamente occuparsi di tutto. Vorrebbe invece che fossero i giovani a propor-re molte più idee.
«La responsabilità è nostra»Così riassume la motivazione alla base del suo impegno: «Voglio dare il
Una granvoglia di politica
La studentessa Salome Hofer, 24 anni, malgrado la giovane etàha già raggiunto parecchi traguardi: a 20 anni diventa membrodel consiglio comunale di Riehen, il suo comune di domicilio,a 22 entra in Gran Consiglio, nel parlamento di Basilea Cittàe all’inizio del 2010 è stata eletta presidente del consiglio comunale.
Salome Hofer:

9
Un trampolinoper la politicaLa Sessione dei giovani, che ha luogo una volta l’anno a Berna, è una rampa di lancio ideale per tutti quelli che desiderano occuparsi di politica. Gli interessati trovano informazioni e procedura di iscrizione su www.jugendsession.ch. Chi invece vorrebbe rappresentare la Svizzera all’ONU, concorre per il posto di Youth Rep su: www.youthrep.ch
Chi si impegna pergli altri approfittaanche per séIn politica, in un’associazione qualsiasi o nei più svariati progetti: chi presta servizio volontario non contribuisce solo al bene della società ma anche alla propria evoluzione personale. Perché: «Grazie al servizio di volontariato si può imparare moltissimo», spiega Matthias Fiechter della Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG), «si impara ad assumersi delle responsabilità, a sviluppare progetti e idee, a concretizzarli e a mettere in piedi qualcosa. Si affinano le capacità nelle relazioni interpersonali, si impara a relazionarsi e a confrontarsi con gli altri.» Competenze sociali, soft skills dunque, sempre molto utili nella vita in generale.
Buttati!Le opportunità di volontariato sono infinite. Su www.forum-volontariato.ch o www.freiwilligenjahr2011.ch trovi una lista di proposte, così come su www.sajv.ch/it il sito della Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili. Chi invece vorrebbe prendere parte per un paio di settimane o mesi ad un campo di lavoro internazionale, trova pane per i suoi denti presso il Service Civil International. Lo SCI offre attività in tutto il mondo: puoi contribuire alla costruzione di un ecocentro in Bulgaria oppure organizzare attività per il tempo libero destinate ai bambini della Mongolia. Vai su www.scich.org
Una granvoglia di politica
mio contributo, alfine di migliorare la società», dice la studentessa di scien-ze politiche e European Studies. «La responsabilità è nelle nostre mani. Per questo mi pare importante impegnarsi per contribuire alla società, per modi-ficarla, non importa se nella politica, in un’associazione o come allenatore in un club sportivo.» Salome Hofer non se ne sta con le mani in mano. Oltre agli impegni politici è pure pre-sidente del «Midnight Sports Riehen» e fa parte del CdA della Basler Frei-
zeitaktion (BFA), che gestisce diversi punti di ritrovo per i giovani.
Nessuna rinunciaTre o quattro sere per settimana Salo-me è impegnata e agli amici deve spesso spiegare che «non posso uscire tutte le sere giusto per trovarsi a bere qualcosa.» La sensazione di perdere gli anni migliori non l’ha mai neppure sfiorata. «Ho una gran voglia di fare politica», afferma, «mi appassiona ap-profondire tematiche diverse.»
«La responsabilità per la societàè nelle nostre mani. Per questo motivo
trovo importante impegnarsi.»

10
Una gonna alla moda a disegni bianchi e neri, capel-li corti e rossi, tacchi alti: look piuttosto inusuale per una cantante di jodel, vero? Quando Nadja Räss canta, si presenta così. Inconsueti anche gli
strumenti che accompagnano l’artista di Einsiedeln. Per il suo progetto «stimmreise.ch», Nadja Räss ha preferito chitarra elettrica, basso e clarinetto a fisarmoniche e orga-netti.
Alla Festa federale dello jodel non sarebbe stata la benve-nuta. Dal 1952 lo Jodlerverband ha stabilito che all’evento, organizzato ogni tre anni, i soli strumenti di accompagna-mento ammessi sono la fisarmonica e il tipico Schwyzerör-geli. Troppo limitativo per Nadja Räss, che si è già esibita
Nadja Räss interpreta lo jodel fin dall’infanzia: «Lo jodel mi permette di esprimermi. È come se parlassi la mia lingua madre.»
accompagnata da una brass band e da un’orchestra classi-ca: «Faccio fatica a capire chi vuole imbrigliare la musica», dice la trentunenne. «Interessante notare come secoli fa ci fosse maggiore libertà. Allora lo jodel era accompagnato da pianoforte, cetra o violino», puntualizza.
Con il suo atteggiamento controcorrente, sulla scena jodel Nadja Räss ha sempre fatto discutere. «Per un certo periodo sono stata considerata la giovane cantante dai capelli rossi, un po’ stramba, che voleva provocare», ricorda, «mentre questa non era affatto la mia intenzione.» Al contrario: Nadja Räss ha grande rispetto per i canti antichi e tiene molto alla salvaguardia delle radici, vorrebbe però portare aria nuova nella tradizione. «Attraverso il confronto con il patrimonio di melodie antiche, è stato normale sviluppa-re nuove idee.»
Cresciuta a pane e jodelL’incontro di Nadja Räss con lo jodel risale a molto tempo fa. Sono cresciuti insieme. I genitori ascoltavano musica popolare, alle feste di famiglia si cantava. A soli sette anni
Uno jodel rockeggianteIl folclore svizzero vive una nuova primavera.L’Handörgeli (piccola, tipica fisarmonica), il cornodelle Alpi e lo jodel vanno di moda grazie a giovaniinterpreti di musica popolare, fra i quali latrentunenne cantante di jodel Nadja Räss, che simuove con grazia fra le note della tradizione.

11
La Svizzera stava a guardare, quando il nuovo re, Wenger Kilian,
ha steso nella segatura quello vecchio, Abderhalden Jörg.
Nadja inizia a prendere lezioni di jodel, partecipa a concor-si, a 13 anni appare per la prima volta alla TV svizzero-te-desca. Già allora afferma di voler diventare una cantante di jodel professionista. Siamo negli anni 80 e lo jodel è tutto fuorché di moda: «La musica popolare era la musica dei genitori, dunque irrimediabilmente out», racconta. Ma Nadja tiene duro: «Ho fatto quello che mi sentivo di fare, ho continuato a cantare. E un bel giorno, i miei compagni di scuola si sono accorti che lo jodel è proprio cool.»
Tonalità nuoveAll’inizio Nadja Räss canta le tipiche canzoni jodel, «era molto difficile identificarsi nei testi, insomma, fiorellini, mondo perfetto e roba del genere.» Con il passare del tempo inizia a interessarsi a pezzi armonicamente più complessi, sperimenta il cosiddetto Naturjodel e i canti antichi privi di testo e inizia a comporre: «Trovo eccitante contribuire alla letteratura dello jodel», afferma, «nello jodel si toccano quasi sempre temi positivi, mentre nei pezzi pop si parla anche di quello che nella vita non fun-ziona. Ho pensato che poteva funzionare anche nello jodel.» Ed ecco nascere una sua canzone che parla di di-spiaceri amorosi e della tristezza di essere lasciati. Musi-calmente segue nuove vie, trova ispirazione in altri generi, come per esempio nel folclore scandinavo: «Il linguaggio musicale delle mie canzoni è piuttosto malinconico.»
L’opera non fa per leiNel 2000 Nadja Räss ripensa ai suoi sogni di bambina e decide di fare sul serio. Visto che non esiste un curricolo di studio dello jodel, al conservatorio di Zurigo inizia gli studi di canto classico, che porta a termine con successo. Non la sfiora però mai l’idea di cambiare genere, anche se: «Gli esperti all’esame dissero che sembravo fatta apposta per l’opera. Ma quello non è il mio mondo.» Nadja Räss resta fedele allo jodel. Pubblica CD, va in scena duettando con Rita Gabriel e al momento è in tour con il suo proget- to di Naturjodel «stimmreise.ch».
Musica d’altri tempi? Macché!Oltre ai suoi progetti, Nadja Räss si occupa di diffondere lo jodel. Tiene corsi di uno o più giorni all’Accademia dello jodel, da lei stessa fondata. E ha successo: i suoi corsi, che non hanno luogo solo in campagna bensì anche in pieno centro a Zurigo, sovente sono già completi con settimane di anticipo. Ha scritto inoltre un trattato sull’apprendimento dello jodel «Jodel – Theorie und Praxis» e quest’anno ha organizzato un simposio sullo jodel. Lo scopo delle sue molteplici attività: «Vorrei che la popolazione si rendesse conto che lo jodel è tutto fuorché musica d’altri tempi. Anzi è fresco e attuale» ribadisce, «ed è ora che si ritorni a cantare le nostre canzoni popolari.»
www.jodel.ch, www.stimmreise.ch
Un Paese nella segaturaÈ tornato l’orgoglio di esibire la croce svizzera, sport rudi come la lotta svizzera rifioriscono, melodie popolari risuonano nelle città.
La tradizione è di moda. Insieme a Nadja Räss, gruppi come gli «Hujässler» oppure i «Familie Trüeb» mettono un po’ di pepe nella musica popolare. Anche la musica pop pare volere farsi contagiare dal folclore: il rapper Bligg si esibisce accompagnato da un corno delle Alpi e con i «Legändä & Heldä» ha fatto da colonna sonora alla Festa federale di lotta svizzera e delle tradizioni alpi-giane 2010. Il raduno dei «cattivi» ha avuto luogo a Frauenfeld davanti agli occhi di, udite udite, 250 000 spettatori. La televisione ha coperto l’evento con 18 ore di trasmissione, un vero record – e proprio come per i beniamini dei mondiali di calcio, per la prima volta ci si è scambiati le figurine per l’album «Der König». La lotta svizzera impazza! Visto il successo, perfino il conduttore televisivo Kurt Aeschbacher durante il suo programma si è infilato i caratteristici mutandoni e si è lasciato mettere sulla schiena e battere dal re, Wenger Kilian, anche se forse, volendo ...Il professore Walter Leimgruber, sociologo dell’Uni di Basilea, vede nel boom delle tradizioni una risposta alla globalizzazione e alla «illimitata offerta di cultura, media e intrattenimento ad essa collegata», come dichiarato alla NZZ. «Questa molteplicità dà anche insicurezza: da qui l’aumentato bisogno di radici, punti fermi e conferme.»

Quanta discrezione Twenty!Stavolta Twenty è tipicamente svizzero: soprattutto non si deve dare nell’occhio! Ma gli svizzeri sono davvero così? O stanno cambiando? Dì chiaro e tondo cosa pensi della Svizzera, delle sue tradizioni – e cosa si può fare per il nostro Paese: www.facebook.com/euro26.
Twen Svizzera è il supplemento speciale di euro26 pubblicato con Twen 4 inverno 2010, www.euro26.ch Editore SJAG, Berna Idea/Coordinazione gedankensprung, Berna Concetto/Realizzazione Basel West, Basilea Testo/Redazione Stephan Lichtenhahn, Basilea Traduzione Darma Lupi Stampa Büchler Grafino AG, Berna Foto swiss-image.ch/Monika Flueckiger pagg. 2, 11; Frédéric Giger pag. 9; andibrunner.com pag. 10 Illustrazioni Joel Büchli pagg. 1, 12Disclaimer SJAG non assume responsabilità alcuna per prezzi, offerte e contenuti redazionali di terzi
Twen Svizzera è pubblicato grazie a
Ehm, scusi, penso tocchi a me
Zitto e aspetta il tuo turno
Questa carne è orrenda! Immangiabile!
Posto occupatoBuonasera. Caro signore
liberi il sedile. Vorrei sedermi, ho avuto una
giornata pesante!
Ecco come si fa!Magari non dovrei arrendermi
così in fretta.
Mhm, niente male ...
Andava bene?
Scusi, le spiacerebbe spostare
il bagaglio?