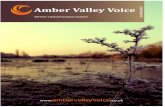sezione I civile; sentenza 28 aprile 1995, n. 4719; Pres. Cantillo, Est. Cicala, P.M. Buonaiuto...
-
Upload
giovanni-grasso -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of sezione I civile; sentenza 28 aprile 1995, n. 4719; Pres. Cantillo, Est. Cicala, P.M. Buonaiuto...

sezione I civile; sentenza 28 aprile 1995, n. 4719; Pres. Cantillo, Est. Cicala, P.M. Buonaiuto(concl. diff.); Zarrella (Avv. Acone) c. Soc. Feltrinelli (Avv. De Fusco). Cassa App. Napoli 7ottobre 1991Author(s): Giovanni GrassoSource: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 9 (SETTEMBRE 1995), pp. 2465/2466-2473/2474Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189020 .
Accessed: 24/06/2014 20:22
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.44.77.40 on Tue, 24 Jun 2014 20:22:12 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
di quest'ultimo quando la posizione del privato sia di interesse
legittimo. «La costante giurisprudenza di questa corte ha sempre affer
mato che il rapporto tra colui che aspira all'iscrizione all'albo
professionale e l'ordine preposto alla tenuta dell'albo medesimo
si identifica con la dicotomia diritto soggettivo-obbligo, anziché con quella interesse legittimo-potere pubblico.
«Infatti, l'ordine professionale non ha facoltà di valutare se
la chiesta iscrizione corrisponda all'interesse pubblico, ma ha
solo il compito di verificare se in realtà l'aspirante sia nel pos sesso dei requisiti appositamente voluti dalla legge, in quanto tale possesso è condizione necessaria e sufficiente per ottenere l'iscrizione la quale deve essere disposta se quei requisiti sussi
stano e deve essere invece negata nel caso contrario (Cass. 16
marzo 1978, n. 1322, id., Rep. 1978, voce cit., n. 58; 14 ottobre
1983, n. 5998, id., Rep. 1983, voce cit., n. 38; 23 febbraio 1990, n. 1399, id., 1990, I, 843).
«Né potrebbe essere diversamente, perché lo svolgimento di una qualunque attività professionale è espressione della genera le situazione di libertà assicurata dall'ordinamento italiano ad
ogni cittadino (art. 4 Cost.) in ordine alla scelta del lavoro.
«Può accadere — come è stato osservato da queste sezioni
unite (Cass. 14 ottobre 1983, n. 5998, id., Rep. 1983, voce cit., n. 38) — che, in un dato momento storico, certe attività, prima liberamente esercitabili, sembrino bisognose di una regolamen tazione nell'interesse generale e vengano perciò consentite sol
tanto a chi dimostri di essere capace e degno di esercitarle. Ma
qualunque diritto, appunto perché tale e non puro arbitrio o
irrilevante possibilità di agire, richiede di essere ancorato a de
terminati presupposti e circoscritto entro determinati limiti; l'im
portante è che, ove ricorrano i presupposti e siano osservati
i limiti, esso possa pienamente esercitarsi.
«Nel caso di specie, mentre non può negarsi — anche in virtù
dell'esplicita previsione normativa — che per quanto riguarda le iscrizioni all'albo professionale ad opera dei competenti con
sigli regionali (o provinciali) si è in presenza di un diritto sog gettivo dell'aspirante, si deve ritenere che l'intento di tutelare
in via immediata e diretta la posizione del cittadino italiano — o del cittadino di uno Stato membro della Cee o di uno
Stato con cui esiste trattamento di reciprocità (art. 7, lettera
a) — sussiste anche nell'ipotesi che l'iscrizione sia richiesta, in
periodo transitorio, al commissario nominato dal presidente del
tribunale ai sensi dell'art. 31.
«Depongono in tal senso: — il confronto con l'iscrizione decisa dai consigli regionali
(o provinciali), essendo logicamente incoerente negare l'esisten
za di un diritto soggettivo all'iscrizione in periodo transitorio,
dal momento che anche per tale periodo sono richieste le stesse
condizioni necessarie per l'iscrizione nel periodo "a regime", ove si eccettui il requisito dell'abilitazione all'esercizio della pro fessione di cui all'art. 7, lett. c) (impossibile per l'inesistenza,
per il passato, dell'esame di Stato), sostituito dal possesso dei
requisiti soggettivi elencati nelle lettere a), ti), c) e d) dell'art. 32; — le condizioni tassativamente prescritte per far luogo all'i
scrizione, il cui accertamento non implica valutazioni di caratte
re amministrativo, ossia scelte del comportamento più rispon denti all'interesse pubblico, ma solo l'individuazione di circo
stanze senza alcun margine di discrezionalità.
«Né in senso contrario alle raggiunte conclusioni può trarsi
argomento dal fatto che l'art. 32, lett. d), prevede l'iscrizione
a favore di soggetti "che abbiano operato per almeno tre anni
nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel cam
po specifico a livello nazionale o internazionale" e cioè sulla
base di una previsione per il cui accertamento il commissario
dispone di potestà discrezionale.
«È infatti sufficiente osservare che l'accertamento di ricono
scimenti a livello nazionale o internazionale non è indice di di
screzionalità amministrativa, allo stesso modo come si è ritenu
to che non sussiste tale discrezionalità per il fatto che l'iscrizio
ne in alcuni albi professionali è subordinata all'accertamento
del requisito della buona condotta dell'aspirante (cfr. giurispru
denza in precedenza citata): si tratta di discrezionalità tecnica
che non incide sul diritto soggettivo dell'interessato all'iscrizione».
Tali principi devono essere applicati con riferimento alla con
troversia relativa all'ammissione alla sessione speciale di esame
di Stato per titoli previsti dall'art. 33 della stessa 1. n. 56 del 1989.
Anche questa norma indica le condizioni al cui concorso è
Il Foro Italiano — 1995.
subordinata l'ammissione senza alcun margine di discrezionali
tà e senza che possa fondarsi il discrimine fra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa sull'applicabilità a taluni o
a tutti i partecipanti del requisito relativo allo svolgimento per almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo, dal momento che anche nell'accertamento di tale
requisito — cosi come per il requisito di cui al precedente art.
32, iett. d) — si è in presenza non già di una discrezionalità amministrativa, ma di una discrezionalità tecnica che non inci
de sul diritto soggettivo dell'interessato all'ammissione alla ses
sione speciale. Allo stesso modo non contiene alcun margine di discreziona
lità amministrativa l'accertamento degli altri requisiti previsti dallo stesso art. 33.
In accoglimento del ricorso va quindi dichiarato che la tutela
giurisdizionale delle ragioni di colui che chiede l'ammissione al
la sessione speciale dell'esame di Stato per titoli di cui all'art.
33 1. n. 56 del 1989 spetta al giudice ordinario, istituzionalmen te competente in tutte le controversie su diritti soggettivi (art. 2907 c.c. e 1 c.p.c.), anche in via di urgenza.
A lui spetta altresì di provvedere, con pienezza di poteri e
quindi anche con pronunce di condanna ad ammettere al con
corso in quanto non gli sono opponibili i noti limiti che la 1.
20 marzo 1865 n. 2248, ali. E, ha posto a salvaguardia dell'atti vità dicrezionale amministrativa.
Allo stesso giudice compete altresì stabilire — in sede di in
terpretazione della normativa applicabile — se il requisito dello
svolgimento per almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo debba essere posseduto da tutti
coloro che sono indicati nella lettera b) dell'art. 33 o non sia
richiesto per coloro che siano in possesso della laurea in psico
logia da almeno due anni.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 28 aprile
1995, n. 4719; Pres. Cantillo, Est. Cicala, P.M. Buonaiu
to (conci, diff.); Zarrella (Aw. Acone) c. Soc. Feltrinelli (Aw. De Fusco). Cassa App. Napoli 7 ottobre 1991.
Ingiunzione (procedimento per) — Opposizione — Termini di
comparizione — Abbreviazione da parte del giudice — Am
missibilità (Cod. proc. civ., art. 163 bis, 645).
Il potere di abbreviazione dei termini di comparizione nelle cau se che richiedano pronta spedizione, attribuito al giudice dal
l'art. 163 bis, 2° comma, c.p.c., è applicabile anche al termi
ne già ridotto alla metà per l'opposizione a decreto in
giuntivo. (1)
(1) Con la decisione in rassegna, la Cassazione muta consapevolmen te il proprio orientamento in ordine al problema della cumulabilità, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, della dimidiazio
ne legale dei termini di comparizione ex art. 645, 2° comma, c.p.c. con l'ulteriore abbreviazione fino alla metà dei termini con provvedi mento del presidente del tribunale (o del pretore o del conciliatore ed
oggi del giudice di pace), ex art. 163 bis, 2° comma, c.p.c. e 70 disp. att.
Finora la giurisprudenza di legittimità, nelle poche occasioni in cui
aveva avuto occasione di occuparsi della questione in sé di poco conto, ma foriera di gravissime conseguenze pratiche — aveva assunto un at
teggiamento negativo: cosi la prima decisione di cui consti in materia, e cioè Cass. 19 gennaio 1956, n. 163, Foro it., Rep. 1956, voce Ingiun
zione (procedimento per), n. 80, e Giusi, civ., 1956, I, 418 e 868, con
nota contraria di P. D'Onofrio e la successiva 5 maggio 1961, n. 1023, Foro it., 1961, I, 912. La giurisprudenza di merito ha finito per lo
più per l'adeguarsi tralatiziamente al ricevuto orientamento: cfr. App. Milano 18 dicembre 1956, id., Rep. 1957, voce cit., n. 45; App. Roma
29 gennaio 1960, id., 1960, I, 1818.
This content downloaded from 185.44.77.40 on Tue, 24 Jun 2014 20:22:12 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

2467 PARTE PRIMA 2468
Svolgimento del processo. — Il sig. Luigi Zarrella proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente ese
cutivo emesso dal presidente del Tribunale di Benevento che
gli intimava il pagamento della somma di lire 141 milioni in favore della s.p.a. f.lli Feltrinelli. L'opposta eccepiva prelimi narmente la nullità della citazione in opposizione per la insuffi
cienza del termine a comparire (nove giorni), in quanto doveva
ritenersi inefficace il provvedimento del presidente del tribunale
che aveva ridotto alla metà il termine già ridotto ex art. 645,
2° comma, c.p.c. Il tribunale dichiarava la nullità della citazione in opposizio
ne e la sentenza era confermata dalla Corte d'appello di Napo
In senso contrario, invece, la dottrina prevalente — alla quale dichia ratamente ha finito per aderire la pronuncia in rassegna — a comincia re dalla ricordata nota di D'Onofrio, Irriducibilità dei termini di com
parizione di cui all'art. 645 c.p.c.?, in Giust. civ., 1956, I, 868 e da
V. Andriou, Commento al codice di procedura civile3, Napoli, 1964,
IV, 71. Cosi pure F. Garbagnati, Il procedimento di ingiunzione, Mi
lano, 1991, 153 e P. Pajardi, Il procedimento di ingiunzione, Milano, 1991, 88 e — sia pure dubitativamente — C. E. Balbi, Ingiunzione (procedimento di), voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989, XVII, 11. Contra, isolatamente e sulle orme della (previgente) giuris prudenza, V. G. Ebner - C. Filadoro, Manuale del procedimento di
ingiunzione, Milano, 1990, 123.
♦ * *
Opposizione a decreto ingiuntivo ed abbreviazione «fino al quarto» dei termini di comparizione (sulla compatibilità tra l'art. 645, 2° com
ma, c.p.c. e l'art. 163 «bis», 2° comma, c.p.c.).
Con la sentenza in rassegna (1) la Suprema corte — modificando il proprio anteriore ancorché ormai risalente orientamento in materia (2) — ha ritenuto che il potere di abbreviazione dei termini a comparire nelle cause che richiedono pronta spedizione — in generale previsto dall'art. 163 bis, 2° comma, c.p.c. per il procedimento ordinario di
primo grado dinanzi al tribunale — è riferibile anche al procedimento monitorio, nel quale pure vige la generale ed astratta facoltà, concessa
all'opponente, di avvalersi della riduzione dei termini alla metà, giusta la previsione dell'art. 645, 2° comma, c.p.c.
Il precedente orientamento dei giudici di legittimità (3), cui le poche decisioni di merito succedutesi nel tempo si sono pedissequamente ade
guate (4), riteneva che l'art. 645 c.p.c., nel dettare i modi e le forme della opposizione a decreto ingiuntivo, esaurisse la disciplina dei termi ni a comparire, prevedendone una volta e per tutte la dimidiazione ope legis, salvo diverso avviso dell'opponente, a cui favore la norma opera istituendo una mera facoltà di abbreviazione, che automaticamente in fluisce anche sulla determinazione dei termini di costituzione in
giudizio (5).
(1) La sentenza si legge anche in Corriere giur., 1995, 682 ss., con commento di V. Carbone, Opposizione ad ingiunzione: applicabilità dell'art. 163 bis, 2° comma, c.p.c.
(2) In motivazione, i giudici di legittimità si dimostrano consapevoli della lontananza temporale dei precedenti in materia («questa corte ha ritenuto, in un passato ormai remoto . . .»), manifestando il dichiarato intento di superarli, valorizzando le contrarie indicazioni della dottrina
(«La dottrina ha, però, avvertito . . .»). Sul punto, il primo commentatore della sentenza — che tra l'altro
faceva parte del collegio giudicante — dopo aver puntualizzato la con
sapevolezza del mutamento di indirizzo interpretativo, ne sottolinea il
possibile «effetto perverso», trattandosi di diverse interpretazioni di norme
processuali, con consequenziale aumento di incertezza negli operatori pratici. Al tempo stesso, peraltro, sottolinea come tale ultimo pericolo sia in gran parte superato dalla circostanza che non pare — salvo un
pur invocato intervento chiarificatore delle sezioni unite, che negli au spici di chi scrive non potrà che confermare la svolta — che si tratti di conflitto sincronico di interpretazioni, ma piuttosto di «fisiologico contrasto diacronico, indirizzato alla evoluzione» (in termini, V. Car
bone, Opposizione, cit., 683, con terminologia mutuata dal Chiarloni). (3) La prima pronuncia in materia è quella di Cass. 19 gennaio 1956,
n. 163, Foro it., Rep. 1956, voce Ingiunzione, n. 80 e Giust. civ., 1956, I, 418 e 868, con nota contraria di D'Onofrio, Irriducibilità dei termini di comparizione di cui all'art. 645 c.p.c.?
Nello stesso senso, successivamente, Cass. 5 maggio 1961 n. 1023, Foro it., 1961, I, 912.
(4) Cfr. App. Milano 18 dicembre 1956, Foro it., Rep. 1957, voce
Ingiunzione, n. 45; App. Roma 29 gennaio 1960, id., 1960, I, 1818; App. Napoli 17 ottobre 1991, n. 2153, inedita, confermativa di Trib. Benevento 8 novembre 1988 ora cassata.
(5) Contra, nel senso della obbligatorietà della riduzione ope legis dei termini di comparizione, E. Garbagnati, I procedimenti d'ingiun
Ii Foro Italiano — 1995.
li, la quale osservava: che il potere di abbreviazione dei termini
di comparizione nelle cause che richiedono pronta spedizione, attribuito dall'art. 163 bis, 2° comma, c.p.c., non è riferibile
alle controversie d'opposizione a decreto ingiuntivo stante per
queste l'astratta ed autonoma riduzione legislativa disposta dal
l'art. 645 c.p.c. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione
lo Zarrella deducendo un unico motivo. Resiste la s.p.a. f.lli
Feltrinelli. Motivi della decisione. — Parte ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione dell'art. 645, 2° comma, c.p.c. e dell'art.
163 bis, 2° comma, c.p.c. asserendo che erroneamente la corte
In tale quadro, il testuale richiamo effettuato dalla disposizione in
esame alle «norme del procedimento ordinario davanti al giudice adi
to», viene bensì' inteso come complessivamente riferito agli art. 163 ss., ma con esclusione della disciplina della abbreviazione dei termini, che non sarebbero in materia quelli del 1° comma dell'art. 163 bis, ma quelli — autonomamente previsti e sia pure calcolati per relationem — del l'art. 645, 2° comma, ultima parte, c.p.c.
A riprova della correttezza della riassunta argomentazione, si soste neva che l'art. 313 del codice di rito — nella formulazione anteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni novellate ex 1. 353/90 —
dopo aver disposto che nel giudizio dinnanzi al pretore e al conciliatore i termini di cui all'art. 163 bis sono ridotti alla metà, per consentire l'ulteriore possibilità di abbreviazione fino alla metà dei termini gfà cosi ope legis ridotti, era costretto a prevedere espressamente tale possi bilità, che invece non era prevista in materia di opposizione a decreto
ingiuntivo. In realtà, i giudici di legittimità riconoscono oggi — sulla scorta di
autorevoli sollecitazioni dottrinarie (6) — che dietro questo modo di
ragionare si celava un equivoco. Il presupposto del ragionamento era, invece, il carattere di specialità
della disposizione di cui all'art. 645 c.p.c., e con esso dei casi in cui il legislatore consente il potere giudiziale di abbreviazione dei termini
zione e per convalida di sfratto, 165 ss. nonché II procedimento di in
giunzione, Milano, 1991, 152. Nel senso del testo la dottrina e la giuri sprudenza assolutamente prevalenti: cfr. per tutti C. Mandrioii, Corso di diritto processuale civile, Torino, 1993, III, 189 e, in giurisprudenza, Cass. 7 aprile 1987, n. 3355, Foro it., Rep. 1987, voce Ingiunzione, n. 38, nonché Trib. Catania, ord. 31 agosto 1992, id., 1993, I, 584
ss., che ne ha dedotto che, ove l'opponente non abbia esercitato la facoltà di abbreviazione di cui all'art. 645, 2° comma, c.p.c. — ed
abbia, come nella specie, subito anzi l'istanza della controparte volta alla anticipazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 163 bis, 3° comma, c.p.c., non possa pretendere la costituzione dell'opposto prima della scadenza del termine minimo di comparizione ridotto alla metà.
Cfr. altresì già Cass. 14 marzo 1964, n. 581, id., Rep. 1964, voce
cit., n. 66, e Giust. civ., 1964, I, 1620; 3 agosto 1973, n. 2255, Foro
it., 1974, I, 1764 e 17 novembre 1971, n. 3286, id., 1972, I, 633, con nota di M. Acone, In tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
(6) Cfr. soprattutto D'Onofrio, loc. ult. cit., secondo il quale l'art. 645 non potrebbe interpretarsi nel senso di prevedere una autonoma
disciplina dei termini, ma va piuttosto letto congiuntamente all'art. 163 bis, con il quale fa corpo in virtù dell'espresso richiamo alle norme in tema di procedimento ordinario di cognizione. Lo stesso autore trae va conferma della sua tesi dalla previsione dell'art. 313 c.p.c. e dall'ul teriore argomento secondo cui la tutela della riduzione dei termini a metà può rivelarsi insufficiente in tutti quei casi in cui il debitore debba subire la provvisoria esecuzione, per la revoca della quale deve attende re la nomina del giudice istruttore. Sul pensiero di questo autore e sulla
replica della Cassazione, che si diede subito cura «di rintuzzare punto per punto le critiche della dottrina, negando le antinomie che le erano state addebitate», cfr. Carbone, Opposizione, cit., 685.
Significativa l'opinione di V. Andrioli, Commentario al codice di
procedura civile5, Napoli, 1964, IV, 71, secondo il quale — al di là ed oltre della dimidiazione legale dei termini ed indipendentemente dal la ratio di tale riduzione — non è da escludere che sussistano e meritino
adeguata tutela ragioni di urgenza che giustifichino caso per caso la
pronta spedizione e la riconnessa abbreviazione dei termini di una ulte riore metà. Implicitamente nello stesso senso, ma senza motivazione, Id., Diritto processuale civile, Napoli, 1979, I, 753 e Id., Codice di procedura civile e norme complementari, Milano, 1978, sub art. 645.
Nello stesso senso, cfr. Garbagnati, Il procedimento, cit., 153 e P.
Pajardi, Il procedimento di ingiunzione, Milano, 1991, 88, nonché, sia pure in termini sfumatamente dubitativi, C. E. Balbi, Ingiunzione (procedimento di), voce dell'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989, XVII, 11.
Contra, isolatamente e sulle orme della precedente giurisprudenza, V. G. Ebner - C. Filadoro, Manuale del procedimento di ingiunzione, Milano, 1990, 123.
This content downloaded from 185.44.77.40 on Tue, 24 Jun 2014 20:22:12 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ha ritenuto non esercitabile il potere di abbreviazione dei termi
ni ex art. 163 bis, 2° comma, c.p.c. Richiede quindi che, modi ficando una vecchia giurisprudenza, questa corte, in conformità
all'opinione della dottrina, affermi che il potere di abbreviazio
ne dei termini di comparizione nelle cause che richiedono pron ta spedizione, attribuito dall'art. 163 bis, 2° comma, c.p.c., sia esercitabile anche nelle controversie d'opposizione a decreto in
giuntivo, nonostante per queste sia già prevista l'astratta ed au
tonoma riduzione legislativa dall'art. 645 c.p.c. La questione è indubbiamente rilevante dal momento che la
nullità della citazione, quale quella derivante dalla inosservanza
del termine di comparizione, è sanata dalla costituzione del con
dilatori per ritenute e motivate ragioni di urgenza (7). Nello stesso tem
po, sotto un profilo sistematico e al di là del dettato normativo, si riteneva che la ratio della disposizione di cui all'art. 645 c.p.c. fosse
quella secondo cui in tema di opposizione a provvedimento monitorio il legislatore si fosse automamente ed una volta per sempre fatto carico delle speciali ragioni di urgenza che caratterizzano tale procedimento, cosi implicitamente escludendo che una ulteriore delibazione delle esi
genze di pronta spedizione potesse essere compiuta, di volta in volta e con riguardo alle specificità del caso concreto, dal giudice.
In realtà i riassunti presupposti — e cosi pure l'argomento letterale che ne era alla base — risultano, ad una analisi più approfondita, fallaci.
1) Innanzitutto, occorre precisare che la ragione giustificatrice della
generalizzata riduzione dei termini in materia di opposizione a decreto
ingiuntivo è diversa da quella che consente il potere giudiziale di abbre viazione del termine dilatorio di comparizione.
Nel primo caso, infatti, la riduzione si giustifica per il fatto che en trambe le parti — cioè l'originario ricorrente, che diviene opposto, e il destinatario dell'ingiunzione, che si fa attore in opposizione — «han
no già avuto modo di presentare i propri argomenti difensivi», cosicché «non vi è più ragione di differire l'istruzione della causa» (8). Non si tratta, dunque, di una generalizzata valutazione legislativa delle spe ciali ragioni di urgenza che caratterizzerebbero — di contro all'ordina rio giudizio di cognizione — il procedimento monitorio, ma semplice mente di una opportuna modalità di accelerazione del procedimento, che si giustifica per le diverse modalità della sua instaurazione, in cui l'atto introduttivo ha la forma della citazione e la sostanza di una com
parsa di risposta (9). Ben diversa è la ratio sottesa al potere dell'attore di sollecitare —
nelle forme di cui al 2° comma dell'art. 163 bis c.p.c., coordinato al
l'art. 70 disp. att. — l'abbreviazione fino alla metà dei termini a com
parire, che si giustifica per quelle esigenze di pronta spedizione della
causa che davvero concretano, nella mediazione della delibazione giudi ziale, ragioni di urgenza.
Ed allora, poiché l'art. 645 effettua un complessivo e generalizzato richiamo alle norme dettate in tema di giudizio ordinario di cognizione, la non applicabilità della abbreviazione dei termini su istanza di parte dovrebbe dedursi a) o dalla espressa esclusione ad opera dello stesso art. 645 ovvero b) dalla incompatibilità tra le due previsioni ovvero, infine, c) dalla identità di ratio della disposta abbreviazione, per evitare una inammissibile duplicazione.
Ebbene, da quanto precede si deduce — come la corte ha finito per riconoscere — che a) l'art. 645 c.p.c. inequivocabilmente richiama il
complesso delle norme dettate per il procedimento ordinario sicut et
(7) In generale, sui termini nel processo civile, sulla distinzione tra termini perentori, ordinatori e dilatori, v., da ultimo, N. Picardi - R. Martino, Termini. I) Diritto processuale civile, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1994, XXXI, secondo cui la modificazione dei termini dilatori, quali sono quelli di comparizione — dilatorio es
sendo, infatti, il termine per cui «l'effetto, sul piano ontologico, rima ne uguale a se stesso ed il termine si limita a «paralizzare» temporanea mente l'effetto di un atto completo nei suoi elementi essenziali» (cfr. p. 3) —
può avere origine legale (come nel caso dei termini di compari zione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo o davanti al giudi ce di pace, giusta il novellato art. 318 c.p.c.) ovvero giudiziale (come nel caso dell'art. 163 bis in relazione all'art. 70 disp. att. (p. 10). Gli
autori in parola non prendono, peraltro, posizione sulla questione —
che è invece risolutiva del problema in discussione — se il potere di abbreviazione legale e quello giudiziale siano cumulabili, salvo lo spun to inteso a valorizzare l'idea che, al di là delle disposizioni particolari, «sembra possibile rintracciare nel sistema l'esistenza di un generale po tere giudiziale dei termini dilatori»: ma in tema di termini a comparire occorre tener conto del carattere eccezionale e non suscettibile di appli cazione analogica ex art. 14 prel. delle norme che prevedono la facoltà di abbreviazione (di cui gli autori citati sono del resto consapevoli).
(8) Cosi espressamente la motivazione della sentenza la quale fa pro prie le osservazioni della dottrina: cfr. testualmente, nello stesso senso, Balbi, cit., 11. La diversità di ratio delle due distinte abbreviazioni dei termini è colta da Andrioli, op. cit., 71.
(9) Cfr. Mandrioli, Corse?, cit., 187.
Il Foro Italiano — 1995.
venuto ex nunc, con salvezza dei diritti anteriormente quesiti
(art. 164, 2° comma, c.p.c.); pertanto, con riguardo a doman
da la cui proposizione sia soggetta a termine perentorio, il veri
ficarsi di detta costituzione, dopo la scadenza di tale termine, non osta alla inammissibilità della domanda medesima (Cass. 2 febbraio 1993, n. 1270, Foro it., Rep. 1993, voce Citazione civile, n. 10).
Il motivo di ricorso merita accoglimento. Infatti l'art. 645
c.p.c. inequivocamente richiama il complesso delle norme det
tate per il procedimento ordinario, e per ciò anche l'art. 163 bis, 2° comma, che prevede e disciplina Pabbreviabilità dei termini
di comparizione.
in quantum, e per ciò anche l'art. 163 bis, 2° comma, che quindi non
può ritenersi fuori gioco sol perché l'ultima parte dell'art. 645 si occupa dei termini a comparire, operandone una generalizzata se pur facoltati va dimidiazione (10); b) non sussiste alcuna incompatibilità — né sul
piano logico né sul piano giuridico — tra le due riduzioni dei termini
(tant'è che — come si è accennato — il cumulo delle stesse era espressa mente previsto in materia di giudizio dinanzi al pretore e al conciliato
re); c) la ratio delle due abbreviazioni — l'una riconnessa alla «natura» del procedimento monitorio, e per ciò operante su un piano generale ed astratto e quindi ope legis; l'altra legata alle ragioni di speciale ur
genza emergenti dal caso singolo, e perciò operante su istanza di parte ed ope iudicis — è del tutto diversa e non incompatibile.
2) È chiaro, allora che il vecchio argomento letterale secondo cui all'art. 313 c.p.c. nella previgente formulazione potesse e dovesse desu mersi la volontà legislativa di escludere la doppia riduzione dei termini a comparire nel procedimento per decreto (giusta il tradizionale argo mentum a contrarìis, secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, cosicché — in definitiva — ubi lex distinguit, et nos distinguere debe
mus) va del tutto ribaltato: ed anzi proprio la previsione della disposi zione in parola induce l'interprete, rispettoso del sistema positivo, alla
più generale configurazione di una fattispecie riduttiva dei termini a
comparire che non può non assumere carattere paradigmatico anche
ai fini della lettura dell'art. 645 c.p.c. In buona sostanza, la dimidiazione per legge dei termini a comparire
si giustificava, per i giudizi pretorili e davanti al conciliatore, sulla base delle esigenze di semplificazione e snellimento dei procedimenti davanti
a giudici monocratici (che oggi, tra l'altro, sono in generale venute me
no, residuando solo in materia di giudizi dinnanzi al giudice di pace) e, per i procedimenti monitori, sulla base delle diverse ragioni sopra riassunte; in entrambi i casi non risulta contraddittorio ammettere una delibazione giudiziale delle eventuali esigenze di pronta spedizione, co
me ex professo aveva fatto il legislatore all'art. 313 c.p.c. e come ben
poteva ritenersi anche per l'art. 645 c.p.c., in cui la legge, in buona
sostanza, minus dixit quam voluit. Per tal via, è da ritenere che oggi l'art. 318, 2° comma, c.p.c. —
come riformulato dalla 1. 353/90 e dalla 1. 375/91, vada interpretato nel senso che la riduzione alla metà dei termini di comparizione dinanzi al giudice di pace, non escluda il provvedimento — a rendersi su istan za di parte dallo stesso giudice di pace nelle forme del decreto motivato
apposto in calce all'originale e alle copie notificate, in analogia con
quanto olim disposto dal previgente art. 313, in coordinato disposto con l'art. 163 bis, 2° comma, c.p.c. e 70 disp. att. — di ulteriore abbre
viazione dei termini per motivate ragioni di urgenza (11).
3) La soluzione favorevole al «cumulo delle riduzioni» (e, quindi,
(10) Cass. 4 novembre 1993, n. 10920, Foro it., Rep. 1993, voce Ri scossione delle imposte, n. 153, ha precisato — in materia di opposizio ne ad ingiunzione doganale prevista dall'art. 82 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 — che la stessa instaura un ordinario processo di cognizione le cui disposizioni sono, quindi, integralmente applicabili, in mancanza di diversa e specifica disposizione normativa, ivi comprese quelle relati ve ai termini di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c.; pertanto, non può ritenersi applicabile — pena la nullità della citazione, sanabile solo e con effetti ex nunc dalla costituzione del convenuto — il disposto dell'art. 645 c.p.c., che riduce a metà i termini di comparizione di cui al precitato art. 163 bis, atteso che le regole del procedimento di oppo sizione al decreto ingiuntivo, data la loro specialità, non sono suscetti bili di applicazione analogica. Se ne può dedurre — con agevole argo mento a contrarìis — che, ove operi congiuntamente la riduzione alla metà dei termini per espresso disposto di legge ed il richiamo a tutte le altre norme in tema di procedimento ordinario di cognizione, nulla osta — salvo incompatibilità logiche o giuridiche, nella specie inesisten ti — alla contemporanea operatività della ulteriore facoltà di riduzione
giudiziale. (11) In questo senso, B. Capponi, in II giudice di pace (a cura di
M. Acone), Napoli, 1992, 190; F. P. Luiso, (C. Consolo - B. Sassa
ia), La riforma del processo civile, Milano, 1993, II, 304; G. Verde - F. Di Nanni, Codice di procedura civile, Torino, 1993, 301. Contra, isolatamente, A. Attardi, Le nuove disposizioni sul processo civile, Milano, 1991, 133. Per altre citazioni, cfr. Carbone, Opposizione, cit.,
685, nota 14.
This content downloaded from 185.44.77.40 on Tue, 24 Jun 2014 20:22:12 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

2471 PARTE PRIMA 2472
Quest'ultima norma potrebbe ritenersi esclusa dal complessi vo e sintetico richiamo in parola solo in presenza di un esplicito
divieto; ovvero se puntuali argomentazioni, tratte dalla ratio
di detta disposizione, dimostrassero l'incompatibilità tra le due
previsioni. In difetto della prima ipotesi, questa corte ha ritenuto, in
un passato ormai remoto, che la predetta inconciliabilità di
scendesse dalla previsione della autonoma riduzione alla metà
dei termini in questione per esplicita affermazione normativa, ravvisando un'incompatibilità logica e giuridica tra la norma
che riduce alla metà tutti questi termini e la eventualità che
essi possano, al ricorrere di speciali motivi di urgenza, subire
ulteriori contrazioni.
in pratica, alla abbreviabilità fino a un quarto dei termini a comparire concessi dall'opponente all'opposto) non comporta — come invece sembra adombrato dalla giurisprudenza favorevole all'opposto orientamento —
una «notevole limitazione del diritto di difesa» (12): a tutto tacere, val
ga di nuovo a fugare ogni dubbio in tal senso il già sviluppato richiamo all'art. 313 c.p.c. (ed oggi all'art. 318 c.p.c.) ed alla sua attitudine a
configurare un «modello» interpretativo generale in ordine alla abbre viazione «congiunta» dei termini per ragioni di specialità del procedi mento e per concomitanti e non incompatibili esigenze di pronta spedi zione (norma e modello, detto per inciso, in riguardo ai quali non sem
bra siano mai stati prospettati né possano in concreto prospettarsi seri dubbi di costituzionalità).
4) La citata App. Napoli 7 ottobre 1991, n. 3153 ritiene confermati
va, se pur indirettamente, della correttezza della soluzione antitetica
a quella fin qui prospettata la decisione della Corte costituzionale con
cui è stata di recente dichiarata la manifesta infondatezza della questio ne di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 415,
3°, 4° e 5° comma, c.p.c. e 645, 2° comma, c.p.c. in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentono all'attore in opposi zione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro sottoposti alla disciplina
processuale di cui agli art. 409 ss. c.p.c. di ottenere la riduzione della
metà dei termini di comparizione (13).
L'argomento prova palesemente troppo, come ha tra l'altro osserva to la Cassazione, cogliendo lo spunto per ribadire — anche sulla scorta della ricordata pronunzia del giudice delle leggi — l'orientamento giuris prudenziale prevalente secondo cui in materia di crediti di lavoro non
è ammessa la facoltà dell'opponente a decreto ingiuntivo di avvalersi
della abbreviazione dei termini di cui all'art. 645, 2° comma, c.p.c. (14), per ragioni che hanno a che fare con la specialità del rito del lavoro — in cui il rispetto del termine di comparizione non dipende esclusiva mente dall'attività dell'opponente, ma anche degli uffici giudiziari coin volti nel procedimento (15).
In altri termini, ove non operi la dimidiazione legale dei termini per motivi di ordine strumentale (soprattutto riconnessi alla circostanza del la mancata operatività della vocatio in ius ad udienza fissa, che è quella che poi — introdotta dalla novella del '50 — è all'origine della questio ne in discussione (16)), è ovvio che non possa operare l'ulteriore mec
(12) Cosi, invece, App. Napoli 7 ottobre 1991, cit.
(13) Cfr. Corte cost., ord. 28 luglio 1988, n. 936, Foro it., 1989, I, 2670, con nota di richiami.
(14) In giurisprudenza, cfr., da ultimo, Cass. 2 aprile 1990, n. 2637, Foro it., 1990, I, 3197, e Giust. civ., 1990, I, 1713, con nota di Murra e già Trib. Napoli 14 maggio 1986, Foro it., 1986, I, 2909.
(15) La richiamata giurisprudenza argomenta nel senso che nel rito del lavoro «centrale [. . .] è il decreto del giudice che fissa l'udienza di discussione, decreto che non sussiste nel rito ordinario e che non può diventare, per la sua centralità, solo un momento accessorio e con
seguenziale della riduzione a metà del termine di comparizione dell'art.
645, 2° comma»: cosi, in motivazione, Cass. 2 aprile 1990, n. 2637, cit.
(16) Cfr. sul punto le osservazioni di Carbone, op. cit., 684. Cfr., altresì', Mandrioli, Corso'', cit., 189, nota 10, il quale rammenta che «occorre tener presente che il testo originale della norma — nel quadro di un sistema di vocatio in ius che non prevedeva la citazione a udienza fissa — configurava la riduzione alla metà del termine di costituzione, e che il legislatore della "novella" del 1950, introducendo la citazione a udienza fissa e cosi configurando il termine di comparizione, aveva creduto di risolvere il problema prevedendo la costituzione di quest'ul timo termine anziché di quello di costituzione». L'autore ritiene, cosi, che tale operazione legislativa avrebbe condotto da un lato alla incon
gruità della riduzione alla metà di un termine dilatorio, dall'altro avrebbe lasciato un vuoto rispetto al termine di costituzione, vuoto colmato da
giurisprudenza e dottrina sul fondamento, per la verità non univoco, dell'art. 165 c.p.c. (indirettamente richiamato dall'art. 645 c.p.c.), ove è disposta la riduzione dei termini di costituzione in caso di abbrevia zione dei termini di comparizione. Il discorso è condivisibile — cosi come il rimedio alla indubbia situazione di vuoto normativo — an
II Foro Italiano — 1995.
La dottrina ha però avvertito che non possono senza fondato
motivo disconoscersi le speciali ragioni di urgenza, idonee a con
sentire e giustificare la pronta spedizione della causa, tanto da
indurre il giudice ad abbreviare i termini di comparizione su
istanza anche dell'attore.
In altre parole, la contemporanea applicabilità dell'art. 645, 2° comma, e dell'art. 163 bis, 2° comma, c.p.c. è resa possibile dalla diversità di ragioni giustificatrici che sorreggono le due distinte riduzioni dei termini: la prima genericamente ed astrat
tamente riconnessa alla peculiarità della fattispecie processuale di opposizione all'ingiunzione, in cui, com'è noto, entrambe le
parti hanno già avuto modo di presentare i propri argomenti difensivi e non vi è più ragione di differire l'istruzione della
canismo abbreviato ad istanza di parte codificato dall'art. 163 bis c.p.c, senza che ciò autorizzi — con generalizzazione del tutto impropria —
ad inferirne ulteriori conseguenze per l'ipotesi in cui l'art. 645, 2° com
ma, c.p.c. sia invece operante. Piuttosto è il caso di rammentare in questa sede — senza pretese
di approfondimento — come proprio la premessa della inoperatività della riduzione legale dei termini a comparire in materia di crediti di
lavoro debba, nonostante l'orientamento giurisprudenziale prevalente ed il peso di autorevoli opinioni dottrinarie in questo senso, ritenersi non del tutto certa: né manca in dottrina chi valuta criticamente la
«disapplicazione» dell'art. 645, 2° comma, c.p.c. nella materia de
qua (17).
5) Un'ultima notazione merita opportuno rilievo. I giudici di legitti mità hanno valorizzato il principio secondo cui non può farsi pagare alla parte incolpevole, che vi abbia fatto affidamento, l'errore del giu dice. Nella specie, in altri termini, svolgendo il discorso che in sentenza è rimasto assorbito dalle considerazioni che precedono, anche ove si volesse ritenere inammissibile la riduzione, ad opera del presidente del
tribunale, dei termini di comparizione già ridotti alla metà — ed abusi
vo il connesso decreto motivato —, non per questo potrebbero farsi
gravare sull'incolpevole opponente — che si è limitato a formulare una
richiesta e a vedersela accolta — le conseguenze della nullità derivata
dell'atto introduttivo della fase di opposizione, con la relativa inammis sibilità della opposizione ed il passaggio in giudicato (rectius: il conse
guimento di irretrattabile efficacia esecutiva) del decreto (oggi, peral tro, a differenza di quanto ritenuto in sentenza per il vecchio rito, tem
perata dalla operatività ex tunc della sanatoria, giusta il nuovo art.
164 c.p.c. (18)).
corché lasci perplesso il rilievo della generale incongruità della riduzio ne di termini dilatori: ché anzi la modificazione abbreviativa per questo tipo di termini è fenomeno ricorrente e, secondo alcuni, addirittura ge neralizzabile al di là delle ipotesi tipizzate; cfr. Picardi - Martino, cit., 10.
Occorre altresì, ricordare — con più specifico riguardo al problema della «cumulabilità» della abbreviazione legale e giudiziale di cui al l'art. 645, 2° comma, e 163 bis, 2° comma, c.p.c. — che in certa misu ra la questione esula dalla modifica delle modalità della citazione intro dotte dalla novella e non può esservi integralmente ricondotto: basti
pensare alla precedente formulazione dell'art. 313 c.p.c., che prevedeva la «doppia riducibilità» in un sistema che, ancor prima della novella e della modifica del meccanismo introduttivo per i giudizi dinnanzi al
tribunale, già era strutturato secondo le modalità della citazione ad udien za fissa.
(17) Sul punto, giova rimandare alle pagine di G. Pezzano, Crediti di lavoro e procedimento monitorio, in / processi speciali. Studi offerti a Virgilio Andrioli dai suoi allievi, Napoli, 1979, 239 ss., spec. 275
ss., ove anche il richiamo all'opinione favorevole alla applicabilità della abbreviazione di V. Andrioli (A. Proto Pisani - G. Pezzano - C. M.
Barone), Le controversie in materia di lavoro2, Bologna-Roma, 1974, 19-20 e sfavorevole di A. Proto Pisani, Problemi di coordinamento
posti dal rito speciale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1974, I, 420 (e in Studi di diritto processuale del lavoro, Milano, 1976, 216 ss., spec. 225) e di G. Arieta, Procedimenti monitori e cautelari e rito del lavo
ro, in II processo di lavoro nell'esperienza della riforma, Milano, 1985, 89 ss., spec. 109.
Più di recente, v. le contrarie opinioni di G. Tarzia, Manuale del diritto del lavoro, Milano, 1987, 255 e di C. A. Nicoletti, Giustizia del lavoro, Torino, 1987, da un lato, e di Balbi, cit., 15, sia pure in termini dubitativi. Ritengono che «tra le varie opinioni prospettate cir ca l'applicabilità della riduzione a metà dei termini [. . .] appare prefe ribile quella che ritiene la norma inoperante» A. Carrato - A. Di Fi
lippo, Il processo del lavoro, Milano, 1993, 221. (18) La sentenza in rassegna argomenta la rilevanza, nel caso concre
to, della questione sollevata, muovendo dal rilievo che la costituzione del convenuto senza osservanza dei termini di comparizione ha bensì effetto sanante, ma solo ex nunc, secondo la previsione del privigente
This content downloaded from 185.44.77.40 on Tue, 24 Jun 2014 20:22:12 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
causa, la seconda dipendente da concrete e specifiche ragioni di urgenza emergenti dalle peculiarità del caso e da valutarsi
di volta in volta dal giudice. Né si rinvengono ragioni che rendano oggettivamente irrazio
nale la possibilità di accedere ad una duplice riduzione, come
emerge dall'art. 313 c.p.c. la cui natura di disposizione ricogni tiva di un principio di carattere generale emerge dalle conside
razioni or ora svolte.
Solo la specialità del rito del lavoro giustifica il fatto che
in tale procedura per il combinato disposto degli art. 415, 3°,
4° e 5° comma, e 645, 2° comma, c.p.c., non sia consentito
all'attore in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavo
ro di ottenere la riduzione a metà dei termini di comparizione.
Invero, nel rito del lavoro, la mancata applicazione dell'art.
645, 2° comma in parte qua viene ricondotta alla peculiarità della disciplina (cfr. Cass. 6 agosto 1987, n. 6762, id., Rep. 1987, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 37; 2 aprile 1990,
n. 2637, id., 1990, I, 3197; Corte cost. 28 luglio 1988, n. 936,
id., 1989, I, 2671). Queste considerazioni consentono di ritener superato un ulte
riore profilo della questione. Appare infatti assai dubbio che
l'illegittimo accorciamento dei termini processuali da parte del
presidente del tribunale possa formar oggetto di sindacato da
parte del tribunale allo scopo di dedurne la nullità dell'atto di
citazione ai sensi del 1° comma dell'art. 164 c.p.c.; si può fon
datamente sostenere che il provvedimento presidenziale debba
assimilarsi ad altre misure ordinatorie che generano un affida
mento nelle parti e possono esser disattese solo quando se ne
vogliano dedurre conseguenze negative a carico di una parte
con violazione dei diritti della difesa.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rin
vio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della
Corte d'appello di Napoli.
In altri termini, viene valorizzata la linea interpretativa intesa a limi
tare al minimo — alla luce del beninteso principio del contraddittorio, che vuole il giudice quale terzo imparziale, in medio sedens — le ipotesi in cui possa sostenersi che Terror iudicis sia, quanto agli effetti, error
partis. E cosi si arriva a sostenere che non sia ammissibile — o sia
quantomeno «assai dubbio» — consentire al collegio (ed oggi al giudice monocratico (19)) rilevare di ufficio la nullità dell'atto introduttivo, sin
dacando il provvedimento (in ipotesi) illegittimo del presidente del tri
bunale, il quale deve correlativamente essere assimilato a quelle altre «misure ordinatorie che generano un affidamento delle parti e possono essere disattese solo quando se ne vogliano dedurre conseguenze negati ve a carico di una parte con violazione dei diritti di difesa».
Giovanni Grasso
art. 164 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 2 febbraio 1993, n. 1270, Foro
it., Rep. 1993, voce Citazione civile, n. 10, richiamata in motivazione). Sul nuovo regime della nullità dell'atto introduttivo — che nella spe
cie avrebbe condotto ad una snatoria ex nunc a seguito della costituzio
ne tardiva dell'opposto, previa utile rinnovazione dell'atto introduttivo,
disposta dal giudice di ufficio alla prima udienza (cfr. art. 164, 2° com
ma, c.p.c„ nella nuova formulazione, cfr. A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1994.
(19) Cfr. Carbone, Opposizione, cit., 687, testo e nota 25, ove an che il richiamo alla contraria ma isolata posizione di Attardi, Le nuo
ve disposizioni, cit., 19.
Il Foro Italiano — 1995 — Parte I-44.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 13 aprile
1995, n. 4227; Pres. Nuovo, Est. Amirante, P.M. Morozzo
Della Rocca (conci, conf.); Inps (Aw. Giordano, Li Mar
zi, Fabiani) c. Soc. Officine Meccaferri (Avv. Comito, Don
di). Conferma Trib. Bologna 5 dicembre 1991.
Lavoro (rapporto di) — Contratto di formazione e lavoro —
Collocamento in cassa integrazione — Ammissibilità (L. 12
agosto 1977 n. 675, provvedimenti per il coordinamento della
politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo
sviluppo del settore, art. 21; d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, mi
sure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazio
nali, art. 3; 1. 19 dicembre 1984 n. 863, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726; 1. 23 luglio 1991 n. 223, norme in materia di cassa integrazione, mobili
tà, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della
Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, art. 2).
È legìttimo il collocamento in cassa integrazione dei lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro. (1)
(1) Conformi, Trib. Bologna 28 maggio 1991, Foro it., Rep. 1991, voce Lavoro (rapporto), n. 1202; Pret. Mantova 12 maggio 1990, id., Rep. 1990, voce cit., n. 1354; Trib. Torino 30 aprile 1990, id., Rep. 1991, voce cit., n. 617; Pret. Bologna 7 agosto 1989, id., Rep. 1989, voce Previdenza sociale, n. 642.
Per il diritto alla cassa integrazione guadagni straordinaria, Cass. 11
agosto 1993, n. 8616, id., Rep. 1993, voce cit., n. 528; 1° marzo 1993, n. 2510, id., Rep. 1994, voce cit., n. 535; Pret. Bologna 30 aprile 1993, Dir. e pratica lav., 1994, 249.
Sul trattamento previdenziale in generale dei lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro, si rinvia alla nota che segue di L.
Carbone.
* * *
La «tutela» previdenziale nel contratto di formazione e lavoro.
I. - Nonostante la scarsa attenzione riservata dal legislatore agli aspetti
previdenziali del contratto di formazione e lavoro, i lavoratori assunti
con tale contratto devono essere considerati, ai fini previdenziali, lavo
ratori subordinati, anche se i datori di lavoro «beneficiano» di partico lari agevolazioni contributive; per tali soggetti si applica, quindi, la nor
mativa di carattere generale in materia previdenziale. Non si può del resto ignorare che il 5° comma dell'art. 3 d.l. 726/84,
convertito in 1. 863/84, prevede espressamente per i contratti di forma
zione e lavoro l'applicazione delle disposizioni legislative che disciplina no i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal
medesimo art. 3. Sui riflessi del contratto di formazione e lavoro sulla tutela previden
ziale dei lavoratori interessati, va evidenziato come il periodo di forma
zione è ininfluente ai fini della determinazione dell'anzianità assicurati va prevista dalla legge per il diritto ad alcune prestazioni previdenziali ed assistenziali (es., pensione, indennità di disoccupazione, versamenti
volontari). Il contratto di formazione e lavoro non «influisce» sull'ammontare
delle prestazioni, sia quelle fissate dalla legge in cifra fissa che quelle fissate percentualmente alla retribuzione (per i lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro compete lo stesso trattamento econo mico degli altri lavoratori, trattamento assoggettabile, del resto, a con
tribuzione). Il contratto di formazione e lavoro non determina effetti particolari
né sul trattamento pensionistico spettante al lavoratore interessato né
sul diritto alla indennità economica di malattia (e la misura della stes
sa), né sul trattamento di cassa integrazione guadagni (per la prassi
amministrativa, v. circ. Inps n. 854 GS del 27 marzo 1986). Anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali il contratto di formazione e lavoro «produce» le stesse conseguenze di un normale rapporto di lavoro.
Il contratto di formazione e lavoro non determina, altresì, conse
guenze specifiche né per la determinazione né per il diritto (e l'importo) dell'indennità di disoccupazione, e delle prestazioni antitubercolari.
Anche la normativa che tutela la lavoratrice madre si applica inte
gralmente alla dipendente assunta con contratto di formazione e lavoro
(sia per quanto concerne il diritto all'astensione obbligatoria e facoltati
va dal lavoro, che per le prestazioni sanitarie). Nessun problema si pone, altresì, per l'applicazione in generale della
normativa sul trattamento di richiamo alle armi e sui permessi per con
gedo matrimoniale. In ordine alla agevolazione contributiva concessa ai datori di lavoro
occorre evidenziare che il «beneficio» riguarda solo la quota a carico
del datore di lavoro ma non quella a carico del lavoratore (che deve
This content downloaded from 185.44.77.40 on Tue, 24 Jun 2014 20:22:12 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions





![home [] · Avv. VOLPE Vincenzo Francesco (Antonio), nato a Eboli (SA) il 04.10.1961 Avv. Avv. Avv, Avv. Avv. Avv. Avv. Avv. Avv. VITALE Olimpia, nata a Eboli (SA) il 28.12.1965 OCCIIINEGIR()](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/6049a37bf9bd336284312a3d/home-avv-volpe-vincenzo-francesco-antonio-nato-a-eboli-sa-il-04101961.jpg)