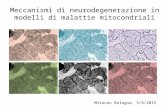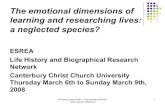r a u c q dai Georgofili a agri- cultura · 2017-11-02 · Anno III n. 1 21 marzo 2009 ... una...
Transcript of r a u c q dai Georgofili a agri- cultura · 2017-11-02 · Anno III n. 1 21 marzo 2009 ... una...
te r r a , acqua
,aria,so l e . . . vita: agri-cultura
informazionidai Georgofili
Anno III n. 1 21 marzo 2009
“Poste Italiane s.p.a. – Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Firenze”
Inca
sodi
man
cato
reca
pito
invi
are
aFi
renz
eC
MP
per
lare
stitu
zion
eal
mitt
ente
prev
iopa
gam
ento
resi
Dalla concitata fuga diprovvedimenti legislativiche ha caratterizzato,
agli albori del nuovo secolo, l’ap-proccio del legislatore al temadel paesaggio, traspare una sortadi tendenziale indifferenza versole peculiarità che connotano ilpaesaggio agrario, le quali, vice-versa, richiedono una disciplinaad hoc, in grado di conciliare latutela dei valori paesaggistici e,dunque, culturali, estetici, natura-
Paesaggio agrario:un’altra occasione perduta
listici, con la protezione degliinteressi economici degli agricol-tori che all’interno di quel pae-saggio svolgono la loro attivitàimprenditoriale.Non si sottrae a questo giudiziosferzante, quanto realistico, l’ul-tima tessera recentementeincastonata nel complesso econtraddittorio mosaico dellalegislazione paesaggistica, rap-presentata dal decreto legislati-vo 26 marzo 2008, n. 63
“Ulteriori disposizioni integrativee correttive del decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, in rela-zione al paesaggio”.Il decreto, infatti, si limita, da unlato, a riproporre la formula giàcollaudata nei suoi precedenti,di un invito diretto alle Regionia riservare particolare attenzio-ne alla salvaguardia dei paesaggirurali, nella individuazione dellelinee di sviluppo urbanistico ededilizio; dall’altro lato, ad inseriregli alberi monumentali, tenden-zialmente localizzati nelle areeagricole, tra le categorie di benipotenzialmente oggetto didichiarazione di notevole inte-resse pubblico, da sottoporrequindi a vincolo paesaggistico.
Conseguentemente, è prevista,nei casi in cui la proposta di vin-colo riguardi filari, alberate edalberi monumentali, l’integrazio-ne della commissione prepostaalla relativa valutazione con unrappresentante del competentecomando regionale del Corpoforestale dello Stato.Ben poco, dunque, rispetto agliauspici, coralmente quanto auto-revolmente manifestati dallastessa Accademia dei Georgofili,di una maggiore attenzione dellegislatore verso la complessitàdegli interessi che si intreccianonel paesaggio agrario e la loropotenziale conflittualità: un’altraoccasione perduta.
NNiiccoolleettttaa FFeerrrruuccccii
Caratteristica comunedelle ricerche volte allamessa a punto di strate-
gie innovative per la difesa dellecolture è l’individuazione dimezzi di lotta efficaci, economi-ci, a basso impatto ambientale edi facile applicazione.Gli interventi per il controllodelle infestazioni entomaticheperseguono i principi ecologicied economici sopra citati,mediante l’impiego di strategie(monitoraggio dei livelli dipopolazione dei fitofagi, uso diattrattivi e repellenti, ecc.) cheriducono l’impatto ambientaledel presidio sanitario più checon l’impiego di mezzi chimicicon ridotta azione biotossica.Infatti le infestazioni entomati-che sono ancora in massimaparte controllate dagli insettici-di organici di sintesi ai quali si
Difesa delle colture con mezzi abasso impatto ambientale
continua a guardare in attesa divalide innovazioni. Interesse edaspettative destano, al riguardo,principi attivi di recente formu-lazione con bassa tossicità permammiferi ed altri gruppi dianimali “non target”.La messa a punto di strategie dilotta a basso impatto ambienta-le contro funghi, batteri, nema-todi fitoparassiti e piante infe-stanti, passa attraverso l’integra-zione delle pratiche dellagestione delle colture (manteni-mento della fertilità biologicadel suolo, diagnostica fitopato-logica, modelli previsionali, ecc.)con i mezzi di difesa diretti. Laricerca e la sperimentazionehanno consentito di individuarestrumenti biotecnici utili opotenzialmente utili per la dife-sa delle colture in campo edegli ortofrutticoli in post-rac-
colta. Per lo più si tratta dimicrorganismi antagonisti, inset-ti parassiti per la lotta alle infe-stanti, biocidi di origine naturale,mezzi fisici, additivi alimentari,ecc., il cui impiego in campopratico è spesso reso difficolto-so anche da procedure di regi-strazione lunghe ed onerose. Ildivieto d’impiego del bromurodi metile per la lotta contro ipatogeni tellurici ha stimolato laricerca e la sperimentazione incampo di mezzi alternativi qualii biofumiganti (ad esempio gliisotiocianati liberati per idrolisidei glucosinolati contenuti inmolte Brassicaceae) e le matriciorganiche complesse (torba,compost, residui colturali, ecc.)la cui soppressività può essereaumentata con l’aggiunta diorganismi competitivi. La man-canza di metodi semplici con
cui determinare la capacità sop-pressiva di differenti matrici,rappresenta il fattore fortemen-te limitante la loro diffusionenella pratica agricola.La resistenza delle piante allemalattie è un efficace meccani-
In questo numero:
Paolo AlghisiAttilio BosticcoOrazio Ciancio
Maurizio CocucciMaurizio Conti
Mario DiniNicoletta Ferrucci
Cesare IntrieriSanti LongoLiviana Leita
Giacomo LorenziniStefano MancusoLetizia Martirano
Vittorio MarziValerio Merlo
Luigi Omodei ZoriniAlessandro Pacciani
Enrico PorcedduLuigi Rossi
Franco ScaramuzziPaolo Sequi
Franco Francesco Vincieri
PPaaoolloo AAllgghhiissii (segue a pag. 2)
2 informazioni dai Georgofili21 marzo 2009
Con la decisione del 10Dicembre 2008, laCommissione UE ha
assentito alla concessione degliAiuti di Stato per l’attuazionedei contratti “di filiera” e “didistretto” (con riferimento alDecreto 2850 del 21/4/2008)aprendo finalmente concreteprospettive all’utilizzazione distrumenti innovativi per l’am-modernamento dell’agricolturae lo sviluppo dei territori rurali,anche in relazione alle acclaratetrasformazioni del settore edagli emergenti orientamentidelle politiche. Si tratta, in effet-ti, di un riconoscimento indiret-to dei distretti a livello europeo
I distretti in agricoltura peruna politica che cambia
sicuramente destinato a impri-mere un’accelerazione alla pro-gettualità a livello locale e dicomparti produttivi. Ma si trattasoprattutto di un provvedimen-to che libera circa 800 milioni dieuro di contributi, risorse im-portanti per le filiere e le areerurali che possono dotarsi diquesti strumenti.I Distretti rurali e i Distrettiagro-alimentari di qualità sonoprevisti all’art.13 della Legge diorientamento del 2001, ed illoro riconoscimento è attribui-to alle Regioni, ma solo alcunehanno finora adottato specificiprovvedimenti legislativi in unclima di non eccezionale inte-
resse da parte delle categorieinteressate.Ciò è quanto emerge a oggi dauna ricerca a livello nazionale,coordinata dal Dipartimento diScienze economiche dell’Uni-versità di Firenze e finanziata dalMIPAAF, per una valutazione sucome hanno operato le Regioniin questi anni e su come hannoreagito le categorie all’introdu-zione di uno strumento digovernance volto a favorire ilpartenariato territoriale e difiliera sulla base di una pro-grammazione dal basso, speri-mentata da tempo anche con lametodologia LEADER e dellaprogrammazione negoziata.La prossima conclusione dellaricerca, si colloca in un momen-to particolarmente interessantee delicato per le imprese e perle aree rurali, poiché vengono acoincidere temporalmente im-
portanti riforme delle politichecomunitarie, quali: la nuovaPolitica di Sviluppo Rurale, larecentissima approvazione del-l’Health Check della PAC, l’atti-vazione della nuova Politica dicoesione.In questo scenario, e soprattut-to in previsione del post 2013in discussione a Bruxelles, siconferma un crescente interes-se per la territorializzazionedelle politiche comunitariecome risposta alla sempre mag-giore competizione sui mercatie a fronte di altre emergenzeambientali e climatiche.È certamente auspicabile che aprovvedimenti legislativi che“danno gambe” ai distretti, sipossano accompagnare ancheopportune riflessioni di miglioreorganizzazione del quadro nor-mativo a livello nazionale.
AAlleessssaannddrroo PPaacccciiaannii
2009 Anno Italo-Egizianodella Scienza e della Tecnologia
Il 2009 è stato proclamatoAnno Italo-Egiziano dellaScienza e della Tecnologia.
L’iniziativa fa seguito al summitItalo-Egiziano del Giugno 2008,tra il Ministro degli Affari Esteriitaliano, Franco Frattini, e il suoomologo egiziano, Aboul Gheit,e si inserisce nell’ambito delDecennio della Scienza e dellaTecnologia (2007-2016), pro-clamato dal Presidente Muba-rak, con lo scopo di fornire sup-porto politico ai programmi diespansione delle capacità scien-tifiche e tecnologiche del Paese,attraverso la cooperazione coni partner internazionali in sva-riati settori scientifico-tecnolo-gici e la costituzione di fondi adhoc per lo sviluppo delle scien-ze e della tecnologia.La sfida per l’Italia è di riuscire apromuovere iniziative che rag-giungano il grande pubblico,valorizzando l’eccellenza italianasia in quello della ricerca appli-cata alla produzione, sia in quel-lo dell’influenza culturale italiananell’area mediterranea, secondoil motto proposto per l’evento:Science for People.In pratica, il taglio del program-ma è quello di abbinare, amomenti di divulgazione scienti-
fica destinati al grande pubblico,attraverso l’organizzazione dimostre scientifiche e di eventispeciali, momenti di approfondi-mento tecnico-scientifico, miratia favorire la cooperazione bila-terale su progetti di ricercascientifica e a rafforzare la pre-senza delle imprese italiane inEgitto e/o di iniziative collegateall’operato della CooperazioneItaliana e di altre Istituzioni italia-ne, principalmente le Regioni.Queste ultime, in particolare,possono essere interessate apartecipare alla programmazio-ne dell’Anno della Scienza edella Tecnologia, in sinergia conaltre Istituzioni, con iniziativemirate a promuovere all’esterol’eccellenza specifica di ogniRegione. Un esempio riguardala Regione Piemonte, che haprevisto due rassegne multidi-sciplinari sulla produzione digranella ed utilizzo degli scartidella lavorazione del riso e sullaproduzione della lana e dellaseta, associate ad un convegnosulla sostenibilità della colturadel riso nell’area mediterranea,proposto dal Consiglio per laRicerca e la Sperimentazione inAgricoltura. Due mostre scienti-fiche riguardano invece: L’Ere-dità di Fermi, in occasione del
Centenario della sua nascita, eL’Eredità di Marconi, in occasio-ne del Centenario del suoPremio Nobel.Università e Enti di RicercaItaliani sono presenti in Egittocon collaborazioni e progetti diricerca in svariati settori scienti-fici ed hanno quindi l’opportu-nità di valorizzare il loro lavoro,attraverso l’organizzazione diconvegni, il lancio di nuovi pro-getti e lo scambio di ricercatori.Possono essere organizzati con-vegni scientifici e altre iniziativein vari settori.
In conclusione, il 2009 AnnoItalo-Egiziano della Scienza edella Tecnologia vuole essereun’occasione per valorizzare laricerca scientifico-tecnologicaitaliana, con potenziali ricadutein chiave di cooperazione conl’Egitto e con i Paesi dell’areamedio-orientale, per promuo-vere le eccellenze del nostrePaese, contando su un ruoloimportante da parte delleRegioni, e per dare visibilità alleaziende italiane operanti inEgitto.La programmazione dell’Annoresterà aperta a proposte dieventi scientifici fino all’ultimomomento compatibilmente conla realizzazione degli eventistessi e comunque fino allaprima metà del 2009.
EEnnrriiccoo PPoorrcceedddduu
Difesa delle colture conmezzi a basso impattoambientale(continua da pag. 1)
smo naturale di difesa dai pato-geni. Molta attenzione vieneposta quindi agli induttori bioti-ci ed abiotici di resistenza eall’ingegneria genetica per laproduzione di piante transgeni-che (PGM) resistenti alle malat-tie. Malgrado l’intensa attivitàsperimentale ed i successi otte-nuti in laboratorio, serra epieno campo, nessuna pianta
dotata di resistenza transgenicaai batteri ed ai funghi fitopato-geni è oggi presente sul merca-to, mentre sono disponibilipiante transgeniche resistenti avirus, insetti ed erbicidi.Nel complesso esiste oggi unampio ventaglio di conoscenzesuscettibili di sviluppo applicati-vo. Quelle necessarie per assi-curare un più esteso impiegodegli strumenti biotecnici sono,però, ancora insufficienti agarantire risultati capaci di con-quistare la piena fiducia degliagricoltori.
PPaaoolloo AAllgghhiissii
Premio “Antico Fattore”
L’Edizione 2009 dello storico Premio “Antico Fattore” èstata dedicata alla viticoltura ed alla enologia. IlConsiglio accademico, avvalendosi del parere di una
apposita Commissione di esperti, ha assegnato il Premio aDaniele Vergari e Roberto Scalacci per il lavoro “Istoria delleviti che si coltivano nella Toscana” con la seguente motivazio-ne: Il valore culturale e scientifico del libro è assai notevole. Lapubblicazione offre la possibilità di riscoprire e recuperare i viti-gni autoctoni nell’ipotesi che alcuni possano essere utilizzati perun concreto miglioramento della viticoltura della RegioneToscana. Comunque quelli ancora reperibili potranno essereconservati come banca genetica.Il Premio sarà consegnato nell’ambito della Cerimonia perl’Inaugurazione del 256° Anno Accademico dei Georgofili.
3informazioni dai Georgofili 21 marzo 2009
Uno specchio per la nostra agricoltura
Nel volume tematico “Leimprese agricole”, l’Istatha presentato i risultati
di una rielaborazione dei daticensuari 2000 effettuata nonprendendo in considerazionel’intero universo delle aziendecensite, ma esclusivamentequelle individuali dedite allacommercializzazione della loroproduzione nonché di quelle acarattere societario. Solo que-sto tipo di aziende avrebbediritto al titolo di imprese ed acomporre quindi l’area dell’agri-coltura imprenditoriale, distintada tutta le attività agricole svol-te per esclusivo autoconsumo.Complessivamente, le aziendeche nel 2000 hanno dichiaratodi commercializzare la propriaproduzione sono 1 milione emezzo.Da parte sua l’Eurostat ha deci-so – a partire dalla indaginestrutturale del 2003 – di limi-tare il campo di osservazione
comunitario alle sole aziendeche superano una certadimensione economica (alme-no 1 UDE), vale a dire quelleche sono in grado potenzial-mente di conseguire un redditodi almeno 1200 euro all’anno.Ciò al fine di rendere più omo-genei e confrontabili i dati delleindagini comunitarie. Le azien-de più piccole vengono relega-te in un’area definita dell’agri-coltura di sussistenza. In seguitoall’adozione di tale nuovocampo di osservazione, le ulti-me indagini comunitarie sullestrutture assegnano all’agricol-tura italiana circa 1 milione ecento mila aziende produttive.Queste nuove statistiche Istated Eurostat dimostrano che, sesi circoscrive il campo di osser-vazione alle aziende che, in virtùdella loro dimensione e dell’im-pegno nella commercializzazio-
ne del prodotto, sono anchevere imprese, l’immagine socio-strutturale dell’agricoltura italia-na cambia notevolmente. I nuo-vi dati convergono nel delimita-re l’area dell’agricoltura impren-ditoriale italiana a poco più diun milione di aziende, cifra cheè molto vicina a quella delle cir-ca 900 mila realtà produttiveiscritte nei registri delle Cameredi Commercio.Nell’ambito di quest’area è per-altro nettamente distinguibile unnucleo forte di imprese, quanti-ficabile in meno di 500 mila uni-tà, il cui ruolo è determinanteper il conseguimento dei risul-tati produttivi ed economici delsettore. Non arrivano neanchea 300 mila le aziende che, con lavendita del prodotto, ottengo-no entrate annue superiori a 25milioni di lire (nel 2000). E ba-stano 400 mila imprese (miglio-ri in termini di dimensione eco-nomica) per produrre l’80% delreddito lordo agricolo comples-sivo. Il restante 20% circa si cal-cola provenga da 600-700 milaimprese più piccole.Questi dati fotografano trediverse realtà in cui si articolal’uso della SAU italiana. In pri-mo luogo, le piccole unità fon-diarie di autoconsumo e/o disussistenza, quantificabili in quasiun milione e mezzo di realtàche la statistica esclude dal no-vero di aziende agrarie. In se-condo luogo, le principali azien-de imprenditoriali vere e pro-prie, il cui numero non arriva almezzo milione. Infine le circa600-700 mila aziende che – perusare l’espressione di CorradoBarberis – compongono un’a-rea di agricoltura professionalepovera, le quali coprono circa 3milioni di ettari di SAU e svol-gono un prezioso ruolo am-bientale e territoriale; ma, a giu-dizio di autorevoli sociologi,sarebbero maggiormente espo-ste ad un progressivo abbando-no, essendo meno capaci ditrattenere o attrarre giovaniche possano succedere all’at-tuale generazione di condutto-ri.
VVaalleerriioo MMeerrlloo
L’immagine strutturale del-l’agricoltura italiana, cosìcome offerta dalle statistiche
Istat ed Eurostat ed analizzatenella interessante sintesi diValerio Merlo (cfr. anchewww.georgofili.it), induce a diverseriflessioni. La prima riguarda ilfatto che, data la loro irrilevanzaproduttiva ed economica, le stati-stiche giustamente non conside-rano più come aziende agrariequel crescente cosmo di micro-proprietà, derivato da una delete-ria ed inarrestata polverizzazionefondiaria. Ne consegue che anchei loro titolari non dovrebberoentrare nel novero degli “addettiall’agricoltura” e non dovrebberoquindi ottenere sostegni pubblicidai fondi destinati allo sviluppodel settore. Mentre, al contrario, sievidenzia sempre più l’opportuni-tà di assecondare un loro riaccor-pamento in valide aziende.Così depurate, le statistiche sonostate finalmente in grado di riflet-tere una più nitida immaginestrutturale dell’agricoltura italia-na, che in precedenza risultavainvece assai degradata rispetto aquella degli altri Paesi dellaUnione Europea. Ora è evidentecome le cause di quelle deforma-zioni d’immagine non dipendes-sero da difetti dello specchio(strumenti statistici), ma daipeculiari criteri con i quali veniva-no considerati e presentati i sog-
getti da rilevare, quindi a causadella nostra prolungata disatten-zione e confusione nei confrontidell’agricoltura, con la conseguen-te incapacità di vedere e distin-guere oggettivamente la realtàdelle cose.La nostra agricoltura risulta com-plessivamente strutturata in pocopiù di un milione di Aziende che,nel loro insieme, forniscono l’inte-ro P.L.V. (prodotto lordo vendibile)agricolo nazionale. Circa l’80% diquesto P.L.V. è prodotto da menodi 500 mila imprese più avanza-te. Appare quindi evidente comelo sviluppo agricolo sia legato aquesto insieme di realtà produtti-ve. La promozione ed il sostegnodi tale sviluppo dovrebbero quindiessere finalizzate razionalmentecome investimenti finanziari inqueste attività. È evidente inoltrel’opportunità di riconsiderare l’im-provvida tendenza alle divisionied alle conseguenti contese inter-ne al settore. L’agricoltura ha giàtroppo sofferto anche per l’insi-nuarsi di una deleteria ricerca diqualsiasi elemento di distinzione,capace solo di creare ulterioridivisioni in categorie ed il moltipli-carsi di rispettive rappresentanze.L’intero settore deve invece sentir-si ed essere considerato come unben definito ed unitario insieme,capace di esercitare tutto il suonotevole peso.
FFrraannccoo SSccaarraammuuzzzzii
L’agricoltura italianaè articolata in pocopiù di un milione
di aziende
4 informazioni dai Georgofili 21 marzo 2009
Il sostegno alla produzione diservizi ambientali da parte delleimprese agricole è uno dei
punti qualificanti dell’impostazionerecente della Politica AgricolaEuropea e si è concretizzato nel-l’introduzione della condizionalitànel primo pilastro e nelle misureagro-ambientali nel secondo.La commistione tra interventidiretti al miglioramento dei reddi-ti agricoli e politiche ambientalipuò, però, ingenerare qualchemalinteso. L’impatto migliorativosull’ambiente ha un senso se gli
Progetti Integrati Territoriali e Piani di Sviluppo Rurale
interventi di investimenti e/omanutenzioni sono svolti susuperfici significative, spesso supe-riori a quelle delle piccole emedie aziende e non su appezza-menti isolati. Nel PSR la introdu-zione dei Progetti IntegratiTerritoriali (PIT) mirava ancheappunto a questo obiettivo, cosìcome, del resto, i progetti intera-ziendali nel precedente periodo(Patti d’area). Ciò che lascia per-plessi è la indeterminatezza diquesti strumenti, che di fatto hacausato la loro pressoché nulla
applicazione nel primo piano. Lamera assegnazione di puntiaggiuntivi alle aziende partecipan-ti ad un PIT, nella graduatoria dellepriorità per l’accesso ai finanzia-menti nelle varie misure, è assolu-tamente inadeguata ad una realepromozione degli stessi. Se si desi-dera conferire alla produzione diservizi ambientali un concretointeresse per gli agricoltori edun significativo vantaggio per lacollettività, occorre identificareuna forma di pagamento diret-to di tali servizi ed assicurare la
loro produzione a dimensioniterritorialmente rilevanti. Il PITpuò essere uno strumento vali-do, ma occorrerebbe assegnar-gli finanziamenti autonomi, nonveicolati da vantaggi nelle gra-duatorie delle varie misure, edoccorrerebbe individuare i sog-getti promotori e/o gestori ditali progetti assicurando aglistessi una convenienza nell’as-sumere questo ruolo. Un esem-pio potrebbero essere certeassociazioni di produttori (adesempio in Toscana gli olivicol-tori ed i viticoltori) in grado dicoinvolgere un numero di agri-coltori che costituiscano massacritica per l’obiettivo di un PITin una determinata area.
LLuuiiggii OOmmooddeeii ZZoorriinnii
Secondo i dati dell’Inven-tario Nazionale delle Fore-ste e dei Serbatoi Forestali
di Carbonio, i cedui in Italia siestendono su 3.663.143 ha ecostituiscono il 41,8% dellasuperficie forestale. La forma digoverno più comune è il ceduomatricinato, con il 27,5%, segui-to dal ceduo semplice, con il10%, e dal ceduo composto,con il 4,3%.Le utilizzazioni di legna percombustibile documentate perl’anno 2002 sono state pari a4.883.273 m3. Va però tenutoconto che le attuali statisticheufficiali sottostimano in modoconsistente gli effettivi prelievilegnosi, soprattutto per quantoriguarda i cedui: una recentericerca ha dimostrato come inItalia centrale il prelievo dimassa legnosa dai cedui siaoltre il 40% maggiore di quellocensito amministrativamente.Una corretta analisi dellepotenzialità di produzione dibiomassa dei boschi cedui devefar riferimento anche a fattoriesterni al bosco, come il nume-ro delle imprese che operanonella filiera della legna da arde-re, che secondo quanto ripor-tato dalle statistiche delleCamere di Commercio a livellonazionale è pari a 2.804, quindipiuttosto limitato. Ciò testimo-nia le gravi difficoltà che caratte-
La produzione dibiomassa forestale
rizzano l’attività nel settoreforestale: stagionalità, condizionidure del lavoro in foresta, diffu-sione del fenomeno del lavoronero, carenza delle necessarieoperazioni di formazione e spe-cializzazione dei lavoratori.Il bosco ceduo è una risorsarinnovabile ed è in grado di for-nire una elevata quantità dilegna per combustibile.Tuttavia,l’uso delle risorse rinnovabili e ilprelievo di prodotti dal bosco:a) non può superare la velocitàcon la quale la risorsa bosco sirigenera; b) non può intaccarele potenzialità evolutive delsistema; c) non deve ridurre labiodiversità.La gestione forestale sostenibilepresuppone l’adozione di unaprospettiva ampia in modo daanalizzare gli effetti delle sceltesui processi dell’ecosistema siaa scala temporale - breve,medio o lungo periodo -, sia ascala spaziale - dal popolamen-to al paesaggio. In ogni caso, èopportuno mettere in attoaccorgimenti selvicolturali voltial miglioramento quali-quantita-tivo del bosco relativi al tratta-mento, agli ordinamenti coltura-li, ai cicli di utilizzazione.La pianificazione forestale èun’arma preziosa per differen-ziare nel tempo e nello spaziogli interventi in modo da garan-tire, attraverso una accurata let-
tura delle diverse situazioni sta-zionali, compositive e struttura-li, il mantenimento dell’efficienzadel sistema bosco e la diversitàbiologica a livello di paesaggio.Alcune regioni molto opportu-namente si sono dotate di pianiforestali che, seppur evidenzian-do l’importanza e la necessitàdell’estrazione di biomassa,pongono restrizioni al taglio deiboschi cedui, imponendo l’allun-gamento dei turni, la diminuzio-ne delle dimensioni delle taglia-
te e l’attuazione delle cure col-turali.Gli scenari attuali e quelli pre-sumibili in un prossimo futuroindicano in modo chiaro che ilproblema della produzione dibiomassa a fini energetici nonsi risolve in chiave tecnica macon una politica forestale ingrado di favorire un for teimpegno a tutti i livelli per ilmiglioramento dell’efficienzadel sistema.
OOrraazziioo CCiiaanncciioo
Ceduo di faggio
5informazioni dai Georgofili 21 marzo 2009
Vasta risonanza ha avutosulla stampa internazio-nale la notizia che nel
comune di Altamura, importan-te centro agricolo della provin-cia di Bari, noto per la produzio-ne di pane DOP molto graditosul mercato, un panettiere pro-duttore di focacce ha determi-nato la chiusura del “fast food”del colosso Mac Donald. Dopol’apertura nel centro cittadinodi un ampio locale con unagigantesca M e un promettenteavvio con una folla di adole-scenti in fila per un hamburger,un po’ alla volta la giovane clien-tela incominciò a non gradire ilpanino pieno di carne pressataper andare al vicino locale delpanettiere, che sfornava focaccecalde e saporite.È indubbio che l’episodio raffor-za le attuali politiche regionaliper la valorizzazione dei nostriprodotti tipici ed il mangiareall’italiana, pur tuttavia è perico-loso credere che la tipicitàpossa risolvere la grave situazio-ne dell’agricoltura, come sonole preoccupazioni di questi gior-
ni per le giacenze di olio d’olivainvendute e l’incerto andamen-to del prezzo del grano semprepiù al ribasso.La notizia è apparsa come rivin-cita delle nostre tradizioni ali-mentari regionali rispetto all’inva-denza dei prodotti dell’industriaalimentare, come nei controversidibattiti slow-food/fast-food.Sarebbe più opportuno informa-re l’opinione pubblica che tradi-zione e industria alimentaresono due modi di fare economiae di rispondere alle attuali esi-genze della società moderna.Il crescente sviluppo dell’indu-stria alimentare, infatti, è dovutoai profondi mutamenti nellasocietà moderna, che per varimotivi dedica sempre menotempo alla preparazione in casadei pasti. Da tempo, la donna èimpegnata nel lavoro fuori casa,nelle città la pausa per il pranzodel mezzogiorno si è ridotta adun rapido spuntino, aumenta ilnumero dei single, aumentano,per praticità, gli incontri convi-viali fuori casa. Allo stessotempo, l’industria offre sempre
più una serie di prodotti ali-mentari, con i servizi incorpora-ti (time saving, conveniencefood) in modo da preparare ilpasto in brevissimo tempo. Lapubblicità televisiva dilaga nel-l’offerta di piatti pronti, “i quat-tro salti in padella”.È finito il tempo della lunga pre-parazione del pane in casa, conlevataccia notte tempo, perconsegnare all’alba le forme dipane ben cresciute al fornaio,come anche è finito il tempodella pignatta brontolona, che afuoco lento per molte ore cuci-nava i legumi.Allo stesso tempo, il giusto impe-gno nella valorizzazione dei pro-dotti tipici regionali, non deve fer-
marsi solo alle frequenti manife-stazioni di propaganda delle gior-nate della degustazione, ma deveanche approfondire sul pianodelle conoscenze tecniche, lecaratteristiche qualitative, chelegano la tipicità con il territorio.Lo sviluppo di nuove tecnolo-gie, utilizzabili per definire indi-catori validi al riconoscimentodell’origine geografica può esse-re un utile strumento non soloper il riconoscimento del pro-dotto tipico, ma anche perinterventi validi per il migliora-mento della qualità. E’ unapproccio scientifico che troval’ampia collaborazione delmondo della ricerca.
VViittttoorriioo MMaarrzzii
La valorizzazione deiprodotti tipici
La focaccia, tipico prodotto locale delle sagre popolari
Cambiamenti climatici edeccessivo grado alcolico dei vini
Ènoto che negli ultimi 20anni si sono verificatiimportanti cambiamenti
climatici, che hanno soprattuttoriguardato l’aumento delle tem-perature e del numero annualedi ore di sole, con il conseguen-te accorciamento del periodocompreso tra il germogliamen-to e la maturazione.In pratica, si manifesta abbastan-za spesso un forte anticipo delmomento in cui il livello gluco-metrico del mosto risulta otti-male per la raccolta. In talemomento, specialmente nelleuve rosse, può essere giàriscontrabile una perdita di aci-dità (specie se le temperaturenotturne sono elevate), mentrenon risultano ancora presentigli aromi finali tipici della varietàed altre fondamentali caratteri-stiche dell’acino (colore dellabuccia, completa sintesi deicomposti fenolici, imbrunimen-to dei vinaccioli, ecc.), che gene-
ricamente sono indicate con iltermine di “maturità fenolica”.L’effetto degli innalzamenti ter-mici comporta, in definitiva, un“disaccoppiamento” nella evolu-zione dei diversi fattori dellamaturazione. Per raggiungerenelle uve rosse la “maturità feno-lica” occorre quindi ritardare ilmomento della vendemmia, conil risultato di incrementare ulte-riormente il grado glucometricodelle bacche e il grado alcolicopotenziale del mosto, che potràdare origine a vini con oltre 13-14 gradi. Tali vini risponderannosempre meno alle esigenze delmercato, che ormai richiedeprodotti armonici ed eleganti,ma con gradazioni moderate.Tenuto conto dei cambiamenticlimatici, è possibile chiedersi seesistano interventi agronomiciper contrastare gli effetti negati-vi dell’accorciamento dei cicliproduttivi.Il metodo più immediato
potrebbe semplicemente consi-stere nell’incrementare la pro-duzione per ceppo o ridurrel’entità del diradamento, ma inmolti casi i risultati sarebbero incontrasto con le norme chelimitano le rese in molti discipli-nari. In alternativa, si potrebbeperaltro ricorrere all’utilizzo ditagli meccanici drastici sulleparti medio-alte dei germogli infase di post-invaiatura, per eli-minare le foglie più funzionali eridurre la sintesi dei carboidrati.La cimatura tardiva potrebbequindi essere utile per contra-stare andamenti troppo “accel-lerati” della maturazione.Per i medesimi scopi potrebbeessere applicata anche la defo-gliazione, eseguita meccanica-mente dopo l’invaiatura e pertutta l’altezza della chioma, dovel’impiego di una macchina (la cuiazione è sempre parziale), com-porterebbe una riduzione dellasuperficie fogliare assimilante.
Risultati promettenti per ridurreil “disaccoppiamento” tra lamaturazione “zuccherina” equella “fenolica” sono infine pro-spettati dal possibile impiego ditrattamenti antitraspiranti allachioma, sempre in fase di post-invaiatura. Alcuni composti anti-traspiranti di origine vegetalefacilmente biodegradabili, usatiin vivaio per ridurre la perdita diacqua nelle fasi di trapianto,sono infatti in grado di formaretemporaneamente uno stratoimpermeabile sulle foglie, ridu-cendo gli scambi gassosi tra glistomi e l’ambiente esterno eabbassando i processi assimilati-vi e quelli di respirazione.In sintesi, la sperimentazione si ègià mobilitata per cercare nuovesoluzioni ai problemi connessi aicambiamenti climatici. La validitàdelle diverse ipotesi è ancora daverificare, ma le premesse sifondano su conoscenze fisiolo-giche consolidate e i risultatiacquisibili potrebbero esseretrasferiti alla tecnica in un perio-do relativamente breve.
CCeessaarree IInnttrriieerrii
6 informazioni dai Georgofili 21 marzo 2009
Nelle piantecome negli animali
La membrana plasmatica èuna barriera biologica chesepara l’interno della cellula
dall’ambiente esterno ad essa.Tutte le cellule, di qualunqueorganismo vivente, sono dotatedi questa membrana selettiva,che gioca un ruolo importantis-simo nella regolazione del tra-sporto di materiale dentro efuori dalla cellula. Poiché lamembrana plasmatica è uno deiprimi punti di contatto per qua-lunque segnale proveniente dal-l’ambiente esterno, è ovvio che
essa rivesta un ruolo fonda-mentale nella percezione erisposta ai diversi stressambientali. In effetti, se la mem-brana plasmatica non è perfet-tamente risigillata in seguito adun danneggiamento (magariprovocato da uno stress) si hala sicura morte della cellula.Negli animali molte cellule, peresempio quelle cardiache o deimuscoli, a causa della loro altadinamicità, subiscono danneg-giamenti frequenti della mem-brana, che devono essere pron-
tamente riparati. Se il danno èpiccolo, nell’ambito dei pochinanometri (milionesimi di milli-metro), allora la riparazione èsemplice e veloce, ma se ildanno è nell’intervallo deimicron (millesimi di millimetro)allora è necessario che nuovipezzi di membrana, provenientidall’interno della cellula, sianotrasportati sul sito di rotturaper sigillarla. Gli addetti a que-sto traffico di membrane dall’in-terno all’esterno della cellula,sono abitualmente gruppi diproteine, fra le quali fondamen-tale è la famiglia delle sinapto-tagmine. Queste proteine, comesuggerisce già il nome, svolgonola loro mansione principalmentea livello delle sinapsi animali.Recentemente è stata pubblicata
sulla prestigiosa rivista di biologiavegetale “Plant Cell” un articolo,frutto della collaborazione fral’Università di Firenze e quelle diMalaga e Bonn, in cui si descrivel’attività di una di queste sinapto-tagmine nelle cellule vegetali. Irisultati descritti dimostranocome nei vegetali questa protei-na svolga un ruolo analogo aquello svolto negli animali e siafondamentale per la riparazionedi danni sulla membrana. Poichémolti stress (sale, freddo, siccità,ecc.) sono fatali alla pianta pro-prio perché distruggono lamembrana plasmatica, è preve-dibile che in un prossimo futuro,queste nuove conoscenze pos-sano essere di valido aiuto nellacreazione di piante più resistenti.
SStteeffaannoo MMaannccuussoo
“Per il filosofo, il fisico, ilmeteorologo e il chimi-co, forse non c’è sogget-
to più interessante dell’ozono”:così si esprimeva Fox nel lonta-no 1873. A questi esperti daqualche decennio possiamoaggiungere “coloro che si occupa-no di piante”, in quanto questoinquinante costituisce una verae propria minaccia mondiale perla produzione di cibo, fibre tessi-li e legname, nonché per la con-servazione delle comunità vege-tali naturali, inclusa la loro biodi-versità. Come noto, si trattadella forma allotropica triatomi-ca dell’ossigeno, dotata di gran-de potenziale ossidoriduttivo, invirtù del quale attacca diretta-mente matrici animali e vegetali,nonché materiali non biologici.Ad esso vengono attribuiti ruoliprimari nei numerosi casi dimortalità associati alle “ondatedi calore” che spesso affliggonoanche il nostro Paese in estate.Perciò questo inquinante è datempo oggetto di interventinormativi in sede sia nazionalesia comunitaria.Gli effetti fitotossici macrosco-pici consistono inizialmente inuna clorosi fogliare diffusa, dinon semplice individuazione inquanto aspecifica; gli stadi suc-
Ozonopatogeno per le piante
cessivi sono rappresentati dauna “bronzatura” o dalla com-parsa di necrosi puntiformi olocalizzate; le zone interessatesono limitate al tessuto a paliz-zata delle regioni internervali.Occorre, comunque, considera-re che il sintomo più diffusodovuto all’azione di questoinquinante è l’induzione prema-tura della senescenza e che rile-vanti interferenze con il meta-bolismo si realizzano in fasesubliminale.L’importanza dell’ozono vadiscussa anche in prospettiva: seoggi il 10-35% delle produzionicerealicole mondiali si realizza-no in aree in cui i livelli di inqui-namento sono tali da ridurre dialmeno il 5-10% le rese (in ter-mini meramente quantitativi),nel 2025 si ritiene che l’esten-sione di tali zone sarà almenotriplicata, se non verranno intra-prese iniziative per abbattere leemissioni di precursori, princi-palmente rappresentati da idro-carburi incombusti e ossidi diazoto. In aggiunta ai ben dimo-strati effetti negativi sulle pro-duzioni vegetali in termini quan-titativi, è indiscutibilmenteimportante valutare anche gliaspetti qualitativi.
GGiiaaccoommoo LLoorreennzziinnii
Effetti dell’esposizione all’aria ambiente per quattro settimane dei cloni di trifogliobianco (Trifolium repens) NC-S (sensibile all’ozono) (a sinistra) e NC-R (resistente)(a destra). Indagini standardizzate di questo tipo vengono condotte a livello europeoda una decina di anni.
Premio “Donato Matassino”Edizione 2008
Il Premio “Donato Matassino”, destinato ad una tesi didottorato di ricerca in “Genetica applicata alla zootecnia”,per il 2008 è stato assegnato a Mariasilvia D’Andrea per
la tesi “Analisi strutturale e funzionale di alcuni GeniCandidati per la qualità della carne”, con la seguente moti-vazione: Il lavoro affronta lo studio di alcuni geni che influisco-no sull’accrescimento e sulla lipogenesi del suino con metodolo-gie avanzate. I risultati ottenuti aprono prospettive di applica-zioni in campo zootecnico e sono di interesse anche per la com-prensione dei meccanismi di lipogenesi.Il Premio sarà consegnato nell’ambito della Cerimonia perl’Inaugurazione del 256° Anno Accademico dei Georgofili.
7informazioni dai Georgofili 21 marzo 2009
Il punteruolo rossodelle palme
Il punteruolo rosso, Rhyncho-phorus ferrugineus (Olivier), èun coleottero di origine asia-
tica che vive a spese di numero-se specie di palme. Le primeinfestazioni su palma da datteri,nella penisola Arabica, risalgonoalla metà degli anni ’80 e dopoun decennio l’insetto ha rag-giunto il bacino del Mediter-raneo. In Spagna è stato segna-lato nel 1993, ma solo a partiredal 2004, le sue infestazioni sisono rapidamente estese nellearee costiere di Italia, Francia,Turchia, Malta, Grecia ePortogallo, Paesi nei quali il pun-teruolo si è inizialmente insedia-to su Phoenix canariensis soprat-tutto adulte e di sesso maschile.In Italia il curculionide è ormaipresente in Sicilia, Campania,Lazio, Puglia, Marche, Abruzzo,Calabria, Basilicata, Liguria eSardegna, favorito nella sua dif-fusione dal trasferimento dipalme infestate asintomatiche edalla mancata, o scorretta, elimi-nazione delle palme con sinto-mi conclamati d’infestazione.Nelle aree a clima tropicale laspecie compie più generazioninel corso dell’anno ognuna dellequali si completa in circa 3 mesie mezzo. La femmina vive circa 3mesi e depone in media 200uova nelle ferite delle palme. InItalia l’insetto è attivo nel corsodell’intero anno nei vari stadi bio-
logici; poco efficaci sono i fattoribiotici di mortalità in massimaparte rappresentati dalle infezio-ni di un fungo entomopatogenodel genere Beauveria. Irrilevanteè il ruolo degli insetti entomofa-gi. L’acaro Centrouropoda almero-dai Wisniewski et Hirschmann èuna specie foretica che è riuscitaa colonizzare stabilmente lo stes-so habitat del suo ospite senzaarrecargli danni apparenti.Attualmente per il controllodelle infestazioni occorre fareriferimento alle “Disposizionisulla lotta obbligatoria contro ilpunteruolo rosso della palmaRhynchophorus ferrugineus” dellaGURI del 13 febbraio 2008 cherecepiscono le decisioni dellaCommissione 2007/365/CE. Inconsiderazione del dilagaredelle infestazioni anche su altrepalme e della scarsa efficaciadegli insetticidi utilizzabili inambiente urbano per la lotta alpunteruolo, il Ministero dellaSalute, nel febbraio 2008, haautorizzato, per motivi eccezio-nali fino al mese di ottobre, l’im-piego di alcuni prodotti insetti-cidi. Attualmente l’uso di taliprodotti, non è legale e pertan-to molte amministrazioni pub-bliche hanno sospeso i tratta-menti fitosanitari, concedendouna tregua al punteruolo. I trat-tamenti chimici curativi richie-dono l’impiego di insetticidi siste-
mici e una diagnosi precoce del-l’infestazione; trattamenti tardivi,oltre ad essere inutili per risolve-re l’attacco nella pianta infestata,sono anche di scarsa efficacia inquanto non raggiungono il ber-saglio poiché gli stadi preimmagi-nali all’interno delle palme sfug-gono all’azione letale degli inset-ticidi. Il metodo endoterapicooffre maggiori garanzie riguardoalla deriva dei prodotti insetticidi,tuttavia occorrono ulteriori spe-rimentazioni per la sua messa apunto. In Sicilia, in forza delDecreto regionale del 6 marzo2007, l’Azienda Foreste Dema-niali a partire dal luglio 2007, haprovveduto all’abbattimento ealla distruzione di circa 8.000delle oltre 10.000 palme infesta-te segnalate dal Servizio Fitosani-tario Regionale. Purtroppo nu-
merose sono le palme infestatenon segnalate dai privati che,spesso, non eliminano le foglie egli stipiti infestati in maniera cor-retta. Una possibile soluzioneduratura ed ecocompatibile delproblema è ancora lontana e varicercata nella individuazione difattori di resistenza delle palme edi vulnerabilità del punteruolorosso; a tale scopo è necessarioapprofondire le conoscenze sullabiologia e l’etologia nonché suifattori biotici e abiotici di conte-nimento della specie nei nostriambienti a clima mediterraneoben diverso da quello tropicaledelle aree d’origine. Tali aspettisono stati esaminati nel corsodell’incontro organizzato dall’Ac-cademia dei Georgofili a Paler-mo lo scorso 19 marzo.
SSaannttii LLoonnggoo
Palme delle Canarie infestate da Rhynchophorus ferrugineus
Le piante per accrescersi e diffe-renziarsi devono approvvigio-narsi di nutrienti minerali che
sono quasi totalmente ma nonesclusivamente prelevati dal suolo.La disponibilità dei nutrienti minera-li, specialmente per quelli che devo-no essere acquisiti in quantità eleva-te, potassio, azoto, fosforo e zolfo, èscarsa e per la produzione agricolaessi vengono somministrati, comefertilizzanti. Inoltre la loro disponibili-tà è disomogenea a causa dellanaturale difformità dei suoli perstruttura e capacità di legare inutrienti.Per questo motivo la quan-tità di nutrienti forniti con le fertiliz-zazioni sono solo in parte assorbitidalle radici ed una quota consisten-
La percezione delle piante dei nutrienti minerali: una strategia per incrementarne l’efficienza d’uso
te dilavata con un elevato dispendioeconomico e cosa ancor più gravecreando un degrado ambientale econdizionando negativamente lasostenibilità delle colture. Infine ilmiglioramento genetico operato,spesso non ha tenuto nel debitoconto la nutrizione minerale e inquesto periodo gli organismi sele-zionati hanno sviluppato grandi pro-duttività ma con scarsa efficienzad’uso dei nutrienti. Più recentemen-te l’efficienza d’uso dei nutrienticostituisce un primario parametro diselezione.Attualmente si sa che l’as-sorbimento dei nutrienti per poteravvenire necessita di un elevato con-tributo di energia metabolica e dientità biochimiche capaci di rendere
possibile questa funzione. Questeentità non sono sempre presentinelle radici ma vengono espressesolo quando sono effettivamentenecessarie per l’assorbimento, perrispondere ad un generale criteriodell’evoluzione essenzialmente mi-rato a favorire lo sviluppo nel suocorso del risparmio delle risorse. Lapresenza dei sistemi di trasporto èquindi controllata da una fitta rete disegnali. Primo fra tutti questi segnaliè la presenza dei nutrienti nella rizo-sfera, ma di grande importanzasono anche i segnali metabolici all’in-terno della cellule di tutta la piantacompresa la parte aerea, che per-mettono un “dialogo” tra i sistemipreposti all’assorbimento ed il meta-
bolismo, evitando tra l’altro l’accu-mulo di molecole tossiche e realiz-zando uno sviluppo armonico inrelazione all’effettiva disponibilità deinutrienti; un ulteriore importantefattore è il tempo intercorrente dallapercezione dei segnali all’operativitàdi questi sistemi. Il dialogo è affidatoa molecole segnale, alcune dellequali sono conosciute, quali meta-boliti, ormoni ed altre quali piccoliframmenti di acidi nucleici sono direcentissima individuazione. La co-noscenza di questa rete di segnala-zione è la nuova frontiera per la sele-zione di organismi capaci di migliora-re l’efficienza d’uso dei nutrienti.
MMaauurriizziioo CCooccuuccccii
8 informazioni dai Georgofili21 marzo 2009
Le biotecnologie possonocontribuire a rendere unaspecie vegetale resistente
ad una malattia anche in assen-za del carattere di resistenza nelpatrimonio genetico di quellaspecie. Un recente lavoro, realiz-zato presso l’ENEA e pubblicatosu Nature Biotechnology, s’inse-risce in quel gruppo di strategieper l’ottenimento di piante resi-stenti a virus che va sotto ilnome di “resistenze derivate dalpatogeno” (PDR). Opportunesequenze derivate dal patrimo-nio genetico di un virus sono ingrado di rendere la pianta resi-stente alla malattia provocata daquello stesso virus.La tecnologia PDR è stata usata
Resistenze derivatedal patogeno
con successo, fin dal 1986, perintrodurre resistenza ad impor-tanti virus vegetali. Tuttavia,mentre le PDR si sono rivelateestremamente efficaci nei con-fronti di virus con genoma adRNA, ad oggi non altrettantopuò dirsi nei confronti di quellicon genoma a DNA come igeminivirus, che causano ingentidanni alla produzione agricolamondiale (es. mais, manioca,cotone, pomodoro).Le cause della scarsa efficaciadelle PDR nei confronti deigeminivirus non erano cono-sciute. I dati prodotti dall’ENEAhanno permesso di identificarequello che costituisce il tallonedi Achille delle PDR contro i
geminivirus, fornendo quindi ilpresupposto indispensabile perlo sviluppo di strategie volte asuperare tale ostacolo. In breve,se il prodotto proteico derivatodal patogeno non è in grado dibloccare completamente lareplicazione virale, allora que-st’ultima attiverà un meccani-smo della pianta, il silenziamen-to dell’RNA, che porta alladegradazione sequenza specifi-ca delle molecole di RNA omo-loghe al genoma virale, senzatuttavia bloccare in maniera effi-cace l’infezione; come conse-guenza il silenziamento del-l’RNA inattiverà il transgene diorigine virale provocando quin-di la perdita della resistenza.Parte dei dati riportati nel lavo-ro è oggetto di un brevettoENEA-CNR e riguarda lo svi-luppo della tecnologia che con-sente di potenziare la resistenzaai geminivirus ottenuta tramitele PDR. In particolare, questa
nuova tecnologia si basa sul-l’espressione in pianta di unprodotto proteico di originevirale, che viene però codificatonon dal gene virale tal quale, mada un gene sintetizzato “adhoc”. Il gene sintetico è costrui-to introducendo nella sequenzavirale mutazioni silenti. In que-sto modo si ottiene una nuovasequenza genica con capacitàcodificante uguale a quella dellasequenza originaria, ma in gradodi “sfuggire” al silenziamentogenico indotto dall’infezionevirale.L’aver compreso il punto debo-le delle PDR ai geminivirus hapermesso, da un lato lo svilup-po di una nuova strategia mole-colare per combattere questaimportante classe di patogeni edall’altro una maggiore consa-pevolezza sulle prospettive chele PDR possono offrire a lungotermine.
LLuuiiggii RRoossssii
Il 7 novembre 2008 presso ilnostro Ministero per gli AffariEsteri è stato celebrato il 30°
anniversario del trattato di col-laborazione scientifica e tecno-logica fra Italia e Cina; alla sedu-ta plenaria del Convegno erapresente per la Cina il Vice Mi-nistro per la Scienza e la Tec-nologia Cao Jianlin e per l’Italiail Sottosegretario al M.A.E. On.Craxi; a proposito delle ricer-che nel settore agricolo èintervenuto il Prof. BaozhongSun dell’Institute of AnimalScience (Chinese Academy forAgricultural Sciences) diPechino, che ha parlato dell’in-troduzione della Razza BovinaPiemontese in Cina, dei buonirisultati ottenuti e dei program-mi di ricerca in atto o proponi-bili nell’ambito degli accordi dicollaborazione tuttora vigentiche coinvolgono il CNR, ilDipartimento di ScienzeZootecniche dell’Università diTorino, l’Assoc. Allev. Bov. R.Piemontese e l’Institute ofAnimal Science di Pechino.L’inizio di tale collaborazionerisale al 1984; nel 1986 venneroinviate circa duemila dosi diseme da tori di razza
Il contributo italiano al miglioramento quanti-qualitativodella produzione di carne bovina in Cina
Piemontese e Chianina alCentro di F.A. di Nanyang(Henan); dopo i buoni risultatiottenuti dall’incrocio tra lerazze italiane e la Yellow cinesevenne scelta la Piemontese. Nel1989 si procedette al trapiantodi embrioni e nel 1990 nacque-ro i primi tre soggetti di razzaPiemontese: un maschio e duefemmine che costituirono ilprimo nucleo in purezza con laconseguente produzione localedi seme utilizzato per otteneremeticci da destinare al macello,ma anche soggetti di razza purae quindi embrioni per la crea-zione di centri di F.A. in molteProvince cinesi. Nel frattempodall’Italia vennero ancora inviatiembrioni e seme fino a quandola comparsa sulla scena dellaBSE ha bloccato ogni movimen-to di germoplasma e quindi gliallevatori cinesi dovettero pro-cedere autonomamente.All’inizio del terzo millennio larazza Piemontese è presente in12 Province con circa 200 capidi cui un centinaio di tori, maattualmente le Province interes-sate sono una ventina. Ognianno vengono destinati almacello centinaia di migliaia dicapi ottenuti dall’incrocio con la
razza locale; questi capi per-mettono una produzione supe-riore di almeno il 10% a quelladei soggetti locali e la qualitàdel prodotto è decisamentemigliore.La situazione può essere consi-derata buona, ma è in evoluzio-ne per due motivi: il primoriguarda la tendenza in deter-minati comprensori a sostituirela razza locale con laPiemontese e quindi negliincroci si procede oltre la F1; il
secondo concerne la necessitàdi migliorare geneticamente laPiemontese, privata per tantianni di germoplasma importa-to dall’Italia, e per questoscopo è prevista la creazione diun Centro Genetico con relati-vo Libro genealogico nellaMunicipalità di Xinye (Henan).A questo fine da parte italianaè stata data ed è assicurata peril futuro l’indispensabile assi-stenza scientifica e tecnica.
AAttttiilliioo BBoossttiiccccoo
Torelli F4 nel cortile prospiciente la stalla in un allevamento di Xinye
9informazioni dai Georgofili 21 marzo 2009
Alcune caratteristichedegli insetti, quali l’eleva-ta densità delle popola-
zioni, la mobilità e la distribu-zione capillare, li rendono ido-nei a diffondere in natura varieentità biologiche, funzione diutilità cruciale, ad esempio, perl’impollinazione di molte specievegetali ma estremamentedannosa per la diffusione diagenti fitopatogeni. Mentre iltrasporto di funghi e batteri haluogo passivamente, in forma dispore portate sulla superficiedel corpo, la trasmissione divirus presume sempre l’esisten-za di interazioni molecolaricomplesse tra patogeno einsetto vettore. Anche nellaforma apparentemente piùsemplice di trasmissione, quellanon-persistente, l’adsorbimentodel virus agli stiletti boccali degliafidi è mediato dalla proteinadel rivestimento virale (capside)oppure da proteine non strut-turali, codificate dal virus, cheagiscono come ‘ponte’ tra parti-cella virale e recettori allocatisulla cuticola dell’insetto. Lasostituzione di un solo aminoa-
Trasmissione dei virusdelle piantemediante insetti
cido nella catena proteica capsi-dica è sufficiente a sopprimerela trasmissibilità del virus. Benpiù complessa è l’interazionevirus-vettore nel processo ditrasmissione circolativo: il virusviene ingerito dall’insettodurante l’alimentazione e, per-corsa buona parte dell’appara-to digerente, penetra nella pa-rete dell’intestino medio oposteriore per endocitosi. Attra-versata la parete intestinale, nefuoriesce (esocitosi) e si diffon-de nell’emolinfa che lo traspor-ta alle ghiandole salivari. Supe-rata la membrana plasmaticabasale per endocitosi-esocitosi,il virus penetra nelle ghiandoleaccessorie, dalle quali viene poiinoculato nelle piante con lasaliva secreta durante l’attivitàtrofica. La proteina virale per-tanto, a differenza delle altreingerite, non viene degradatanel corpo dell’insetto consen-tendo così la ‘sopravvivenza’ delvirus. Nel caso dei Luteovirus èprovato che le particelle viralisfuggono la degradazione graziead una proteina – omologa allaproteina procariotica GroEL, o
simbionina – che è prodotta dalbatterio Gram-negativo Bu-chnera aphidicola, endosimbiontedegli afidi e interagisce con ilcapside virale stabilizzandolo.Il progredire delle conoscenzesulle dinamiche molecolari pre-
poste alla trasmissione dei virusmediante insetti potrebbe aprirela via a mezzi di lotta innovativi,più idonei a contenere le infe-zioni con rischi ridotti per l’am-biente e per la salute dell’uomo.
MMaauurriizziioo CCoonnttii
Frutti di albicocco con aree necrotiche depresse, colpiti da cascola nelle fasi inizia-li di sviluppo in seguito a infezione con il virus della vaiolatura delle drupacee(PPV), o ‘Sharka’. In alto, frutto coetaneo da pianta sana.
La trasmissibilitàdei prioni
L’Encefalopatia SpongiformeTrasmissibile (TSE) secon-do alcuni studiosi era cau-
sata da un virus di minime di-mensioni (“virino”), secondo al-tri era semplicemente la modifi-cazione strutturale di una pro-teina in una isoforma infettivadenominata “prione” (pprroteina-ceus iinfectious oonnly). Oggi sitende a dimostrare che la tra-sformazione di un normale prio-ne in una molecola molto simi-le, ma infettiva e capace di tra-sformare quelle vicine, può alte-rare la memoria a lungo termi-ne anche nell’uomo. L’infettivitàdi tale molecola pone gravi pro-blemi a tutto il comparto agro-alimentare.
Come si ricorderà, nonostante lapresenza di TSE in capi animali enell’uomo sia stata rivelata qual-che decennio fa, il clamore me-diatico ha raggiunto i livelli piùelevati in occasione dell’insor-genza e diffusione della BSE (En-cefalopatia Spongiforme Bovina)in Gran Bretagna prima e poi inEuropa. Oggi, una nuova manife-stazione e diffusione negli StatiUniti ed in Canada di malattiespongiformi trasmissibili che col-piscono i cervidi selvatici (CWD,Chronic Wasting Disease) èfonte di preoccupazione per unapossibile propagazione anche inEuropa. Recentemente sonostati isolati prioni anche in tessuticerebrali di delfini: la loro se-
quenza amminoacidica presentaun discreto grado di omologiacon quella dei bovini.L’aspetto più preoccupanteforse riguarda proprio il salto dispecie nella trasmissione dell’in-fettività che, nel caso della BSE,è stata veicolata dal bovinoall’uomo attraverso la dieta.Risultati di recenti studi interna-zionali, alcuni dei quali anchenostri, inducono a ritenere chele vie di trasmissione possanoessere anche diverse. Oggi lepur limitate conoscenze dispo-nibili portano a ritenere che ilsuolo possa rappresentare unveicolo di propagazione dell’in-fettività fra animali al pascolo.Analogamente, le più plausibilivie di apporto di prioni ai sedi-menti possono essere ricondu-cibili a meccanismi biochimici efisiologici indotti da squilibrinutrizionali delle specie acquati-che; la relazione sedimento-prione ed il rischio ambientale
ad essa associato è ormai unapriorità di ricerca della comuni-tà scientifica internazionale.Il primo studio sistematico in taledirezione risale al 2006. Leita ecoll. hanno dimostrato la tenaciacon cui la proteina prionica cel-lulare si può legare a suoli agri-coli. Si è cercato di approfondirele dinamiche della forte intera-zione che potrebbe essere all’o-rigine della persistenza del prio-ne nel suolo. Alcuni studi mo-strano che l’adsorbimento di-pende dalla loro carica superfi-ciale. Oggi come prova d’infetti-vità del materiale adsorbito sonodisponibili saggi in vitro.La maggior parte degli studifinora trascurano la componen-te organica, indispensabile percapire l’effettiva dinamica diinterazione tra suolo e prione.Ed è proprio in tale direzioneche si sta lavorando.
PPaaoolloo SSeeqquuii ee LLiivviiaannaa LLeeiittaa
10 informazioni dai Georgofili 21 marzo 2009
In Cina da più di 1500 anni lefoglie di Artemisia annua L.sono state impiegate in sem-
plici preparazioni di decotti perle loro proprietà febbrifughe.Soltanto agli inizi degli anni ’70è stata provata la sua attivitàanche nei casi di febbri malari-che e successivamente è statoidentificato il principio attivoresponsabile dell’attività antima-larica: l’artemisinina. L’artemisi-nina si trova nelle parti aereedella pianta, principalmentenelle foglie e nelle infiorescenze,con tracce negli steli e totaleassenza nel polline e nelle radi-ci. La sua concentrazione èmolto bassa, tra 0,01 ed 0,8%rispetto al peso secco delladroga. Nei nostri studi abbiamovalutato l’attività antimalaricaanche di altri costituenti il fito-complesso dell’Artemisia annuaL., in particolare dei flavonoidipolimetossilati, dimostrandoche essi presentano un sinergi-smo di azione antimalarica.Questa scoperta rende parti-colarmente interessante, spe-cialmente per i Paesi in via disviluppo, la possibilità di impie-gare con successo nella terapiaantimalarica l’estratto di Artemi-sia annua L. a prezzi molto bassi,al posto del principio attivo
Artemisia, tè verde e foglie d’olivo:antimalarici con azione sinergica
isolato notevolmente costo-so.Recentemente nell’ambito di unnostro screening per valutare leproprietà antimalariche di nu-merosi estratti di droghe vege-tali di largo impiego, abbiamoverificato che sia i decotti di tèverde (Camellia sinensis L.) chequelli di foglie di olivo (Oleaeuropaea L.) presentavano unasignificativa seppur modestaattività antimalarica. Nella medi-cina tradizionale mediterranea ildecotto di foglie d’olivo èimpiegato principalmente per lasua attività antiipertensiva, matalvolta se ne riscontra l’usoanche come febbrifugo. Del tèverde, originario del continenteasiatico ed attualmente diffusoin tutto il mondo, non era maistata riportata l’attività antima-larica mentre ne sono ricono-sciute numerose proprietàsoprattutto come antiossidantenel migliorare in generale lasalute; recentemente è stataipotizzata una possibile attivitàdei suoi principi attivi comeagenti anticancro. I costituenticaratteristici, le gallocatechinedel tè e l’oleuropeina nel decot-to di foglie di olivo sono statiindividuati come i probabiliresponsabili dell’azione antima-
larica riscontrata. Molti interes-santi sono i risultati ottenutivalutando l’attività antiplasmo-dica (il plasmodio è il vettoredella malaria) di bassi dosaggidi artemisinina, 1.25 nanomola-re, molto al di sotto quindi
della concentrazione 40 nano-molare efficace nei confrontidel plasmodio, se associata atali estratti. In alcuni casi siottengono semplicemente de-gli effetti additivi, ma esistonocombinazioni par ticolari traartemisinina e gli estratti di fo-glie d’olivo e di tè verde o deiloro costituenti caratteristiciche mostrano evidenti azionisinergiche.
FFrraannccoo FFrraanncceessccoo VViinncciieerrii
Artemisia annua L.
Accade nel mondo. Secondo il Servizio interna-zionale per l’acquisizione dellebiotecnologie agricole (Isaaa)nel 2008 sono stati coltivati nelmondo 125 milioni di ettari dicolture geneticamente modifi-cate, 10,7% in più rispetto al2007. (11 febbraio)
. Gli assessori regionali all’agri-coltura di tutte le regioni italia-ne chiedono al ministro ilrispetto del titolo V della Costi-tuzione che conferisce alleregioni competenze esclusive inmateria di agricoltura. Lo hannofatto con un documento i cuicontenuti sono stati “accoltidalla piena totalità dei rappre-sentanti regionali … Indipen-dentemente dalla appartenenzapolitica”. (9 febbraio)
. La produzione di cavolfiorein Gran Bretagna nel corso del-l’ultimo decennio è diminuita di
circa il 35% (a vantaggio deibroccoli italiani) mentre crescela preoccupazione che gli agri-coltori la stiano abbandonando.Lo scrive l’autorevole “TheTimes”. (9 febbraio)
. Secondo una statistica delministero dell’agricoltura nel-l’anno economico 2007-2008in Germania le entrate delleprincipali aziende agro-alimen-tari sono aumentate del 21,2%(49,884 euro). (7 febbraio)
. Secondo quanto deciso inuna riunione del Consiglio diStato, la Cina ha portato il livel-lo di allerta per l’emergenza sic-cità da arancione a rosso, il livel-lo più alto, in risposta alla peg-gior siccità che ha colpito alcu-ne zone del Paese negli ultimicinquanta anni. (5 febbraio)
. Le vendite di champagnesono calate in volume del 4,8%nel 2008 rispetto al 2007,
secondo le statistiche di spedi-zione comunicate oggi dalComitato interprofessionale deivini di champagne (CIVC). (5febbraio)
. Nella Striscia di Gaza “ladistruzione del settore agricoloha peggiorato la già grave situa-zione della produzione alimen-tare causata da 18 mesi di chiu-sura delle frontiere”. Lo rendenoto la Fao, denunciando lamancanza di cibo a sufficienzaper gli abitanti della striscia. (30gennaio)
. Una quantità sempre mag-giore di cittadini tedeschi com-pra vino prodotto in Germania.Secondo l’Istituto tedesco delvino (DWI), nel 2008 un tede-sco su due (49,4%) ha compra-to vino prodotto nel Paese. (30gennaio)
. Tom Vilsack è stato nomina-to ufficialmente segretario di
stato all’agricoltura americano.(28 gennaio)
. Il ministro delle politiche agri-cole Luca Zaia ha consegnatopersonalmente, al direttore ge-nerale della Fao Jacques Diouf, lalettera di invito al primo verticedei ministri dell’agricoltura deiPaesi G8. (28 gennaio)
. Il 65% di tutto ciò che laNuova Zelanda vende nel mon-do proviene dal settore agrico-lo. Questo contributo è ascrivi-bile solo al 14% della popola-zione della Nuova Zelanda. (18gennaio)
. Il prezzo del riso potrebbeaumentare nel 2009, per ilsecondo anno di seguito, mal-grado la crisi economica mon-diale. Lo ha stimato l’istituto diricerca internazionale sul riso(Irri) con sede nelle Filippine.(12 gennaio)
LLeettiizziiaa MMaarrttiirraannoo
11informazioni dai Georgofili 21 marzo 2009
Arrigo Serpieri
Arrigo Serpieri è nato aBologna il 15 giugno 1877.Allievo di Vittorio Niccoli,
e da lui formato alla scuola diCuppari e di Ridolfi, si è laureatonel 1900 col massimo dei voti ela lode alla Scuola Superiore diAgricoltura di Milano.Nel 1906 è diventato Profes-sore ordinario nell’Universitàdegli Studi di Perugia e l’annoseguente è stato chiamato aMilano, alla Cattedra di Econo-mia e Estimo, in precedenza diVittorio Niccoli.Nel 1911 il Ministro dell’Agri-coltura Ranieri gli affidò l’incari-co di preparare una nuova legi-slazione forestale e, l’annoseguente, Francesco SaverioNitti, nuovo Ministro dell’Agri-coltura, lo incaricò di organizza-re l’Istituto Superiore forestaledi Firenze, che sostituì l’Istitutodi Vallombrosa.Dal 1912 è stato Direttoredell’Istituto superiore forestale diFirenze e titolare della cattedra diEconomia e Estimo Forestale.Incarichi che ha conservato fino al1925, quando l’Istituto fu trasfor-mato in Istituto superiore agrarioe forestale.Assunse allora la dire-zione dell’Istituto di Economia ePolitica agraria e la Cattedra diEconomia agraria, conservandoper incarico l’insegnamento dellaEconomia e estimo forestale.Dopo la Guerra 1915-18 par-tecipò a Parigi alle trattativeinternazionali per la determina-
zione dei danni di guerra; costi-tuì con Meuccio Ruini e LuigiSturzo il Segretariato per laMontagna che presiedette finoal 1935.Nel 1923 è stato per un annosottosegretario per l’agricolturanel Ministero dell’Economianazionale. Ha prodotto unanotevolissima attività legislativa.Varò 15 provvedimenti, fra iquali le prime “leggi Serpieri”, il“Riordinamento e riforma dellalegislazione in materia di boschie di territori montani” e i “Prov-vedimenti per le trasformazionifondiarie di pubblico interesse”.Nel 1924 fu eletto al Parlamen-to. Presiedette la Commissioneagricoltura della Camera e ilComitato Interministeriale perle trasformazioni fondiarie.Nel 1926 assunse la Presidenzadell’Accademia dei Georgofili,che conservò fino al 1944.Impresse alla gloriosa Istituzioneun nuovo slancio, fino a render-la sede di analisi degli aspettipiù importanti e controversidell’agricoltura del Paese, nellasua accezione di agricoltura,foreste, allevamenti, territorio esocietà rurale. In quella sede, fral’altro, presero forma concettua-le e struttura normativa i princi-pali provvedimenti di legge sullabonifica e la colonizzazione, larevisione e l’aggiornamento del-l’imposizione fiscale in agricoltu-ra, la “carta della mezzadria” e lelinee di una adeguata legislazio-
ne in materia di contratti agrari.Nel 1929 gli fu conferito unsecondo sottosegretariato, conl’incarico di organizzare e dirigerela bonifica integrale del Paese. Edè così che, dopo 5 anni dalla leggen.753 del 1924,quando il Paese sidibatteva in una crisi industrialedagli ampi risvolti di disoccupazio-ne e di urbanesimo, di inflazione edi deflazione, il finanziamento diuna stagione di forti iniziativedello Stato nel campo delle operepubbliche di bonifica contribuì adattenuare gli effetti complessivi diuna crisi altrove più devastante.Un “new deal” ante litteram, per-corso imitato dall’Amministra-zione Roosevelt nel superamento
della grande crisi economica origi-nata nel 1929 negli Stati Unitid’America.Predispose un TU sulla bonificaintegrale destinato a essereesemplare ben oltre la duratadella sua vita: il RD 13 febbraio1933, n. 215, ancora ricordatocome “legge Serpieri” sullabonifica integrale.È stato Presidente dell’Associa-zione nazionale dei consorzi dibonifica, membro della Cameradelle Corporazioni, Presidentedella relativa Sezione agricoltu-ra e Presidente della Commis-sione Censuaria Centrale.Nel 1937 venne nominato Ret-tore dell’Università di Firenze enel 1939 Senatore. Sempre nel1939 venne insignito del premiodell’Accademia d’Italia per i suoistudi e per l’opera profusa nellabonifica integrale.Nel 1947 è stato nominatoProfessore emerito.Nel 1954 gli fu conferita la me-daglia d’oro di “distinzione geor-gofila” e, nel 1957, con decretodel Presidente della Repubblica,la medaglia d’oro dei benemeri-ti della Scuola, della Cultura edell’ Arte.Nel 1958 si ammala gravemen-te; il 30 gennaio 1960 muore.Notevole è stata la sua operadi studioso, ricercatore e mae-stro nel campo delle disciplineeconomico agrarie, alle quali haconferito autonomia dottrinariae impianto metodologico insu-perato.
MMaarriioo DDiinniiI Colleghi della Facoltà di Agraria di Firenze festeggiano il prof. Serpieri (al centro della foto) per il suo ottantesimo compleanno (1957).Dal basso all’alto e da sinistra a destra: Generoso Patrone, Marino Gasparini,Angelo Camparini,Arrigo Serpieri,Antonio Biraghi, MarioTofani, Giovanni Vitali, Alessandro Morettini, Enzo Giorgi, Ernesto Alinari, Gino Florenzano, Renzo Giuliani, Roberto Corti, Pier LuigiPini, Gino Baldini,Vincenzo Bellucci e Sergio Orsi.
Arrigo Serpieri in un bassorilievo realizzato nel 1965 da Antonio Berti perl’Accademia dei Georgofili e collocato, con un’apposita Cerimonia il 3 aprile 1966,nella Sala del Consiglio.
12 informazioni dai Georgofili21 marzo 2009
Agricoltori d’avanguardia, uomini illuminati e lungimiranti, fondarono la nostra Accademia più di 250 anni fa ed hannosempre rappresentato una componente essenziale nelle attività dei Georgofili. Seguendo il rapido evolversi delcomplesso mondo che ruota intorno all’agricoltura, gli imprenditori del settore hanno continuato ad assumere ruoli
avanzati, aprendo strade ed orizzonti nuovi, sempre più incisivi, specialistici ed agguerriti nel confronto su mercati ormaiglobali.Questo nuovo strumento di informazione intende dedicare un suo spazio per evidenziare la figura e le benemerenze dialcuni fra gli illustri Georgofili che sono oggi imprenditori d’avanguardia e guidano modelli evolutivi delle attività agricoleverso il futuro.
Gianni Zonindel suo amico toscano FilippoMazzei di produrre vini di gran-de classe da varietà internazio-nali, facendo diventare la Virginiaun Wine Country a livello mon-diale.Il fattore vincente della CasaVinicola Zonin è la qualità nelladimensione; il marchio Zonin,infatti, intende “garantire unaottima qualità di vini per unnumero importante di consuma-tori, perché un buon vino nondeve rimanere un privilegio perpochi”. E la filosofia delle tenutedi famiglia è altrettanto vincenteperché è fondata sulla difesadelle identità e del patrimoniorurale, sul continuo progressoqualitativo, sulla gestione moder-na delle tecniche culturali fruttodella passione dei 32 enologi eagronomi viticoli dell’azienda esulla coltivazione-valorizzazionedei vitigni autoctoni dal Refoscodel peduncolo rosso alGrignolino, dal Brachetto allaBonarda, dal Negroamaro allaBarbera, dal Nero d’Avolaall’Insolia, per finire con gliautentici toscani Vermentino eSangiovese .Per il complesso delle sue attivi-tà e delle eccellenze conseguite,Gianni Zonin nel 1989 è statoinsignito dal Presidente dellaRepubblica Italiana dell’onorifi-cenza di Cavaliere del Lavoro.Numerosi sono i riconoscimen-ti e le cariche ricoperte a con-ferma del prestigio riconosciutoin molti ambiti economici nelnostro Paese. Nell’ambito ban-cario-assicurativo è Presidentedal 1996 della Banca Popolaredi Vicenza, della società NordEst Merchant, Vice PresidenteCattolica Assicurazioni, Consi-gliere dell’Associazione Banca-ria Italiana. Sotto la sua guida laBanca Popolare di Vicenza si è
DDiirreettttoorree rreessppoonnssaabbiilleePaolo Nanni
RReeddaazziioonneeAccademia dei GeorgofiliLogge Uffizi Corti 50122 FirenzeTel.: 055212114, 055213360Fax: [email protected]
SSttaammppaaF.&F. Parretti GraficheFirenze
RReegg.. TTrriibb.. FFiirreennzzee nn.. 55556622 ddeell 2211//33//22000077© Accademia dei Georgofili ISSN 1974-269X (print)
Ogni responsabilità relativa aicontenuti dei singoli scritti èdei rispettivi autori.
sviluppata per dimensioni e perstruttura ed è diventata unGruppo bancario di respironazionale, presente con banchecontrollate nelle principalimacroregioni italiane, come laCariprato che opera in tutta laToscana. Nel settore industrialeè Membro del Consiglio Diret-tivo dell’Associazione Italiana
dell’Industria di Marca, “Cen-tromarca”. Nell’ambito vitivini-colo è stato presidente dellaUnione italiana Vini ed è mem-bro e consigliere dell’ “Acca-demia Italiana della vite e delvino”. Dal 1999 è AccademicoCorrispondente dei Georgofilie da quest’anno è stato nomi-nato Accademico Ordinario.
Gianni Zonin è nato il 15gennaio del 1938 aGambellara (Vicenza) e
lo scorso anno ha festeggiato lesue “nozze d’oro” con la vitivini-coltura. La madre avrebbe volu-to che diventasse avvocato, malo zio lo chiama in azienda e lofa con ragione dal momentoche in questa esperienza GianniZonin riuscirà a sommare lospirito imprenditoriale ad unanon comune capacità di inter-pretare il potenziale di una re-gione, della sua terra e delle suevigne. Si diploma in Enologiapresso l’Istituto di ConeglianoVeneto e successivamente silaurea in Giurisprudenza. Sindalla prima giovinezza partecipaall’attività della famiglia, che dasette generazioni si dedica allaviticoltura, ed ha un forte lega-me con il territorio e un pro-fondo rispetto per la natura el’ambiente. Attività che hacostantemente perseguito sinda quando, nel 1967 l’aziendafamiliare si trasforma in “S.p.A.”,ed egli ne assume la Presidenza,a soli 29 anni. Oggi la famigliaZonin dispone di dieci granditenute distribuite nelle setteregioni vitivinicole di maggiorprestigio – Veneto, Friuli,Piemonte, Lombardia, Toscana,Sicilia e Puglia – per produrrevini di qualità elevata e si esten-dono complessivamente suoltre 3.500 ettari di terreno dicui 1.800 coltivati a vigna. Altri100 ettari su 500 di estensione,si trovano negli Stati Uniti inVirginia con la proprietà diBarboursville Vineyards, doveGianni Zonin ha realizzato ilsogno di Thomas Jefferson,terzo presidente degli USA, e
Georgofili imprenditori oggi