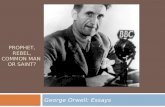Orwell.(27.10.2012)
-
Upload
glisfogliati -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of Orwell.(27.10.2012)
-
7/31/2019 Orwell.(27.10.2012)
1/4
I LI L FF U T U RU T U R OO H AH A R A DR A D I CI C II A N T I C H EA N T I C H E
www.pubblicogiornale.it SABATO 27 OTTOBRE 20 12DIRETTORE LUCA TELESE - A CURA DI CHRISTIAN RAIMO
diALESSANDRO LEOGRANDE
Oggi si fa una gran discussione intorno alla non-fiction. Qual il confinetra giornalismo e letteratura? possibile individuare una linea di demar-cazione o piuttosto una terra di mezza al cui interno, a sua volta, pren-dono corpo percorsi differenti tra loro? Fino a che punto consentito at-traversare i confini? Dove si colloca l'io in tutto questo (l'io che osserva,l'io che agisce, l'io che narra)? Grande la confusione sotto il cielo, spe-cie in Italia, tanto che converrebbe mettere un po' di ordine nel discorso.In America Latina (continente in cui il nuevo periodismo sembra risorge-re in forme sempre nuove: si pensi ad esempio alla rivista peruvianaEtiqueta negra, a s crittori come Juan Villoro e Carlos Monsivais, e andando indietro nel tempo al padre del genere, l'argentino Rodolfo
Walsh, autore dell'imprescindibile Operazione massacro, in seguito se-questrato e ucciso dai militari nel '77) molto chiara la distinzione tran ar r ativ o e no v elado. Quella che indichiamo come non-fiction, pur adot-tando forme letterarie plurime ( di Villoro la bella espressione o r n i to -rinco della prosa), appartiene al primo campo.Cos negli Stati Uniti. La distinzione tra memo ir, racconto del reale e let-teratura di invenzione piuttosto netta. La non-fiction ha raggiunto no-tevoli risultati, grazie anche allo storico ruolo delle riviste che pubblicanoreportage di 50-60 mila battute (Atlantic Monthly, The New Yorker,The Nation, The New Republic, Vanity Fair...) e ad autori come Wil-liam Langewiesche o Joan Didion.E in Italia? Il discorso sul Novecento sarebbe molto ampio: da Carlo Levia Primo Levi, da Anna Maria Ortese a Corrado Stajano e a molti altri...Tuttavia la tradizione della non-fiction italiana (se cos possiamo definir-la) viene da molto lontano. Si pensi ad alcune opere diversissime cheprovengono dal cuore dell'Ottocento: non solo Zibaldon e di GiacomoLeopardi o Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni, ma ancheDiario della spedizione dal 5 al 28 maggio (cio la Spedizione dei mille) diIppolito Nievo o La Sicilianel 1876 di Leopoldo Franchetti e Sidney Son-nino. In esse il racconto della realt (in buona sostanza dell'Italia chenon cambia) passa attraverso la creazione di strutture narrative che
preannunciano molti dei percorsi successivi.Non ci sono norme particolari che regolano queste scritture. Per due,tre idee di fondo possono essere recuperate.1 Il reporter non mai solo . Disse una volta Ryszard Kapuscinski chesenza l'aiuto degli altri non si pu scrivere un reportage.
SEGUE A PAGINA IV
GI O R N A LI S M O / N A R R AT I V A
La realt non quellacosa che inventi
ANDREA BOTTO, KA-BOOM #04, Perrero, 2011, C-print, cm 81x98
TUTTO IL CINEMA DI HERZOG
Oltre la vita
di PAOLO PECERE
Luned scorso Werner Herzog ha presentato i quattroepisodi della miniserie On Death Rownella cornice delTorino Film Festival. Si tratta dei brevi incontri tra Her-zog e quattro detenuti americani nel braccio della morte,corredati di brevissimi commenti e alcune sequenze gi-rate fuori dal carcere (il progetto era gi confluito un an-no prima nel film Into the Abyss).
SEGUE A PAGINA III
JA CO PETTI E LA TV-V ERIT
Il manipolatore
di GIUSEPPE SANSONNA
Il vortice di immagini in cui affoghiamo non ci chiariscele idee. Amplifica lambiguit, ricopre gli eventi di unatorbida patina spettacolare. Il video del bambino pado-vano trascinato dagli agenti di polizia viene condiviso ecommentato da migliaia di utenti sui social network, pri-ma di essere ingoiato dalla televisione. Eppure le dina-miche profonde della vicenda umana rimangono ignote...
SEGUE A PAGINA IV
0aeN3jsVhYXbNXVrfFsbyYt6EfUCxeBOVMOLAejLwcBppeNIFLw1CohAseADOZI+G RENTLWFaOoozwe /5rG Odo=
-
7/31/2019 Orwell.(27.10.2012)
2/4
IIS A B AT O
27 OTTOBRE 2012
PERCH CARRRE UN NUOVO CLASSICO
La sfida di Limonov
RUSHDIE, ELLIS, COETZEE
La vita affondata
dai romanzi
di DANIELE MANUSIA
Scrivendo le proprie memorie in terza persona Salman Rushdie ci stadicendo cheJoseph Antonsarebbe un bel libro anche se si trattasse diletteratura di finzione. Anche se fosse sol o un romanzo. Il che avrebbesenso, considerando che la storia di Rushdie, in sintesi, quella di unoscrittore che si complicato tremendamente la vita proprio con unromanzo, I versi satanici, valutato sul piano religioso (come qual cosa,quindi, di pi di un romanzo). Certo, avrebbe fatto meno fatica se sifosse limitato ad aprirci il suo cuore con una confessione sincera inprima persona, invece di rappresentarsi come un personaggio allin-
terno di quella riproduzione in scala della vita che il romanzo, contutto il lavoro di ricerca e le difficolt che deve aver comportato met-tere una vicenda come la sua, personale e di dominio pubblico, allagiusta distanza (alla fine del libro, ad esempio, Rushdie ringrazia gli ar-chivisti dellEmory University per il lavoro di catalogazione dei suoido cu m e n ti).Quella di Rushdie una scelta generosa che si pu spiegare come unomaggio al mondo della finzione da pa rte di uno scrittore che ha ri-schiato che il mondo reale prendesse il sopravvento sulle sue opere,fraintendendole e impedendogli la necessaria libert fisica e mentaleper produrne di nuove.(L'autore di questo pezzo, va detto, uno di quei sostenitori della su-periorit delle opere sulla vita, e in omaggio agli autori trattati e al lorocoraggio letterario lo dichiara usando la terza persona.)Rushdie cita Yeats: L'intelletto dell'uomo costretto a scegliere trala perfezione della vita e quella dell'opera e alla fine del primo capi-tolo ci dice che durante la stesura de I versi satanici, appeso al murodavanti alla scrivania (anche se non possiamo essere certi che il murodel Rushdie personaggio coincida con quello dell'autore del libro cheteniamo in mano), teneva un appunto per ricordarsi di cosa significaportare a termine un libro: Per guadagnare in futuro l'immortalit, oper lo meno la posterit, si perde, o perlomeno ci si rovina, l'esistenza
quotidiana nel presente.Che esistenza quotidiana e immortalit si ostacolino a vicenda il te-ma di fondo di altre due autobiografie, diciamo cos, anomale. BretEaston Ellis sembra sincero quando, nella prima parte di Lunar Park,parla in prima persona della sua sessualit e del rapporto col padre,dei problemi derivati dal success o ottenuto troppo velocemente (sol-di e droga). Prova anche a mettere in chiaro la sua tanto chiacchieratasessualit, solo che dopo una quarantina di pagine si trasferisce incampagna, in seguito ad attac chi terroristici mai avvenuti a New York,con una moglie e un figlio che nell a realt non esistono, anche se lamoglie attrice ha un vero sito con tanto di filmografia e il figlio Robbyuna pagina Myspace. Con un'esistenza quotidiana decisamente inva-dente, Ellis spinge la confusione dei piani fino a capovolgerli. Se nellavita vera riceveva lettere minatorie in cui anonimi lettori dicevano divolergli fare quelle stesse cose che lui aveva fatto alle vitti me di Ame -rican psycho (e a Toronto un serial killer si davvero ispirato al libro),in Lunar Park direttamente Patrick Bateman, protagonista di Ame-rican psycho, ad accusare al telefono il suo autore come responsabilemorale degli omicidi avvenuti all'interno di Lunar park. Se fossi in tedarei un'altra occhiata a quello sporco libercolo che hai scritto, gli di-ce Bateman.
In un certo senso come se Bret Easton Ell is si sovraesponesse senzapudore per rendere impossibile qualsiasi distinzione tra verit e men-zogna al di fuori del lib ro, come se ogni narratore fosse per statutoinaffidabile. J.M. Coetzee, invece, si spinge ancora pi in l dichiarandoapertamente, con la sua trilogia autobiografica, che ogni l ibro unabugia di cui sospettare.Gi a partire dai primi due libri, In fan ziae Gio v ent , Coetzee rompecon le convenzioni dell'autobiografia scrivendo in terza persona e altempo presente. Come stato notato da William Deresiewicz s ulNew York Times (pezzo a cui ispirato il titolo di questo) utilizzare ilpresente significa disattendere il patto con il lettore, solitamente libe-ro di collegare gli avvenimenti passati della narrazione con quello chesa dell'autore. Allo stesso modo in Gio v ent non c' traccia di talentoletterario, il futuro premio Nobel un poeta impiegato a ll'IBM, un ven-tenne dalle velleit frustrate. Rovesciando il paradigma romanticodell'artista guidato dalla propria interiorit, e quello esteta della vitacome opera d'arte, il suo racconto di formazione non porta a nulla.L'ultimo capitolo della trilogia, Tempo d'estate (2009), fonda la propriainaffidabilit sul presupposto di base che Coetzee morto e quelleche stiamo leggendo sono cinque interviste ad a ltrettante donne chelo hanno conosciuto. Donne che, per giunta, mettono continuamente
in discussione il modo in cui lo sconosciuto intervistatore porta avantile interviste. Una delle donne di Tempo d'estate chiede all'intervista-tore che tipo di libro abbia intenzione di mettere insieme: un libro dipettegolezzi o un libro serio? Ha un'autorizzazione?. Ma il sospettonei confronti dellopera serve solo, ancora una volta, a ribadire la suasuperiorit nei confronti di quella vita a cui tutti, tranne gli scrittori,sembrano tenere tanto. Cosl'intervistatore risponde a quella domanda con un'altra domanda, co-me avrebbe fatto Coetzee in persona: C' forse bisogno di un'auto-rizzazione per scrivere un libro? E a chi la si dovrebbe chiedere?.
di CARLO MAZZA GALANTI
Tra i pochi romanzieri contemporanei che effettivamentenon deludono mai c' Emmanuel Carrre, forse l'unicofrancese a riscuotere gli unanimi consensi del pubblico edella critica internazionali, anche pi del discontinuo Houel-lebecq. A leggere Limo n o v, l'ultimo suo libro, forte l'im-pressione che una certa idea di letteratura, allo stessotempo molto tradizionale e molto innovativa, abbia trovatola sua forma ideale. Se le sue prime opere, libri come I baffio La settimana bianca, pescavano nelle ossessioni identi-tarie e nella cronaca nera per costruire romanzi interessan-ti e ben fatti ma formalmente ortodossi, con L'Avvers ar ioCarrre mischiava le carte e imboccava una strada nuova,quella che l'ha portato fin qui. In quel libro inaudito escioccante, ricostruendo la personalit vertiginosa di Jean-Claude Romand mitomane pluriomicida incarcerato nel1996 dopo avere sterminato la sua famiglia il narratoreautobiografico esegue un vero e proprio funambolismo sul
sottile confine dove il profilo della realt documentariasembra coincidere con quello del racconto romanzesco:impossibile decidere dove finisce uno e comincia l'altro. Neidue successivi ha seguito la rotta: con La vita come unromanzo russo e Vite che non sono la mia Carrre hacompiuto un'operazione simile guardando rispettivamentealla propria storia famigliare e alle vittime del maremotodel 2004 nel sudest asiatico. Limo n o v, adesso, rappresentaun ulteriore approdo in questo genere di narrativa ibridache la letteratura europea e in particolare quella francese(tra sperimentazioni autobiografiche, aut o fict ion e bio fic-t io n) ha frequentato assiduamente nel corso degli ultimidecenni. Al centro della scena di nuovo un personaggioesorbitante, a suo modo straordinario. Irriducibilmentescorretto, insopportabilmente arrivista, Eduard Limonovha indossato molte maschere: teppistello nella provinciaucraina da giovane, poeta underground a Mosca, domesticodi ricchi borghesi e poi disperato senzatetto a New York.Per il gusto del rischio e della contraddizione ha fattocomunella coi neofascisti, mettendosi al fianco di Arkancon i cetnici serbi dopo la bohme e i salotti letterari nella
Parigi degli anni ottanta, dove ha conosciuto il suo futurobiografo. Infine diventato capo carismatico del partitonazional-bolscevico (falce e martello sullo sfondo rosso ebianco della bandiera nazista) nella Russia di Putin. Untenebroso avventuriero, pieno di vitalit e mal rispostesperanze, pi romanzesco di Julien Sorel, Rastignac e Bar-damu messi insieme: grimaldello per andare al cuore di unostato essenziale dell'animo umano (perch l'istinto di au-toaffermazione pu essere molto pi forte di quello disopravvivenza) e a interpretare l'aggrovigliata sceneggia-
tura del collasso dell'impero sovietico. Nulla di pi utile, sevolete capire cos' la Russia oggi, della sua parabola esemmai, a completare il quadro, leggeteviSan'kjadi ZacharPrilepin, giovane e talentuoso autore gi membro del par-tito di Limonov e anche presente come personaggio nellibro di Carrre (uscir nei prossimi giorni per Voland unasua raccolta di racconti intitolata Il peccato). Ricordiamol'origine russa di Carrre, e che sua madre una storicaaccademica che alla terra della sua famiglia ha dedicatomolte pagine: la documentazione e il materiale di primamano qui confluiti sono davvero ponderosi, il modo in cuivengono impiegati per dare vita a una narrativa avvincente esemplare. Eppure la fascinazione per il suo irregolarepersonaggio un esercizio anzitutto artistico e la ricerca diuna particolare distanza letteraria capace di mobilitare lepi intime risorse autobiografiche. Se questo libro non solo un ottimo romanzo-reportage dipende da questo:come nei film di Herzog, cui Carrre ha dedicato un saggiogiovanile, ci che pi conta, al di l dei singoli contesti, un
confronto serrato, una sfida tra un io e un a l t ro da cuiil primo si sente ossessivamente, ineluttabilmente attratto.Un confronto che la postura denuncia ti v a di molta lette-ratura impegnata nel racconto del presente non pu, eprobabilmente non vuole, interpretare. E che permette aCarrre di muoversi contemporaneamente sul terreno so-lido del cronista o dello storico e su quello molto piscivoloso di chi nella scrittura vede anzitutto un modo perfare i conti con se stesso, nella convinzione che soltanto dal, dall'ottusa scommessa sulla propria unicit, possa scoc-care la scintilla dell'ispirazione. All'origine dell'attrazioneche Carrre prova per Eduard Limonov c' il carattereamorale e impenetrabile di questo losco outsider, come seil francese vi riconoscesse oscuramente una parte di s acui sente di dovere qualcosa. L'individualismo borghesedello scrittore si trova insomma ad affrontare una difficilepartita con il titanismo superomistico di un personaggiosopra le righe, nutrito d'idealismo, affamato di eroismo ecarisma. Carrre, ultimo precipitato dell'estetica naturali-sta, il campione della conoscenza educata all'osservazio-ne disincantata del mondo, padrone raffinato dell'ambigui-
t. Limonov quello dell'azione indisciplinata e anarcoide,soldato del dogmatismo. Ed come se una lunga storia, pilunga di quella della fine dell'URSS, si riassumesse nelreciproco illuminarsi di queste due figure a loro modoesemplari. Qualcuno potr leggereLimo n o vcome un affre-sco, dall'andatura quasi saggistica, sulla contemporaneit;altri come un affondo narrativo in zone remote e sensibilidella psiche umana. Qualcun altro potr infine arrovellarsisul modo in cui questi due aspetti corrono insieme, inse-guendo l'immagine dei grandi romanzi del passato.
ANDREA BOTTO, KA-BOOM #13, Adelfia, 2010, C-print, cm 98x81
0aeN3jsVhYXbNXVrfFsbyYt6EfUCxeBOVMOLAejLwcBppeNIFLw1CohAseADOZI+G RAB5qH6N0zqON cUejxee40=
-
7/31/2019 Orwell.(27.10.2012)
3/4
IIIS A B AT O
27 OTTOBRE 2012
I CONFINI DEL CINEMA E DEL DOCUMENTARISMO
Herzog: oltre la vita
SCIENZA DELLA LETTURA
Non una questionedi ebook e tabletdiMICHELE DANTINI
La neuroscienza della lettura una disciplina recente: a su o modo eso-terica, ci conduce in universi di pilastri viventie foreste di simboliche avrebbero acceso la pi tenebrosa immaginazione romantica. Lamente avvicina dapprima la pagina come un enigmatico paesaggio inbianco e nero, privo di riposanti tonalit intermedie: un intrico di archi-travi, semiarchi e colonne, di ombre dense e contrasti violenti che oc-correr ammansire e organizzare in combinazioni dotate di senso, ap-punto le p a ro l e. Il modo in cui ci adattiamo gradualmente alle difficol-t della lettura, nel corso dei primi anni di vita, un affascinante episo-dio di riconversione neurale (o rici c l aggio, suggerisce lo psicolgo co-
gnitivo Stanislas Dehaene). Non esistono regioni predisposte. Ma alcu-ne famiglie di neuroni visivi si attivano per la decifrazione delle parole.Sagome, contorni, fi gu rea forma di t, x o y sono ricorrenti in na-tura se osserviamo gli oggetti a partire dai loro profili: compongono lal-fabeto primordiale attraverso cui scritto il Mondo, sono le corrispon-denzedella poesia di Baudelaire. Gli elementi lineari basici di tutti gli al-fabeti fonetici, di geroglifici e ideogrammi rimandano a queste fi gureuniversali. La nostra mente si evoluta docilmente, stabilendo mimeti-smi. La domanda : cosa accade, sotto il profilo neurale, se la pagina visualizzata in ambiente multitasking? La lettura un a manifestazionetra le tante del pensiero lineare. Cosa ci dice la scienza degli effetti realiche luso di Internet produce sulla nostra mente? Non rilevante che ilsupporto muti, divenga cio digitale e non cartaceo. E decisivo inveceleccesso di informazioni in entrata o in uscita. Smartphone e tablet sol-lecitano attivit simultanee e concorrenziali che sovraccaricano la m e-moria di lavoro precludendo elaborazioni successive. Luso inespertodei gadget pu inibire o disperdere lattenzione selettiva, la stessache si associa a una lettura raccolta e prolungata. Stiamo entrando inunepoca di pensiero non lineare. un mutam ento da temere, che pre-lude alla scomparsa della societ del Libro e dellInterpretazione? Epresto per affermarlo. Anche la diffusione del libro a stampa, raccontaAdrian Johns, fu accolta in origine da timori e oscure profezie, poi dissi-
patisi in seguito. Gi i nostri antenati secenteschi, come provano gli stu-di di Robert Darnton e altri, leggevano spinti da necessit di ordine pra-tico, in modo segmentalee non s e q u enziale, un po come noi quan-do ci muoviamo rapidi e compulsivi tra i diversi link segnalati dai motoridi ricerca. Vale per la pena adottare prospettive complesse, che nonnascondano le ambivalenze. Le euforie di inizio millennio (sul Web 2.0etc.) sono ormai lontane.Esiste oggi un formidabile consenso sulla necessit di rivedere l attribu -zione delle competenze: linterazione Mente-Digitale troppo impor-tante perch le sue modalit possano essere decise da programmatorie ingegneri elettronici. Internet non l utopia neoilluminista che crede-vamo: i propositi dei paladini del free Web si scontrano con enormi in-teressi commerciali. Unampia letteratura si occupa di discutere critica-mente Rete e Digitale, cataloga distorsioni, vaticina patologie. C chi(come Sherry Turkle, docente del MIT e responsabile di Initiative on Te-chnology and Self) indaga lisolamento cui ci avviano le professioni digi-tali. Saremo condannati a abitare universi rabbiosi e celibatari? Altri,come Nicholas Carr o Eli Pariser, denunciano che la plasticit della Men-te, una risorsa adattiva tra le pi preziose, fuorviata se la Macchina im-pone lo standard (ci possibile interpretare, aggiunge Yves Citton, sulpresupposto di unoscura precognizione: niente che possa essere tra-
dotto in algoritmi). Con persuasiva veemenza, e non da posizioni no -stalgiche, Jaron Lanier e Geert Lovink invitano a contrastare derive mo-nopolistiche o mistiche totalitarie. La teoria critica delle Rete appe-na agli inizi: ma gi adesso promette di diventare un ambito di ricercatra i pi innovativi del decennio. Le discipline storiche e sociali hannolopportunit di trarsi fuori dal logoro recinto dei saperi antiquari e glistudenti di Human ities di imparare a programmare. Joel Balkan introdu-ce un punto di vista solo in apparenza laterale. Nel suo ultimo libro, As -salto allin fanzia, considera laggressivit del marketing dei prodotti ri-volti ai bambini. probabile che il dibattito sulla Rete, pro et contra, deb-ba in futuro ricollocarsi almeno in parte sotto la voce: tutela dellinfan -zi a.Pensiero complesso, capacit sintattica e immaginazione si sviluppanoin contesti relazionali incoraggianti e attraverso giochi di ruolo. La me-moria ha un funzionamento assai diverso da quello dell attenzione: an-c hessa tuttavia un elemento determinante del processo di acquisi-zione di nuove conoscenze. Inizia a costituirsi gi nel periodo fetale ed strettamente associata alle esperienze di cura e accoglimento (o di in-curia e rifiuto) che segnano i primi anni di vita. Apprendiamo dal rappor-to con adulti empatici, in altre parole, in modi che non sono per nienteassimilabili a una trasmissione di in fo r m azi o ni. Imitiamo chi ci vuole
bene e gioca con noi, dunque no n desta in noi timore: questa la prospet-tiva del bambino, irriducibile a modelli cibernetici. Qualcosa come u nPrincipio-Narrazione corrobora lapprendimento: qualcosa che un am-biente multitasking, frammentario e disparato, disperde. Abbiamo ne-cessit che le informazioni siano esposte o ordinate organicamenteallinterno di un racconto. Studi recenti sulle aree del c ervello attivatedalla lettura di romanzi spingono a credere che una precoce consuetu-dine con questo genere letterario accresce competenze psicologiche,sociali e memoria. Riusciamo a orientarci nel mondo solo se sostenutidalle affabulazioni di avveduti car egiv er.
SEGUE DALLA COPERTINA
Si parlato di docu me nt ari: un vecchio errore, di per s inno-cuo. Ma come spiegare che queste con v e rsazi o ni (non in-tervist e, come ha precisato lui stesso) appartengono a un so-lo film, che da pi di 40 anni forma una delle esperienze fonda-mentali del cinema, e in cui fatti e elaborazione fittizia si in-trecciano sempre, come a ricalcare la costituzione stessadellidentit umana? Si pu ricordare che i protagonisti dei filmdi Herzog sono sempre degli individui che infrangono fatal-mente le norme della vita quotidiana, finanche della sopravvi-venza, e spesso soccombono: ritroveremo cos una strana pa-rentela tra il giovane omicida Michael Perry e il soldato Wo-yzeck (1977), tra Brad Macallam (che ucci de la madre e si barri-ca in casa nel recente My son my son what have ye don e?) e ilsoldato Stroszek di Segni di vita(1968), che si proclama re delMediterraneo minacciando di far saltare in aria il fortino in cuisi arrocca. Si pu precisare che non si tratta di morbosa com-passione per folli e assassini (termini sempre assenti nell at-
tentissimo vocabolario di Herzog), ma della ricerca di unosguardo dallesterno sul nostro mondo. Gli uomini eccezionalidi cui narra Herzog includono Kaspa r Hauser, il ragazzo senzanome cresciuto in catene e ignaro del mondo, la sordo-ciecaFini Straubinger, e ancora nani ribelli, avventurieri megalomani(Aguirre, Fitzcarraldo), sportivi visionari (Messne r, il saltatorecon gli sci Walter Steiner), profeti, sedicenti Cristi. Lelenco po-trebbe continuare, fino al recente caso di Timothy Threadwell,i cui filmati costituiscono il materiale di Grizzly man (2005 ) .Con lui, che va a vivere con gli orsi e si racconta per mesi difronte a una telecamera, prima di essere divorato, Herzog haspinto lo sguardo fino a riprendere le ultime immagini che pre-cedono la morte di una persona: nel gesto di autofiction diThreadwell, che si isola dalla societ ma si presenta come uneroe televisivo, che fantastica di una natura incontaminata e siautodistrugge, la distanza tra essere e apparire si confo nde espicca lenigma di uno sguardo che ci sfugge. Ribelle kleistianosenza prospettiva, e al tempo stesso vittima di uni n c apa citdi comunicare, Threadwell incarna l ambiguit di tutti i perso-naggi che hanno ispirato in He rzog una simpatia che di volta involta commuove e inquieta ( imminente una nuova serie di
documentari, Hate in America, in cui comparir tra gli altri TedKaczynsky-Unabomber). Sono quasi tutti dei falliti, per unverso. Lo stesso Kaspar Hauser riconobbe nei suoi diari: B e,mi sembra che la mia comparsa in questo mondo sia stata unarovinosa caduta. Ma con la storia esemplare di questa co m-parsa Herzog (come afferma lui stesso in Incontri alla fine delmo n do) racconta di come un alieno potrebbe guardare in mo-do nuovo le cose di questo pianeta . A questo scopo i fatti ri-sultano addirittura controproducenti: il dato di fatto crea nor-me, la verit illuminazione. Ci avviciniamo allobiettivo: Her-
zog ci invita a cercare una verit a un livello pi profondo dellarealt quotidiana, e lo fa viaggiando in cerca di immagini a de-guate, nuove, senza le quali ci estingueremo come dinosauri.Nei paesaggi e nei gesti Herzog ha sempre cercato queste im-magini interne, propriamente non rappresentabili. Ecco perchla visione e il sogno sono momenti essenziali dei suoi film, edeccole ritornare in Into the Abyss e On Death Row. A uominiprossimi alla morte, o ai familiari svuotati di vittime e perpe-tratori dellomicidio, si chiede di raccontare cosa sarebbe po-tuto essere, cosa sognano, cosa vedono nel futuro. Herzog sol-lecita con delicatezza e la carne trema, scossa da bagliori vul-canici. Un carceriere racconta di come, guardando negli occhiuna donna che lo ringraziava dopo essere stata assicurata allettino per liniezione letale, abbia vissuto una sconvolgenteesperienza fisica dimmedesimazione che lo ha portato a la-sciare il lavoro, a contemplare gli uccelli che volano, a conclu-dere: la legge pu cambiare. Un detenuto racconta di com e,prima dellesecuzione (sospesa improvvisamente durante lul-
timo pasto), abbia immaginato la propria situazione comequella di un film in cui pi e pi volte ti svegli e capisci che stavisognando e sei ancora nel braccio della morte. I padri parlanodei figli condannati, le sorelle dei fratelli perduti: alcuni perso-naggi restano imprigionati nel fatto costituito da una doppiaviolenza quella di assurdi crimini e quella della pena capitale e nelle sue sistemazioni morali, mentre per altri il futuroprende forma indistinta di visione. Cos Michael Perry dichiaravedremo cosa succede, pochi giorni prima delles ecu zion e,mentre Jason Burkett, che ha ucciso tre persone insieme aPerry ma stato condannato allergastolo, si sposa e parla diavere un figlio. Una donna ci racconta di come si innamoratadi Burkett e, ottenendo il suo seme di contrabbando (come lamette Herzog), ha concepito un bambino. Ci mostra la foto delfeto sul suo cellulare. Ecco la visione, che mi lascia muto eamorale mentre cerco con disagio di tornare alle pratiche quo-tidiane, e bisbiglio nel buio. Questo essere in pixel, che non po-tr mai cammina re a fianco del padre, gi sopraffatto dai di-scorsi e dagli sguardi altrui. Mucchio di ce llule cieche, un giornoforse si sentir coinvolto dalla sentenza di Woyzeck quando siscopre tradito: ogni uomo un abisso, e d le vertigini a guar-
darci dentro
. Ma al tempo stesso questo feto, ora, guarda tut-ti i sopravvissuti di questa vicen da dalla distanza di un futuro incui potr mettere mano sullintreccio di visione e crudo istintodi cui fatto, e vedere cose che noi non possiamo immaginare:per un attimo risuona unesplosione silenziosa che sembra di-sfarci tutti, personaggi e spettatori, mentre qualcuno sussurrale parole di un famoso romanzo: IO SONO VIVO, E VOI SIETEM O RT I.
PAOLO PECERE
ANDREA BOTTO, KA-BOOM #17, Rapallo, 2009, C-print, cm 38x46
0aeN3jsVhYXbNXVrfFsbyYt6EfUCxeBOVMOLAejLwcBppeNIFLw1CohAseADOZI+G RG7Abe1cUBfeI7Dr6gt3aYo=
-
7/31/2019 Orwell.(27.10.2012)
4/4
IVS A B AT O
27 OTTOBRE 2012
IL CINEMA S CO R R ET T O E SEMINALE DI JACOPETTI
Le m anipolazioni dei mon do
SEGUE DALLA COPERTINAIl reporter solo l'estensore finale, l'ultimo anello di una catena com-posta da moltissimi individui che forniscono materiali, aneddoti, rifles-sioni, generano incontri. Senza comprensione reciproca, diceva anco-ra Kapuscinski, scrivere impossibile.Ovviamente lo stile adottatodall'estensore finalenon secondario. Anzi, quasi sempre fa la diffe-renza. A mo' di piccolo esempio, baster ricordare che nei libri delloscrittore polacco non ci sono mai interviste classiche, domande e rispo-ste, ma solo descrizioni di incontri, approssimazioni alla realt, ritratti didonne e uomini noti e meno noti (molto spesso marginali che nessunoavrebbe mai ricordato), uso (frequente) del discorso libero in diretto.2 Non inventare. Prendiamo alcuni libri usciti negli ultimi due anni : Ana -tomia di un istante di Javier Cercas (sul fallito colpo di Stato in Spagnanel 1981), L'u o mo - las erdi Gellert Tamas (su un killer seriale di cittadinistranieri nella placida Svezia), Tutto e subito di Morgan Sports (sul casodi Ilan Halimi, ragazzo ebreo sequestrato, torturato e ucciso nella ba-nlieue parigina da un gruppo di balordi che lo crede ricco in quantoebreo), oLimonovdi Emmanuel Carrre (di cui si parla anche in qu estepagine)Tutti sembrano condividere un dato di fondo. Per raccontareuna realt sempre pi complessa, per decostruire un mondo che non sipresenta mai in bianco e nero, occorre un approccio che attraversi i ge-
neri, li ibridi, li faccia stridere fra loro. In tutti questi libri si usano formeletterarie o cinematografiche per raccontare una realt sminuzzata finoal dettaglio: larchitettura del romanzo, il ritmo del noir, il montaggio al-ternato, il procedere per accumulazione di materiali seguendo cerchiconcentrici. I loro autori sembrano dirci (e spesso lo dichiarano aperta-mente) che occorre superare l'inchiesta giornalistica, o le gabbie dellasaggistica, su un punto specifico: lo scavo psicologico delle persone incarne e ossa. Occorre scandagliare gli abissi che si aprono in o gnuno dinoi, i dettagli della vita che sovente rivelano il tutto.Eppure questi libri si fermano ai bordi di un confine: non in troducono maielementi di fiction nel racconto. Non collocano mai il proprio io in posti incui non stato, non inve ntano personaggi dal nulla, non edulcorano larealt, per un semplice motivo: se costruisci un metodo cos complessoproprio per demistificare il mondo e il racconto di esso, perch poi falsi-ficarne una sua parte, rompendo il patto con i lettori, scivolando sullabuccia di banana della legittimit? L'attraversamento di quella terra dimezzo avviene su un piano strutturale (e sicuramente pi interessante):la sussunzione di forme, non l'alterazione dei contenuti.3 La giusta distanza. Non facile capire quale sia, dipende da caso a ca-so. Tra i due estremi la distanza siderale di chi neanche ci va nei posti el'immersione totale che spesso genera miopia o eccessiva indulgenza i gradi di prossimit possono essere diversi. Ma se da una parte, specie
nel momento della scrittura, la distanza permette di cogliere meglio ichiaroscuri, le variazioni, dall'altra dovrebbe essere evidente l'equi-distanza tra la vittima e il carnefice, tra l'oppresso e l'oppressore, tra chidetiene il potere e chi lo subisce un mito giornalistico infondato. Spes-so genera mostri. Come diceva una vecchia can zone dei minatori delKentucky: Which Side Are You On?
ALESSANDRO LEOGRANDE
SEGUE DALLA COPERTINA
...in mancanza di uno sguardo etico che si assuma la re-sponsabilit di approfondire, con pudore e precisione,lontano dai riflettori. Nel tritatutto di Blob appare MarcoTarquinio, direttore di Avvenire, che azzarda unanalisisemiotica in una tribuna pomeridiana: Il filmato fa trop-po effetto per via dell audio, quelle urla della zia e delbambino. Provate a cambiargli colonna sonora. I blobbi-sti eseguono alla lettera, sovrapponendo alle immagini ilnostalgico elogio dellinfanzia calcistica di De Gregori. Leparole Nino non aver paura scorrono mentre il bambinoscalcia, per liberarsi dalla stretta dei poliziotti. Lim magin ediventa ancora pi insostenibile, ipnotica come un fram-mento di un mondo movie. Ovvero di quei documentarisospesi tra finzione e realt, inventati dai giornalistiGualtiero Jacopetti e Franco Prosperi allinizio degli annisessanta. Pieni di crudeli esotismi, imbevuti nel senti-mentalismo musicale di Riz Ortolani. Mistificazioni d im-patto, base organica dellinfotainment in cui si gradual-
mente trasformata gran parte dellinformazione globale.
Gualtiero Jacopetti, morto un anno fa, viveva una sostan-ziale rimozione, se si escludono sporadiche interviste erassegne, come quelle curate da Lorenzo Micheli Gigiottied Anthony Ettorre. Il suo stile, assorbito dallim magin ariogiornalistico, ha subito molte degradazioni. Bruno Vespa,ad esempio, la sera dell11 settembre 2001 rinunci allasigla del suo Porta a Porta, tratta dalla colonna sonora diVia col vento. Sovrappose il lirismo di Max Steiner alladissoluzione delle Twin Towers. Straniante crudelt, nonsi sa quanto involontaria, incapace di restituire un sensoallimmagine pi lampante e misteriosa della contempo-raneit. Ripetutamente svelata e sepolta da cumuli didietrologie, complottismi, tasselli che non si incastrano. Amacerie ancora fumanti, dalla bocca di Karlheinz Stoc-khausen sfugg un paradosso: E la pi grande operadarte possibile dellintero cosmo. Corresse poi il tiro,per evitare un linciaggio non solo mediatico, attribuendole responsabilit ad unanarchia diabolica. Ma aveva cen-trato un punto: quel crollo rimasto un enigma, comeaccade alle opere darte. Stenta ancora a sedimentarsi in
una storiografia senza ombre.
La stampa informa i fatti.Non sui fatti ripeteva Carmelo Bene, riferendosi ai cor-morani affogati nel petrolio. Rimbalzavano sugli schermimondiali, spacciati per ennesima prova del sadismo diSaddam Hussein. Ottimi titoli di testa per la Guerra delGolfo, primo grande conflitto mediatico. Ma i pennuti inagonia provenivano da chiss quale repertorio. Una ma-nipolazione che avr divertito Jacopetti e la sua visionenichilista del cosmo. Ventenne, osservava pensoso pen-zolare il corpo di Mussolini a Piazzale Loreto, nel ludibrio
generale, seduto su di una jeep americana. Era stipendia-to dallFBI e si era gi liberato dellinnocenza, per fareposto a una nicciana sfiducia nel genere umano. Scelsecome maestri Longanesi e Montanelli: Nasco e rimangogiornalista. Passai rapidamente dalla macchina da scrive-re alla cinepresa. Avevo a disposizione le immagini inmovimento e potevo integrarle con il mio commento.Rumori dambiente, voci, silenzi. Un universo vivo, inac-cessibile al giornalista puro, costretto a sprecare vana-mente fiumi di retorica. Jacopetti, in pieni anni cinquan-ta, trasforma la settimana Incom in una rielaborazionesarcastica della cronaca, diventando celebre. Fellini lo in-crocia nei tavolini di Via Veneto e rimane sedotto dallasua bellezza perfida, da avventuriero. E cos che immagi-na il giornalista in progressiva corruzione de La dolce vi-ta. Gli propone la parte, ma Jacopetti rifiuta, conscio deisuoi limiti: Il mio posto al di qua, non al di l. Esordi-sce cos alla regia nel 1962, con Mondo cane, capostipitedei Mondo movies, mockumentary etnografici che diven-
teranno una moda internazionale. Pieni di esotismo insfavillante cinemascope, in un tripudio di grandangoli, ri-prese aeree e montaggi frenetici, presagi dei videoclip avenire. unenciclopedia visiva di bizzarrie, frutto di viag-gi su scala planetaria, perfetta per sfamare le golositclandestine di un pubblico sessualmente represso dallesagrestie. Un abbozzo dellodierna, sterminata archivia-zione della rete. C lindigena che ha appena perso unfiglio e si consola allattando un maialino orfano, accosta-ta a sofisticati gourmet americani, intenti a gustare ver-mi e topi muschiati. Ogni pretesto buono per mostrarecorpi nudi, come le assatanate ninfomani di una tribdella Nuova Guinea. La voce over piena di ironia, vela-tamente colonialista. Jacopetti si rivela spesso sgradevo-le, a volte illuminante. In Addio zio Tom, realizzato nel1971, si assiste allingresso di unorda di turisti dellAme ri-ca del Nord, in una vecchia casa della Louisiana. Voglionoriassaporare latmosfera del sud schiavista. Ad accoglierlineri e bianchi, per loccasione addobbati filologicamenteda schiavi e padroni. Vendono a peso doro presunti fioc-chi di cotone depoca e altri souvenir. La sequenza pa-
lesemente ricostruita, girata con inquadrature di splendi-da composizione e una calibrata direzione di attori ecomparse. Difficile stabilire se levento sia mai accaduto.Di certo la trasformazione di un periodo storico sangui-noso in puro folklore diventer unabitudine ricorrente, adiverse latitudini. Ed ecco forse il merito che distingue Ja-copetti dai suoi epigoni: saper cogliere, attraverso la fin-zione, sintomi profetici.
GIUSEPPE SANSONNA
ANDREA BOTTO, KA-BOOM #07, Riva di Tures, 2011, C-print, cm 98x81
CHI SIAMO E CHI VORREMMO ESSERE
Grazie a tutti i redattori, jumpinshark, Carolina Cutolo, Carlo Mazza Galanti.Le fotografie di questo numero (a cura di Fabio Severo e Alessandro Im-briaco) sono tratteda KA-BOOM di AndreaB otto (www.andreabotto.it),una sequenza di paesaggi italiani che mostrano vari tipi di detonazionicontrollate,da demolizionia bonifiche ambientali, finoa spettacolipiro-tecnici. Andrea Botto presente in diverse collezioni pubbliche e private,tra cui il MAXXIdi Roma e il Museo di Villa Croce di Genova. KA-BOOM havinto nel 2012 il Premio Graziadei FOTOGRAFIA Festival di Roma. Orwell anche su facebook , e su twitter @orwe llp
Gentile Direttore, immagino se ne sia accorto ma, qualora fosse ne-cessario, volevo informarla che nel mio ambito ho raggiunto la qualifi-ca di t e c n i co. In quanto indefessa mandatrice di lettere sono ormaiinternazionalmente considerata una specialista (lo dice anche il posti-no) e converr che sarebbe un peccato sprecare un tale bagaglio dicompetenze. Non mi sembra giusto rendermi indisponibile, accettoqualunque incarico con spirito di servizio. Voglia perci considerarmi
papabile alla nomina di:-Amministratore delegato di Poste S.P.A-Funzionario della Polizia Postale-Sottosegretario al Ministero Poste e Telegrafi-Direttore del Museo della Stampa-CEO di Hotmail-General manager di Olivetti (e quindi anche di Telecom)-Preside di una facolt di Lettere a caso-Erede dello spazio La bustina di Minerva.-Conduttrice di C' Posta per TeP.S: scelga pure lei, a me van bene tutti, non sono una persona choosy.P.S.2: se mi d un o di questi lavori, il secondo lo faccio gratis.Perch il lavoro nobilita l'uomo, sopratutto se ne hai pi di uno.Distinti saluti e tanto -ma tanto- spirito di servizio.
LETTERA AL DIRETTORE DI LISA NUR SULTAN









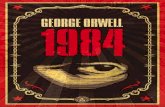


![George Orwell[1]](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/554c61ffb4c905452e8b5642/george-orwell1.jpg)