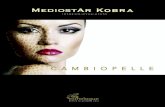Metropolitan City: Multidiscilinary Researches for the ... · La legge 56/2014 attribuisce alle ......
Transcript of Metropolitan City: Multidiscilinary Researches for the ... · La legge 56/2014 attribuisce alle ......


n. 10/2015
Indice
Special Inser tINSERTO SPECIALE
Francesc o Calabrò, Lucia Del la Spina ............................................................................................................................. p.3 Metropolitan City: Multidisciplinary Researches for the Constituent PhaseCittà Metropolitana: contributi multidisciplinari per la fase costituente
Robert o Camagni ......................................................................................................................................................................................................... p.5Metropolitan City and Strategic Planning Città metropolitana e pianificazione strategica
Michelange lo Russo ............................................................................................................................................................................................................... p.9Rethinking the Metropolitan DimensionRipensare la dimensione metropolitana
St e fano Stanghe l l in i ............................................................................................................................................................................................................ p.14The Metropolitan City Planning Issues and the Evaluation ResearchesLe forme di pianificazione della città metropolitana e i contributi della valutazione
LaborEstCITTÀ METROPOLITANE, AREE INTERNE: la competitività territoriale nelle Regioni in ritardo di sviluppo
Rivista fondata da Edoardo Mollica
DIRETTORE RESPONSABILESimonetta Valtieri
LaborEst CITTÀ METROPOLITANE, AREE INTERNE:la competitività territoriale nelle Regioni in ritardo di sviluppoINSERTO SPECIALE N. 10/Giugno 2015
Iscr. Trib. di Reggio Cal. n. 12/05ISSN 1973-7688 - ISBN 978-88-7221-380-3ISSN online 2421-3187
Versione elettronica disponibile sul sito:www.laborest.orgInfo: [email protected]
COMITATO DI REDAZIONEGiancarlo Bambace, Daniele Campolo,
Giuseppina Cassalia, Carmen De Gaetano,Maurizio Malaspina, Tiziana Meduri, Alessandro Rugolo, Raffaele Scrivo,
Carmela Tramontana, Claudia Ventura, Angela Viglianisi
SEGRETERIA DI REDAZIONE E GRAFICADaniele Campolo, Angela Viglianisi
SITO WEBClaudia Ventura, Angela Viglianisi
PROGETTO GRAFICOGiuseppina Cassalia, Claudia Ventura
ABBONAMENTIAnnuale (2 fascicoli) € 30,00 + spese postali
1 fascicolo € 16,00 + spese postali
COMITATO TECNICO - ISTITUZIONALEPresidente Regione Calabria: M. Oliverio
UPI: G. RaffaANCI: G. Varacalli - M. Ripepi
Confindustria Reggio C.: A. CuzzocreaOrdine dei dott. agronomi e forestali: L. Tassone
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori: P. De Stefano
Ordine dei Geologi: A. PizzoniaOrdine degli Ingegneri: F. Cirianni
Parco Naz. Aspromonte: G. Bombino
AMMINISTRAZIONEFrancesco Mallamace
Dipartimento PAU - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabriavia Salita Melissari (Feo di Vito)
89124 Reggio Calabria Tel. 0965/1696421 - Fax. 0965/1696550
Tel. 0965/1696430-302 email: [email protected]
EDITORELaruffa Editore SRL
via Dei 3 Mulini, 14 - 89124 Reggio Calabria
Gli articoli pubblicati dalla rivista LaborEst sono sottoposti a una doppia procedura di
“blind peer review” da parte di studiosi di Università italiane e straniere.
Copertina di Claudia VenturaLogo di copertina di Alessandro Rugolo
INDICE_INSERTO SPECIALE_LaborEst_10_OK.qxp_Layout 1 12/10/15 18:11 Pagina 1

3
1. Premessa
Le città metropolitane, almeno nelle intenzioni del legisla-tore, dovrebbero costituire l’ossatura della futura orga-nizzazione del nostro territorio, in grado di fare da trainoper l’intero sistema italiano nella competizione globale.LaborEst ha chiesto a tre autorevoli studiosi: Roberto Ca-magni (Economia Urbana), Michelangelo Russo (Urbani-stica) e Stefano Stanghellini (Valutazione Economica diPiani e Progetti) di indicare quali sono dal loro punto divista gli aspetti ai quali occorre prestare maggiore atten-zione, soprattutto nella fase di start up del nuovo sog-getto istituzionale: le innovazioni più significative, i rischiprincipali, le sfide da raccogliere. I contributi contenuti inquesto inserto speciale del n. 10 della rivista LaborEst il-lustrano gli interventi tenuti in occasione del seminario“Roberto Camagni, Michelangelo Russo, Stefano Stan-ghellini: il futuro delle città metropolitane. Contributi mul-tidisciplinari per la fase costituente nelle Regioni ObiettivoConvergenza”, svoltosi a Reggio Calabria il 22 maggio2015, organizzato insieme con i colleghi Giuseppe Fera(Urbanistica) e Massimo Finocchiaro (Economia appli-cata), e con Enzo Tromba (Osservatorio Città Metropoli-tana “Edoardo Mollica”), ai quali vanno i nostri più sentitiringraziamenti. Obiettivo del seminario era favorire il confronto interdi-sciplinare sulle tematiche di maggiore rilevanza ai finidella redazione di statuti metropolitani: essi dovrannocontenere il sistema delle regole necessario per realiz-zare nuovi soggetti istituzionali rispondenti alle istanze ealle dinamiche reali dei territori. In considerazione dellafase costituente delle città metropolitane, quindi, l’atten-zione è stata posta su come le funzioni proprie di questoente possono essere disciplinate e concepite.
Tali contributi costituiscono un significativo momento diconfronto e approfondimento, ma anche un supporto of-ferto ai decisori politici dal mondo della ricerca scienti-fica, in un processo - quale quello di costituzione dellecittà metropolitane - del tutto nuovo per la realtà italiana.
2. Alcuni spunti di riflessione
A Camagni, Russo e Stanghellini sono stati sottoposti al-cuni interrogativi. La legge 56/2014 attribuisce allecittà metropolitane compiti specifici tra i quali la curadello sviluppo strategico del territorio metropolitano; lamedesima legge attribuisce anche una serie di funzioni,tra le quali è il caso di sottolineare:
adozione e aggiornamento annuale di un piano stra-•tegico triennale del territorio metropolitano; pianificazione territoriale generale. •
E’ rispetto a tali funzioni che l’economia urbana, le disci-pline urbanistiche, la cultura della valutazione sono chia-mate a interrogarsi: occorre un ripensamento in terminidi approccio culturale, elaborazioni metodologiche e stru-menti operativi?Il tema generale del confronto interdisciplinare è: comele città metropolitane possono organizzarsi per miglio-rare la propria efficacia ed efficienza e svolgere il neces-sario ruolo di accompagnamento e di promozione dellosviluppo locale? Quale contributo possono dare al temaqueste discipline? Quali innovazioni è necessario intro-durre per raggiungere l’obiettivo? Il tema generale può essere declinato in maniera piùesplicita:
è opportuno ricominciare sempre da zero, ripar-•tendo da una pianificazione di carattere generale
CITTÀ METROPOLITANA: CONTRIBUTI MULTIDISCIPLINARI
PER LA FASE COSTITUENTE
INSERTO SPECIALE
Francesco Calabrò, Lucia Della Spina Responsabili scientifici LaborEst
[email protected], [email protected]
SPECIAL INSERT
Metropolitan City: Multidiscilinary Researches for the Constituent Phase
Inserto speciale_LaboEst_10_calabrò_della spina.qxp_Layout 1 10/10/15 08:26 Pagina 135

4
INSERTO SPECIALE
che, secondo la consueta struttura gerarchica,scende via via di scala, per non arrivare mai al mo-mento operativo perché nel frattempo, essendocambiato il quadro di riferimento, occorre ricomin-ciare dalla pianificazione generale? Il tempo non èuna variabile indipendente.le dinamiche dei nostri territori hanno un carattere•espansivo tale da richiedere ancora previsioni che ri-guardano ogni centimetro quadrato di suolo? Esi-stono, invece, strumenti in grado di garantire latutela e il perseguimento reali degli obiettivi pubblici,attraverso un approccio di tipo programmatico?Come è possibile garantire la redistribuzione dellerendite prodotte dalle trasformazioni urbane? Comesi coniugano le scelte spaziali con la programma-zione economica e l’allocazione di risorse?la pianificazione strategica con quali risorse viene at-•tuata? Come si garantisce l’efficacia, la fattibilità e lasostenibilità delle scelte? Come si passa da un livellodi selezione degli obiettivi alla allocazione puntualedelle risorse e alla programmazione operativa?
Si parla di piano strategico triennale avendo in•mente il programma triennale comunale delleopere pubbliche?C’è un nesso tra scelte strategiche, scelte di bi-•lancio dell’ente e, magari, i fondi europei?C’è un’integrazione tra interventi infrastrutturali•e azioni immateriali?Vale ancora il principio che la programmazione•della spesa pubblica, in un determinato territorio,deve essere unica anche se le fonti di coperturasono diverse?
3. Le indicazioni emerse
Nel ringraziare gli autori per aver accettato l’invito di La-borEst, ci preme sottolineare alcuni tratti comuni che anostro modesto avviso traspaiono, più o meno esplicita-mente, dai tre contributi:
La centralità del Piano Strategico •La necessità di sintesi tra pianificazione strategica,•territoriale e urbanistica Il ruolo delle classi dirigenti locali•
3.1. La centralità del Piano Strategico L’ambiguità della formulazione legislativa, che da un latoassegna una funzione di indirizzo al Piano Strategico, edall’altro lo disegna in maniera molto simile al PianoTriennale delle Opere pubbliche, non sminuisce comun-que la portata (potenziale) dell’innovazione introdotta conl’obbligatorietà di uno strumento finora usato solo in ma-niera volontaristica. Non c’è dubbio, però, che è solo at-traverso questo strumento che potranno essere trovatele risposte per il futuro dell’economia e dei territori.
3.2. La necessità di sintesi tra pianificazione strategica,territoriale e urbanisticaE’ evidente che se, come dice Camagni, il Piano Strate-gico individua il “cosa” fare e il Piano Urbanistico il “dove”farlo, i due strumenti non potranno essere concepiti inmaniera indipendente: non si tratta solo di un rapportogerarchico, che pure è evidente, ma della necessità discegliere contestualmente il “cosa” e il “dove”, trattan-dosi il più delle volte di variabili interdipendenti. La capa-cità di dare sostanza a un progetto di territorio comevision del futuro, di interpretare correttamente parole-chiave come “confini”, “multiscalarità”, “contempora-neità”, “new governance” (Russo) non può prescinderedalla creazione di nuovi strumenti, in grado di garantirela sintesi e il coordinamento tra le molteplici dimensionidel governo del territorio: quella strategica, quella terri-toriale e quella economico-finanziaria. È proprio nella ca-pacità di supportare il decisore comparando lealternative, verificando la fattibilità e “misurando” l’effica-cia delle scelte che risiede il contributo della cultura dellavalutazione (Stanghellini), ancora oggi, il più delle volteconcepita solo in termini di meri adempimenti formali,sottovalutando il ruolo che potrebbe avere nella sceltadelle soluzioni maggiormente capaci di soddisfare i biso-gni dei cittadini in relazione ai costi da sostenere, ren-dendo motivate, trasparenti e fattibili le decisioni.
3.3. Il ruolo delle classi dirigenti localiIl grave deficit delle attuali classi dirigenti, non solo diquella politica, già sottolineato anche nell’editoriale di que-sto numero della rivista, costituisce uno dei rischi princi-pali per questa riforma: è evidente che se le sceltesusseguenti non saranno caratterizzate da strategie dilungo periodo, i risultati non potranno che essere disa-strosi. Gli aspetti sui quali i tre studiosi invitano a prestareparticolare attenzione sono:
le leggi regionali di riordino delle funzioni alla luce•della legge 56/2014;gli Statuti delle Città Metropolitane. •
E’ evidente che il modo in cui sarà declinato il Piano Stra-tegico e i rapporti che si stabiliranno con le altre formedi pianificazione dipenderanno da come saranno scrittele norme di riferimento, sia a livello regionale che a livellometropolitano. La sfida per le classi dirigenti non è, però,limitata esclusivamente al momento della scrittura delleregole: la capacità di attivare processi inclusivi, che ve-dano convergere su obiettivi condivisi sia le altre ammi-nistrazioni pubbliche che i soggetti privati, risiede nonsolo nella cornice normativa ma anche, o forse soprat-tutto, nell’azione quotidiana. Anche in questo caso si av-verte la necessità di un recupero di protagonismo deicorpi intermedi della società, che aiutino la politica a ri-trovare credibilità, restituendo legittimità alle scelte cheincidono sulla vita dei cittadini.
Inserto speciale_LaboEst_10_calabrò_della spina.qxp_Layout 1 10/10/15 08:26 Pagina 136

5
1. Una innovazione problematica
La legge 56 per la prima volta introduce nel sistema giu-ridico italiano il concetto e la pratica della PianificazioneStrategica (per le Città Metropolitane).Questa novità, checertamente costituisce una innovazione rilevante, deveessere compresa a fondo, perché la legge, normandol’istituto della PS, ne muta in maniera sostanziale la na-tura e le caratteristiche rispetto a quelle che si sono an-date consolidando nella teoria e nella pratica del nostropaese negli ultimi vent’anni (Gibelli, 1996; Camagni,2003 e 2006). Un istituto che nasceva da un atto volontario di ammini-strazioni locali e di rappresentanze istituzionali di inte-ressi, essenzialmente auto-organizzato e regolatoattraverso un “patto” e una serie di accordi, nel quale ilprocesso partecipativo era essenziale e costitutivo e cheoperativamente si realizzata attraverso una serie di pro-getti condivisi in cui le diverse parti si obbligavano volon-tariamente a eseguire compiti diversi ma integrati,diviene oggi atto obbligatorio, di indirizzo, un piano che siimpone ai Comuni e alle Aree Omogenee (che tuttaviacontribuiscono a realizzarlo), un atto di “government” enon più solo di “governance”.Non c’è da stupirsi delle novità sostanziali, che tuttaviapossono essere sfuggite a letture iniziali e/o superficiali:i giuristi – pour cause! – non se ne erano mai occupativeramente trattandosi di materia non obbligatoria, nonnormata, lasciata alla buona volontà e agli eventuali ac-cordi contrattuali fra le parti; e dunque non c’è da stupirsiche con lo stesso termine si siano intese cose tutt’affattodiverse da quelle consolidate nelle pratiche (e soprattuttodalla migliore teoria economica e di pianificazione).Questa incongruenza, e quel che più conta questa di-
stanza concettuale e questa cesura istituzionale, è stataben messa in evidenza al recente seminario dell’ANCI del13 maggio 2015 da Daniele Donati, un giurista che haavuto la possibilità di ben valutare questa distanzaavendo diretto il Comitato Tecnico-Scientifico del recentePiano Strategico Metropolitano di Bologna.Sembra dunque necessaria una riflessione approfonditasul tema, soprattutto per valutare, io penso, le potenzia-lità del vecchio istituto nella nuova forma giuridica, nel-l’ottica della sua efficacia operativa ed anche dei possibilirafforzamenti che potranno essere introdotti con modi-fiche successive della legge nazionale o dalle leggi regio-nali. Esso infatti costituisce uno dei pochi strumentipotenzialmente utilizzabili dalla Città Metropolitana perrealizzare concrete innovazioni all’interno della cornicedi debolezze strutturali che la caratterizzano nella legge:assenza, almeno per un bel pezzo, di suffragio universale;gratuità delle cariche; totale assenza di nuove risorse;assenza di fiscalità propria (diversamente da quanto pre-visto dalla nuova legge francese, del tutto coeva alla no-stra legge 56) (Camagni, 2014).
2. Vantaggi, svantaggi e rischi
Il principale vantaggio che discende dalla nuova veste“normata” della PS risiede nella sua, almeno potenziale,maggiore cogenza. Infatti uno dei limiti rilevati spessodelle pratiche realizzate almeno in Italia era la facilità concui impegni sottoscritti non venivano successivamenterispettati, restando nell’ambito di generiche affermazionidi principio cui non seguivano effettive realizzazioni: anzi-ché impegni, indirizzi facilmente degradabili a pura reto-rica politica.Nella legge, il PS è obbligatorio, e, nella parole di Donati,
CITTÀ METROPOLITANA EPIANIFICAZIONE STRATEGICA
INSERTO SPECIALE
Roberto Camagni Dipartimento ABC, Politecnico di Milano,
Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133, Milano, Italia [email protected]
SPECIAL INSERT
Metropolitan City and Strategic Planning
Inserto speciale_LaboEst_10_camagni.qxp_Layout 1 08/10/15 11:19 Pagina 135

6
INSERTO SPECIALE
è “funzione fondamentale” e caratterizzante il nuovo enteCittà metropolitana, un atto di “alta amministrazione”. Inquanto tale esso si impone ai Comuni; dovrebbe preva-lere, anche solo in senso logico, sugli altri strumenti dipianificazione assegnati alla Città metropolitana e giusti-fica la richiesta di relative nuove funzioni e risorse da as-segnare alla CM stessa.Tutto ciò sembra vantaggioso, anche se resta moltonell’ambito delle potenzialità più che delle effettive possi-bilità attuali. Per questo suggerisco che siano le leggi re-gionali di riordino delle funzioni a seguito della 56 asottolineare, rafforzandola, la cogenza della PS. Natural-mente tale cogenza avrebbe dei limiti: essa infatti nasceda un atto, il Piano Strategico, che si occupa di “indirizzi”e non, o non necessariamente, di progetti; esige che lealtre amministrazioni locali creino con le loro delibera-zioni, le necessarie pre-condizioni territoriali per ospitarele indicazioni del PS, ma nulla può richiedere alla decisio-nalità del privato, al di là della accettazione delle su dispo-sizioni. Il PS resta comunque uno strumento piùstrutturato di quanto non fosse nelle pratiche seguite fi-nora, almeno nei rapporti a carattere organizzativo conle altre parti dell’amministrazione pubblica. Penso in que-sto senso ad esempio ai rapporti, che spesso si sono ri-velati conflittuali, fra gli organi del piano strategico e gliorgani preposti alla pianificazione, urbanistica e dei tra-sporti soprattutto, degli enti locali, quando non siano statifin dall’inizio adeguatamente coinvolti in modo organicoall’interno delle procedure ‘inusuali’ del piano strategico. Il rapporto fra Piano Strategico e Piano Territoriale Ge-nerale risulta particolarmente delicato. Sulla base dellamia esperienza passata – e in particolare l’esperienzache ho vissuto a Roma alla fine degli anni ’90 nel rap-porto fra due Piani, per la verità mai approvati definitiva-mente: il Piano Strategico avviato dall’ultimaamministrazione Rutelli (Camagni e Mazzonis, 2001) eil Piano Regolatore gestito da Marcelloni con Campos eOliva – ho imparato che, in estrema sintesi, il PS definisceil ‘che cosa’ e il PRG definisce il ‘dove’ (territorializza lescelte e le decisioni ‘condivise’ del PS). Vi sono dunqueampie autonomie, che discendono dalla diversa naturadei due Piani: partecipato e partenariale, almeno in pas-sato, il PS e atto amministrativo, anche se giustificato einteragito, il PRG; ma anche ampie co-decisioni, datol’orizzonte di medio-lungo termine che i due Piani condi-vidono, le ampie sinergie che potenzialmente possonocreare e le risorse finanziarie private che possono rispet-tivamente attivare nell’interesse collettivo; e comunque,innegabilmente, si ravvisa una prevalenza e una prioritàlogica del PS che intrinsecamente si occupa di innova-zione – economica e territoriale - diversamente dal PRGche si occupa prioritariamente di efficienza territoriale edi sostenibilità degli usi del suolo, perseguibili in diversimodi con adeguate misure. Lo Statuto della CM di Milano mette in evidenza questa
stretta relazione fra i due Piani e la priorità logico-strate-gica del PS: Il PS costituisce la cornice di riferimento ge-nerale dell’azione della CM. Gli altri atti di pianificazione egli atti di carattere generale della CM mettono in evi-denza con specifica motivazione le loro relazioni col PS”(art. 34 comma1). “Il Consiglio metropolitano sollecitamotivatamente i comuni e le unioni di comuni all’ado-zione, alla revoca o alla modificazione degli atti di lorocompetenza suscettibili di incidere sull’attuazione del PS.”(art. 34 comma 2). D’altra parte si dice che “la CM curala pianificazione di coordinamento e la pianificazione ter-ritoriale generale del proprio territorio in relazione al PS(…) mediante un unico atto di pianificazione denominatopiano territoriale metropolitano” (art.35 c. 1). Quindi giustamente si indica la costruzione di un quadrostrategico attraverso il PS e la sua territorializzazione at-traverso un unico piano territoriale. Una indicazione que-st’ultima stranamente e sorprendentemente disattesada alcune CM, come quella di Firenze, in cui il piano ter-ritoriale è uno ma anche possibilmente trino (generale,di coordinamento e strutturale) e, sulla base di una sedi-cente tradizione, anche strategico. Al di là dei formalismie delle sigle, si tratta da una parte di interrogarsi sul fu-turo del territorio e della sua economia, individuando unavisione, davvero condivisa al di là degli interessi di parte,una strategia per perseguire tale visione e un insieme dimisure, azioni e progetti; d’altra parte si tratta di co-struire un insieme coerente di regole dilocalizzazione/territorializzazione che garantiscano lamaggiore efficienza territoriale (uso efficiente delle ri-sorse: energetiche, ambientali, insediative, naturali e pae-sistiche e di suolo), la migliore qualità territoriale e, nonultima, l’identità territoriale.Purtroppo, diversamente dalle pratiche tradizionali, il PSnon giunge necessariamente a definire dei progetti, es-sendo caratteristicamente un atto di indirizzo (e, si spera,un atto che indichi chiari obiettivi e modalità attuative).Inoltre, in quanto atto amministrativo che vincola solo leamministrazioni – CM, Comuni e Aree omogenee qualeche sia la loro natura istituzionale – il PS normato dalla56 non agisce sul bilancio di altri enti, pubblici e privati,che potrebbero concorrere a raggiungere i suoi obiettivi.Per farlo, sono necessarie sia procedure allargate e par-tecipative sia accordi di programma o altre forme di co-ordinamento e di impegno reciproco, non normate dalla56 ma non certo escluse. Si cercherebbe con questo diportare il nuovo PS a reintegrare quella che apparivacome la vera specificità dei PS tradizionali che, oltre a co-struire una visione condivisa, realizzavano e includevanole assunzioni di responsabilità – manageriale e finanziaria– dei partner del processo, esterni alla amministrazionelocale (Camagni, 2006).
Inserto speciale_LaboEst_10_camagni.qxp_Layout 1 08/10/15 11:19 Pagina 136

Il carattere relazionale e processuale del PS tradizionalecostituisce una delle differenze fondamentali rispetto alPS della legge 56, poco compresa dalla disciplina giuri-dica. Il PS tradizionale è fondamentalmente un processodi costruzione di fiducia reciproca (in particolare fra partepubblica e parte privata), di sinergia fra decisioni pubbli-che (multilivello) e fra decisioni pubbliche e private; un pro-cesso, come è stato ben messo in evidenza da ArnaldoBagnasco (2002) che presuppone ma anche che co-struisce ‘capitale sociale’. Il PS divine una sorta di ‘benerelazionale’ costruito collettivamente. L’importanza di questo elemento è emersa chiarissimada una comparazione fra i PS realizzati (e finanziati) spon-taneamente da alcune collettività locali – città o province– e i PS che per un certo periodo sono stati incentivatidal Governo centrale, al fine di costruire piattaforme pro-grammatiche da sostenere coi Fondi Strutturali europei:i primi vedevano una ricerca di soluzioni consensuali e so-prattutto una partecipazione elevatissima da parte di unaserie di istituzioni, associazioni e singoli attori e cittadini;i secondi incontravano difficoltà a realizzare una tale par-tecipazione ed i partenariati comunque attivati erano ingenere mossi troppo scopertamente da interessi indivi-duali. Il risultato in questo secondo caso era, al meglio,una semplice somma di progetti, mentre nel primo casoera spesso una moltiplicazione di efficacia progettuale at-traverso la attivazione di forti sinergie (Camagni, 2010).La sottovalutazione dei processi partenariali e partecipa-tivi nella legge 56 è elemento che deve far riflettere. Men-tre la legge francese istituisce, fra gli organi delleMétropoles, un Conseil de Développement in cui si rac-colgono con funzioni consultive le parti economiche, so-ciali e culturali, nulla si dice nella nostra legge. Glistrumenti di partecipazione sono lasciati agli Statuti, colrischio che, accanto a formulazioni coerenti e orientatealla trasparenza e alla cooperazione fra pubblico e privato(come nei casi di Torino, Bologna e Roma) si possano tro-vare formulazioni che affrontano il tema in modo retoricoo solo formale (così giudico ad esempio il “Forum perma-
nente” dello Statuto milanese). Soprattutto è essenzialeche gli strumenti partecipativi e partenariali siano stret-tamente legati alla formazione del PS, come si è detto.Infine, una cura (e una attenzione politica) particolaredeve essere prestata alla formulazione delle leggi regio-nali di riordino delle funzioni. Le Regioni non sono maistate, istituzionalmente e politicamente, amiche delle CM,che possono costituire naturalmente un contropotere ri-levante. Ciò non significa che esse devano per forza boi-cottare le CM, vanificando il progetto governativo dicostruzione di istituzioni relativamente forti e preposte arafforzare la competitività dei nostri territori. Tuttavia po-sizioni come quella della Regione Lombardia che, nel PdLdel 29/6/2015 approvato dalla Giunta regionale, di-spone che “sono trasferite alla Regione le funzioni giàconferite alla Provincia di Milano nell’ambito delle materieagricoltura, foreste, caccia e pesca, politiche culturali,ambiente ed energia” (art. 3 comma 1), dovrebbero es-sere apertamente biasimate. Se queste sono le “disposi-zioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della CittàMetropolitana di Milano” significa che viviamo in unmondo capovolto.
3. Conclusioni
In conclusione possiamo dire che il fatto che la legge 56definisca normativamente il PS come funzione fondamen-tale e obbligatoria della CM può costituire un elementopositivo in termini di efficacia del piano: esso può assu-mere quella cogenza che mancava nel caso dei PS tradi-zionali, spontanei e volontari. Una cogenza tuttavia cherisulta chiara nei confronti delle altre amministrazionipubbliche locali e nei confronti di altri strumenti di pianifi-cazione della CM, ma che non è naturalmente opponibilead altri soggetti non territoriali o privati; una cogenza cheriguarda comunque un atto di indirizzo che non includenecessariamente una precisa progettualità. Quello che mancherebbe a un PS normato, espressione
7
LaborEst n.10/2015
PS Tradizionale PS normato dalla legge 56
Atto volontario Atto normato e obbligatorio
Piano/processo Piano/documento formale
Patto pubblico-privato Atto amministrativo unilaterale
Costruisce una visione condivisa Atto di “alta amministrazione”
Risultato di una governance Atto di government Vincolo consensuale fra attori Vincola la PA locale
Atto condiviso, non giustificato Atto che va giustificato, e “giustiziabile”
Processo partecipato e partenariale Processo e atto autoritativo
Carattere relazionale: presuppone e crea
sinergie e “capitale sociale” Carattere amministrativo e politico
Raccoglie risorse dai bilanci degli enti
sottoscrittori
Opera sul bilancio dell’ente CM
(o degli enti locali)
Indica obiettivi, strategie e progetti Indica obiettivi e modalità per raggiungerli
Tab.1 – Differenze fra i Piani Strategici tradizionali e quelli regolati dalla legge 56
Inserto speciale_LaboEst_10_camagni.qxp_Layout 1 08/10/15 11:19 Pagina 137

politico-amministrativa di un processo tutto interno allapubblica amministrazione, è soprattutto la relazionalitàcon la città e il territorio che costituisce l’essenza più spe-cifica dei piani strategici spontanei e volontari, non obbli-gatori e non normati, della tradizione. Questarelazionalità, che si esprime in fiducia, cooperazione, si-nergia e capitale sociale, è essenziale all’efficacia di unpiano strategico, se questo vuole costituire non solo unacornice di indirizzo ma anche uno strumento di attiva-zione di energie esterne alla PA: creatività diffuse e ca-pacità progettuali, risorse manageriali e decisionali,risorse finanziarie. La costruzione condivisa di una visionedel futuro non può essere realizzata da una struttura isti-tuzionale e amministrativa pubblica chiusa, soprattuttonella attuale fase in cui manca la legittimazione di un votodiretto e in cui possibili conflitti di interesse possono ri-durre l’efficacia operativa del personale politico impe-gnato ad un tempo al livello comunale e metropolitano.La legittimità, la trasparenza, la creatività e le sinergierealizzabili attraverso processi partenariali e partecipativisono condizioni che i PS normati devono recuperare, informe variabili ma necessarie, per non perdere quei van-taggi che i migliori piani tradizionali hanno specificamenterealizzato. Questo è uno dei più importanti compiti che gliStatuti, attuali o riformati, devono svolgere, eventual-mente aiutati da qualche condiviso emendamento da ap-portare alla legge.
Bibliografia
Bagnasco A., Il capitale sociale nel capitalismo che cambia, Stato eMercato, vol. 2(65), 271-303, 2002
Camagni R., Piano strategico, capitale relazionale e community gover-nance, in Pugliese T., Spaziante A. (eds.), Pianificazione strategica perle città: riflessioni dalle pratiche, F. Angeli, Milano, 77-99, 2003
Camagni R., Cinque tesi a proposito di pianificazione strategica ur-bana, in AAVV, Pianificazione strategica per la governance del terri-torio, Editiore Lattanzio, Milano, 25-38, 2006
Camagni R., I piani strategici del Mezzogiorno, in Florio R., 10 anni dipianificazione strategica in Italia, Quaderno 3, RECS – Rete delle CittàStrategiche, Firenze, 201-209, 2010
Camagni R., Verso la città metropolitana, in La finanza territoriale –Rapporto 2014, Ires-Irpet-Eupolis, Franco Angeli, Milano, 147-164,2014
Camagni R. e Mazzonis D. (a cura di), Verso un piano strategico perRoma, Alinea, Firenze, 2001
Gibelli M.C., Tre famiglie di piani strategici: verso un modello reticolaree visionario, in Curti F., Gibelli M. C. (1996) (a cura di), Pianificazionestrategica e gestione dello sviluppo urbano, Firenze, Alinea, 1996
8
INSERTO SPECIALE
Inserto speciale_LaboEst_10_camagni.qxp_Layout 1 08/10/15 11:19 Pagina 138

9
1. Introduzione
La dimensione metropolitana è un criterio chiave per l’in-terpretazione della città contemporanea: questo scrittoè volto alla disamina concreta di punti, luoghi, e strategieche ne definiscano la natura in termini di costruzione diuna nuova possibile e innovativa spazialità metropolitana.La tesi è che il governo delle aree urbane di scala metro-politana risulti come prospettiva strategica per trattarei fenomeni di mutazione sociale e urbana dei nostri terri-tori; le motivazioni riguardano una serie di condizioni cheindividuano quella metropolitana come area emblema-tica entro cui dispiegare un progetto di territorio intesocome vision di futuro: proiettata nel lungo periodo, conuna dimensione eminentemente politica oltre che urba-nistica. Questa idea lavora attorno a cinque parole chiaveche caratterizzano la centralità della dimensione metro-politana come luogo del progetto: confini, multiscalarità,contemporaneità, rischi/infrastrutture, new governance.Parole esplorate attraverso i concetti trasversali di pros-simità e topologia, mediante i quali, con successive ap-prossimazioni cognitive e progettuali, si proverà aragionare sullo spazio della metropoli estesa come luogodel progetto.
2. CONFINI _ boundaries
La questione dei confini è stato uno dei luoghi centrali deldibattito ai tempi della Legge n.142 del 1990, ed è stataconcepita dalle forze politiche come il mezzo per ridise-gnare una geografia amministrativa del potere e dellagiurisdizione del territorio. Depurare il tema dei confinida questo significato di gestione del potere, amplia la va-
lenza culturale e progettuale che i limiti acquistano nelprogetto della scala metropolitana.La definizione di nuovi confini consente una lettura delterritorio, della sua morfologia economico-sociale e fisicospaziale, che non sia artificialmente disegnata sulla basedei termini amministrativi: disegnare il limite vuol dire ri-conoscere il modello di sviluppo, ma anche la rilevanzadei fenomeni insediativi (storici e in atto), la forma delpaesaggio e le potenzialità della sua trasformazione.I confini, in questo quadro concettuale, hanno uno spes-sore a geometria variabile; la loro topografia non può es-sere fissata per decreto legge. Sono parte di un progettoche deve riconoscere del territorio l’identità, i valori, lecriticità e la loro distribuzione, le patologie, le potenzialità,le reti di relazioni visibili, soprattutto quelle latenti. La definizione dei confini non può essere un dato preco-stituito, stabile e fisso nel tempo: definisce la forma diuna processualità che è incentrata sull’incontro tra sog-getti collettivi e di diversa natura, sul riconoscimento dicoerenze e convergenze tra interessi e domande di tra-sformazione, sulla lettura dei meccanismi di regolazionedel complesso ecosistema che definisce la struttura am-bientale e geomorfologica del territorio, sulle opportunitàdi sviluppo e crescita delle risorse.Un processualità mobile, che sfugge per definizione la fis-sità, discontinua e variabile, che va gestita attraverso unprogetto. Il confine non può essere individuato come il pe-rimetro di una zonizzazione, ma deve incentrare la varia-bilità della sua geometria sulla base della costruzione diuna o più vision, intese come quadri strategici entro cuicollocare abitabilità del territorio e innovazione di pro-cesso. Vision plurali fatte di elementi stabili ed elementivariabili, parti dure e parti molli – come si diceva alcunidecenni orsono – di coalizioni e di progetti.
RIPENSARE LA DIMENSIONE METROPOLITANA
INSERTO SPECIALE
Michelangelo Russo Dipartimento Diarc, Università degli Studi di Napoli Federico II,
Via Forno Vecchio, 36, 80134, Napoli, Italia [email protected]
SPECIAL INSERT
Rethinking the Metropolitan Dimension
Inserto speciale_LaboEst_10_russo.qxp_Layout 1 08/10/15 14:02 Pagina 135

10
INSERTO SPECIALE
La definizione del confine attiene alla forma del piano ealla forma di governo indispensabile per gestire la dimen-sione metropolitana. Tuttavia il tema del confine assumeun significato politico, soprattutto se letto attraverso lachiave del “contenimento del consumo di suolo”. Il con-fine esterno della metropoli è duttile e non va intesocome riserva per ulteriori espansioni dell’urbanizzato macome spazio pubblico, di socialità e integrazione tra na-tura e città, campagna e produzione, residenza e nuovedotazioni territoriali. I confini sono anche ostacoli, barriere, recinti fisici cheproducono discontinuità spaziale e sociale, inaccessibi-lità, frammentazione, diffusa ingiustizia. Sono i temi dellanuova questione urbana (Secchi, 2011) che, ad esempionella metropoli napoletana assumono particolare rile-vanza: zone prive di ogni uso e prospettiva, territori-scarto dei processi urbanizzativi, friche, terrain vague,spazi delle infrastrutture e dei grandi contenitori terziarie manifatturieri, talvolta anch’essi dismessi (Formato,2010). Iterare alle diverse scale il concetto di confinecon spessore può, in questa condizione, assumere un ca-rattere innovativo, nella prospettiva di costruire un nuovotessuto di relazioni, topologicamente collegato al suolo efunzionalmente volto a migliorare le condizioni di acces-sibilità e socialità.
3. MULTISCALARITÀ _multiscalarity: dal luogo al si-stema
L’approccio multiscalare è il modello interpretativo pro-prio del territorio metropolitano. La varianza di focale at-traverso cui è possibile descrivere il territorio urbano,l’iterazione a diverse scale dei medesimi principi insedia-tivi e morfologici, la necessità di guardare i luoghi nellaloro forma identitaria e i sistemi come reti di relazioni so-vralocali, consente di mettere in tensione le dimensionia cui è possibile riconoscere e nominare i fenomeni cheattraversano e danno forma al territorio.L’approccio accosta visioni di ampia scala e esplorazionimateriali (fino alla scala 0 che riguarda la conformazionedel suolo), senza gerarchie tra le une e le altre. E’ nelladialettica tra la scala del progetto e l’evento che ne pro-duce la metamorfosi spaziale, che, nel tempo, si preci-sano progressivamente le visioni generali, perdendo ilcarattere adattivo e in parte indefinito che le caratterizzain quanto vision. Questa metodologia consente di disarti-colare la complessità della metropoli contemporanea,scomponendo in sistemi, la complessità di relazioni cheintercorrono tra luoghi, società ed elementi naturali(Russo, 2015). In relazione ai temi emergenti della metropoli contempo-ranea appaiono prioritarie la riflessioni sulla sostenibilitàambientale e sull’accessibilità: i relativi sistemi dannoluogo a un campo di relazioni notevoli in quanto i due temi
presentano profonde interrelazioni e mutue interferenze.Reti ecologiche, frammenti di landscape ecology, mosaiciambientali: un continuo processo di assemblaggio di ma-teriali eterogenei, garantisce in prospettiva le tutele e lasopravvivenza dell’ecosistema come struttura del terri-torio, e pone in evidenza la profonda integrazione che ènecessario istituire anche nelle azioni locali di interventosu parti minute del territorio tra tecniche d’intervento eun approccio landscape/ecological sensitive. Un progetto territoriale in cui assume ruolo primario,anche in relazione al tema del contenimento del rischio(idraulico ma anche legato all’inquinamento), la significa-zione, funzionale ed ambientale, della rete delle acque(Secchi, Viganò, 2011; Viganò, 2014). Una rete blu orien-tata alla fondazione di una maglia organica di corridoi ebacini di esondazione, alla ricerca di equilibri idraulici emiglioramenti della resilienza sistemica, per la costitu-zione di una bonifica diffusa, delle falde e dei suoli, anchemediante il varo di “macchine ibride” (Berger, 2009).Con analoga logica va inteso il sistema della mobilità edelle infrastrutture: i network infrastrutturali diminui-scono le distanze, consentono di ridisegnare le topologiemetropolitane, hanno un impatto determinante nel dise-gnare i luoghi e le centralità della nuova vita urbana. Non solo le grandi infrastrutture: la riscoperta dei trac-ciati deboli del territorio aperto, periurbano e “intra-ur-bano” (interpoderali, argini, incisioni, ecc.), insieme ad unavalorizzazione delle aree di margine dei nastri per la mo-bilità su gomma o su ferro (e delle aree intercluse da lorodeterminate: svincoli, intersezioni, intradossi di viadottistradali e ferroviari, ecc.) costituisce uno straordinariopotenziale per la rigenerazione ambientale ed urbani-stica. Il complesso di reti blu, verdi e bianche, opportu-namente riconfigurato, offre alla città metropolitana laconcreta possibilità di trovare nuove continuità topologi-che, pubbliche e ad elevata valenza ecologica.
4. CONTEMPORANEITÀ _contemporaries: fenomeni dimutazione
La dimensione metropolitana fa tradizionalmente riferi-mento alla città piuttosto che al territorio: lavora sui prin-cipi di contiguità, densità, concentrazione,interconnessione, centralità. Tale concezione va tuttaviaaggiornata, rapportata all’attualità di una conurbazioneestesa, frammentaria, discontinua. Una condizione in cuiil fenomeno di shrinkage (contrazione) di alcune parti ur-bane è accompagnato da una concomitante “espan-sione” delle aree di frangia, dei bordi insediati (non soloesterni). Le parti insediate sono inoltre soggette a conti-nui “decadimenti”, dovuti all’inutilizzo e alla bassa oscarsa contestualizzazione (secondo la definizione diDrosscape fornita in: Berger 2007). Un moto non isotropo né tantomeno lineare, che pro-
Inserto speciale_LaboEst_10_russo.qxp_Layout 1 08/10/15 14:02 Pagina 136

cede in maniera disomogenea, lasciando cunei ed inter-clusi non urbanizzati e scarti urbani che, a diverse scale,punteggiano i sistemi, insediativi ed ambientali: edifici ab-bandonati, fabbriche dismesse, aree residenziali pubbli-che degradate o in parziale abbandono, cave, centricommerciali e della grande distribuzione vuoti, piatta-forme per la logistica, spazi delle lottizzazioni abusive,aree inquinate, discariche (talvolta abusive), cave di-smesse, zone bianche prodotte dagli strumenti urbani-stici vigenti, lottizzazioni incompiute o inutilizzate. Ilmetabolismo della città produce aree negate: moltospesso è un “metabolismo patologico”, che consuma ebrucia tessuti sani, distrugge risorse non più riproducibilie si contrappone a un’idea di metabolismo urbano, intesocome scambio di flussi tra sistema ecologico e sistemaurbano che, governato attraverso strategie adattive dimitigazione e di virtuosa interazione (ciclo delle acque,ciclo dei rifiuti, produzione di energia, forme di mobilitàdolce, etc.) rappresenta una straordinaria potenzialitàper il territorio metropolitano (Gandy, 2004). Nella regione urbana di Napoli, ad esempio, il metaboli-smo delle aree periurbane assume una forma metasta-tica, rapida e distruttiva. Gli scarti sono dovuti a fenomeniinsediativi e sociali: dal dilagare della dispersione insedia-tiva in un periurbano che accosta agricoltura e produ-zione industriale, al consumo dilagante di suolo dovutoall’urbanistica dell’abusivismo, fino ai modelli insediatividei sistemi della logistica regionale, alle discariche abu-sive e occultate dei rifiuti tossici.Il recupero di questi “scarti” – recupero eticamente sem-pre più urgente anche in relazione ai temi emergenti dellasostenibilità ambientale e del risparmio di territorio(Ciorra, Marini, 2011) - e la loro re-immissione in altri ciclidi vita può avvenire solo in una logica di sistema, multi-scalare e radicato alle specificità dei contesti. La dimensione pertinente per questa logica pianificatoriaè l’area metropolitana: gli scarti divengono nuovi spazipubblici, nuovi suoli, nuove occasioni re-insediative, nuovipaesaggi. Una dimensione, quella metropolitana, che con-sente di leggere i fenomeni, in relazione alla città, ai tes-suti insediativi, ai sistemi di paesaggio e agli spazi di vitacollettiva e individuale, nei concetti di prossimità e di to-pologia propri della città, alla scala metropolitana. Costruire in questo inedito spazio un progetto che razio-nalizzi l’uso delle risorse, utilizzandone il patrimonio e pro-lungando o invertendo i cicli di vita dei materiali territoriali,diviene una profonda alternativa strategica nella cittàcontemporanea. Napoli decresce all’interno del suo territorio. Le statisti-che dicono che l’area vasta non decresce come Napoli.Per esempio la Provincia di Napoli cresce poco, mentrela città decresce. Napoli è una città che ha espulso po-polazione nella provincia, nella cintura urbana più vicinaper marginalità, per degrado. Un degrado che si manife-sta nelle condizioni urbane che si generano nella “tena-
glia” tra un centro storico poco abitabile e una periferiadilagante che coincide con la città pubblica, frutto dell’ur-banistica modernista del secondo dopoguerra. La periferia urbana della città pubblica napoletana ha si-gnificato la costruzione di micro città: Ponticelli, Scampia,Soccavo. Quartieri-città che hanno prodotto condizioni didegrado tali non creare nessuna potenzialità di ricambio,pochissimi flussi di spostamento interno, facendo sì cheesistono poche isole urbane dove si concentrano le op-portunità localizzative residenziali, e dove si muove il mer-cato immobiliare; l’alternativa, favorita dalle retiinfrastrutturali realizzate dalla Casmez (Asse Mediano,Asse di Supporto, Asse di Andata al Lavoro), è stataquella di programmare residenza fuori dai confini comu-nali, a ovest e nord-ovest, verso la provincia di Caserta,in particolare nel litorale flegreo, sulla fascia costiera enell’entroterra del litorale domitio. Infatti, come segnalaun’attenta lettura delle variazioni della popolazione resi-dente nelle province campane, tra il 2001 e il 2008,mentre la Provincia di Napoli cresce pochissimo, ma nondecresce, si registra una crescita demografica della pro-vincia di Caserta del 5,3% (Discepolo, 2012). Tuttavia Napoli è una città che continuerebbe ad attrarre,a livello locale, soprattutto in relazione ad alcuni suoi quar-tieri. I prezzi delle case mantengono un valore elevatis-simo, quasi sempre non commisurato alla qualità ediliziadelle abitazioni ma soprattutto al loro valore posizionale:significa che c’è una forte domanda residenziale, e unacostante pressione da parte degli operatori economicisulla abitabilità di questa città. Questa abitabilità si costruisce, oggi, a partire da un qua-dro relazionale basato sulla messa a sistema di compo-nenti estese, allargate a Napoli e ai comunidell’entroterra. Componenti che hanno valore in quantoparti integrate entro sistemi, entro layer la cui sovrappo-sizione consente di costruire la complessità del territoriointersettoriale: questi sistemi possono essere ricono-sciuti nella città alla scala metropolitana.
5. RISKS_MOBILITY _infrastrutturare il territorio
Gestione dei rischi e mobilità rappresentano alcuni clas-sici modelli interpretativi di carattere settoriale alla cono-scenza e alla gestione del territorio. Sono materiali delsuo cambiamento: rappresentano settori di interventoche hanno la possibilità di creare effetti straordinari sullaforma della città metropolitana. La loro considerazionebinata costituisce uno dei pilastri del vigente Piano Terri-toriale Regionale, anche se oggi questa consapevolezzasembra essere confinata.Il pericolo assume valenza collettiva quando è accostatoalla densità: il rischio nelle aree urbane moltiplica l’entitàdei parametri pericolosità e valore esposto, come è noto.Ma anche la gestione del rischio è più praticabile nell’area
11
LaborEst n.10/2015
Inserto speciale_LaboEst_10_russo.qxp_Layout 1 08/10/15 14:02 Pagina 137

metropolitana: cioè in un territorio che è possibile leggerecome città, come metropolitan community (Martinotti,1999a, 1999b). In Campania ad esempio – dopo anni in cui questo temaè stato forse anche abusato dal punto di vista della co-municazione mediatica – è completamente stata ri-mossa la questione del Rischio Vesuvio (Russo, 2004).Sopravvive a quest’oblio la Legge regionale n. 21 del di-cembre 2003 – legge che vieta nuove case alle pendicidel vulcano – ma, significativamente, quest’estate, la Re-gione, con Legge n. 16, ha abrogato tout court il Pianostrategico operativo (Gasparrini, 2011) che avrebbe do-vuto costituire il complemento progettuale dei divieti ap-posti dalla Legge del 2003, per la concreta messa insicurezza di territori estremamente fragili, non solo dalpunto di vista del rischio vulcanico. La dimensione metropolitana è l’unica a cui questo ri-schio può essere trattato, nella fase preventiva, e nellaprospettiva di mitigarne gli effetti.Allo stesso modo il rischio idrogeologico, in relazione alsistema delle infrastrutture blu, è un altro argomento cheha la medesima rilevanza nei meccanismi urbani allascala metropolitana (Pötz, Bleuzé, 2012). Pensare di ri-solvere questo tema ponendo divieti e regolando minu-ziosamente le azioni possibili, anche quelle più minute(operazione di stampo settoriale, propria delle Autoritàdi Bacino), è operazione quantomeno velleitaria. A ciò si aggiunge l’interferenza “insanabile” d’interi agglo-merati, abusivi e legali, con le aree di maggiore sensibilitàidro-geo-morfologica e sismica, che determina condizionidi rischio tali da richiedere una rigorosa indicazione neltempo dei tessuti urbani da diradare o delocalizzare, sullaloro localizzazione e sulle possibili strategie d’intervento.Nello scenario legato alla valutazione del rischio, grandeimportanza assume il tema dell’accessibilità, non solo in-tesa come “via di fuga”. Rischio e mobilità – ad esempionel contesto provinciale Napoli/Caserta – hanno unaforte interconnessione in una prospettiva del Rischio Ve-suvio; ma in particolare diventano dei luoghi di riflessioneprogettuale intersettoriale, poiché determinano dei pro-fondi condizionamenti dell’assetto insediativo alla scalametropolitana. Il disegno della mobilità consente di interconnettere il ter-ritorio, di collegare le sue prospettive insediative con inodi delle reti in modo da incentrare le potenzialità di tra-sferimento sul trasporto pubblico, ridisegnare le conve-nienze localizzative e le centralità della città (indirizzandodunque la struttura degli insediamenti); rafforzare il tra-sporto pubblico su ferro, costruire una rete di mobilità“più dolce” (piste ciclabili, percorsi urbani integrati ai si-stemi del verde), valorizzare tutte le modalità di trasportoe la loro interconnessione. Sono politiche di scala regionale, che trovano una loroidentitaria collocazione nello spazio della città, alla scalametropolitana.
5. NEW GOVERNANCE _amministrare e governare ilterritorio
Il controsenso di leggi urbanistiche regionali come quelladella Campania (n. 16/2004) è quello di prevedere ilpiano comunale sdoppiato in strutturale/operativo conun’attribuzione incerta dei collegamenti della parte strut-turale con i quadri sovraordinati (soprattutto di scala pro-vinciale). Si tratta di una carenza che rende incerto ilcarattere stesso di una scelta strutturale, indebolisce lacapacità di una opzione strutturale di innescare una di-mensione strategica se non adeguatamente contestua-lizzata nei rigidi boundaries territoriali definiti dalperimetro amministrativo dei comuni. Una scelta di piano strutturale attiva in un piccolo co-mune, ad esempio, è un paradosso. E’ incerta l’attribu-zione di competenze tra i diversi Enti e il principio disussidiarietà tra gli stessi è spesso smentito da una dia-lettica ancora profondamente ancorata alla logica piani-ficatoria a cascata, basata sull’interdizione e la“contrattazione” sui punti di equilibrio piuttosto che su diuna efficiente co-pianificazione tra gli Enti e i soggetti. Le scelte strutturali interessano la scala delle reti, dei va-lori, delle componenti ecologiche, dei patrimoni, della mor-fologia urbana, della distribuzione delle funzioni, delleinvarianti e delle aree di trasformabilità. La dimensione e il contesto di un piano strutturale defini-scono un territorio con caratteristiche omogenee, nelsenso di rilevante interconnessione, nonché identitarie:la forma strutturale del piano ha senso nel territorio me-tropolitano (non solo provinciale), nell’accordo tra attoriistituzionali intersettoriali, sulla base dei valori di lungo pe-riodo.Il piano strutturale rappresenta un’auspicabile forma dicoordinamento di una governance multilivello indispensa-bile per la costruzione di visioni del cambiamento dovepossano essere individuati i criteri stabili, efficaci e con-divisi per governare la trasformazione dei nostri territori.Il compito primario della nuova città metropolitana do-vrebbe essere proprio quello di varare, in tempi rapidi econ sufficiente autorevolezza (politica e tecnica), un Pianostrutturale complessivo, capace di fornire una vision con-vincente delle regioni metropolitane, da precisare ed at-tuare nel tempo, con pazienza e lungimiranza: affinchéciò avvenga è necessario un progetto di spazio e di terri-torio, e la capacità politica oltre che tecnica di renderlopatrimonio condiviso, cioè statuto fondativo della cittàmetropolitana in formazione, attraverso concreti per-corsi di co-pianificazione.
12
INSERTO SPECIALE
Inserto speciale_LaboEst_10_russo.qxp_Layout 1 08/10/15 14:02 Pagina 138

BibliografiaBerger A., Drosscape: Wasting Land in Urban America, Princeton Ar-chitectural Press, 2007
Berger A., Systemic Design Can Change the World, SUN Publishers,The Netherlands, 2009
Ciorra P., Marini S., (a cura di), Re-cycle. Strategie per l'architettura,la città e il pianeta, Electa Mondadori, Milano, 2011
Discepolo B. (a cura di), Downsizing Napoli. Il declino della città parte-nopea, cinquant’anni dopo e quarant’anni prima, Edizioni Graffiti, Na-poli, 2012
Formato E., Paesaggi dell’abiezione urbana, in AA.VV., Abitare il fu-turo… dopo Copenaghen, Clean Edizioni, Napoli, 2010
Gandy M., Rethinking urban metabolism: Water, space and the mo-dern city, City, Vol. 8, No. 3, December 2004, 2004
Gasparrini C., Vesuvio. La convivenza col rischio, Prisma, N. 1/2011,FrancoAngeli, Milano, 2011
Martinotti G., La dimensione metropolitana. Sviluppo e governo dellanuova città, Il nuovo governo locale, N.3, FrancoAngeli, Milano, 1999a
Martinotti G. (a cura di), La dimensione metropolitana, il Mulino, Bolo-gna, 1999b
Pötz H., Bleuzé P., Urban Green-Blue Grids for Sustainable and Dyna-mic Cities, coop for life, Delft, The Netherlands, 2012
Russo M., Napoli metropoli a rischio, in Savino M. (a cura di), Pratichedi pianificazione alla prova, FrancoAngeli, Milano, 2004
Russo M., Multiscalarità. Dimensioni e spazi della contemporaneità,Asur n. 113, FrancoAngeli, Milano, 2015
Secchi B., Progetto di suolo 2, in Aymonino A., Mosco V.P. (a cura di),Spazi pubblici contemporanei. Architettura a volume zero, Skira, Mi-lano, 2006
Secchi B., La nuova questione urbana, Crios, N.1/2011, Carocci Edi-tore, Roma, 2011
Secchi B., Viganò P., La ville poreuse: un projet pour le Grand Paris etla métropole de l'après-Kyoto, Metispresses, Genève, 2011
Viganò P., Metamorfosi dell’ordinario: per una nuova urbanistica, inRusso M. (a cura di), Urbanistica per una diversa crescita, DonzelliEditore, Roma, 2014
13
LaborEst n.10/2015
Inserto speciale_LaboEst_10_russo.qxp_Layout 1 08/10/15 14:02 Pagina 139

Quali pianificazioni per la città metropolitana
Alla Città Metropolitana la legge istitutiva1 riconosce, inprimo luogo, le funzioni di cura dello sviluppo strategicodel territorio metropolitano, e di promozione e gestioneintegrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di co-municazione di suo interesse2.La medesima legge indica anche, fra le altre funzioni dellaCittà Metropolitana, le seguenti3:
a) l’adozione e l’aggiornamento annuale di un pianostrategico triennale del territorio metropolitano;b) la pianificazione territoriale generale, ivi compresele strutture di comunicazione, le reti di servizi e delleinfrastrutture di competenza, anche fissando vincolie obiettivi all’esercizio delle funzioni dei comuni;c) la mobilità e la viabilità, anche assicurando la com-patibilità e la coerenza della pianificazione urbanisticacomunale nell’ambito metropolitano;d) la promozione e il coordinamento dello sviluppoeconomico e sociale, anche assicurando sostegnoalle attività economiche coerenti con la vocazionedella città metropolitana come delineata nel pianostrategico del territorio metropolitano.
Rispetto alla precedente esperienza nazionale di pianifi-cazione strategica, quale è stata promossa anche dalinee guida ministeriali4, e all’esperienza di pianificazioneterritoriale e urbanistica rinnovata dalle leggi regionali epraticata dagli enti territoriali, le formulazioni adottatedalla legge istitutiva della Città Metropolitana che sono
state sopra richiamate, sollevano rilevanti dubbi interpre-tativi. Ci si riferisce soprattutto al “piano strategico trien-nale” e, in parte, anche alla “pianificazione territorialegenerale”.Nell’economia del presente contributo merita tuttavianon addentrarsi subito in tali questioni, per evitare di re-starvi invischiati, e puntare piuttosto direttamente alcuore della questione, rappresentata da un fatto ogget-tivo, e cioè che la legge assegna alla Città Metropolitanaforti funzioni di pianificazione. Su questa base appare utilesviluppare il ragionamento che viene di seguito espostoper punti successivi.
1. La legge attribuisce alla città metropolitana la fun-zione della “pianificazione territoriale generale” e nonla redazione del “piano territoriale di coordinamento”delle vecchie province; tale funzione riguarda soprat-tutto le infrastrutture, la mobilità ed i servizi, anchefissando vincoli e obiettivi per i Comuni.2. Mentre la “pianificazione territoriale generale”spetta alla Città Metropolitana, ai Comuni - riuniti inunione o esito di fusioni - compete la pianificazioneurbanistica, da esercitare con i vincoli e gli obiettividefiniti dalla Città Metropolitana per quanto riguardale infrastrutture. Poiché alla Città Metropolitanacompete la “pianificazione territoriale generale”, neconsegue che gli strumenti urbanistici dei Comuni,per quanto concerne la disciplina delle trasforma-zioni dei loro territori, devono avere previsioni com-patibili e coerenti con il piano territoriale
LE FORME DI PIANIFICAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA E
I CONTRIBUTI DELLA VALUTAZIONE
INSERTO SPECIALE
Stefano StanghelliniDipartimento DPPAC, Università Iuav di Venezia, Santa Croce 1957, Ca’ Tron, 30135, Venezia, Italia
SPECIAL INSERT
The Metropolitan City Planning Issues andthe Evaluation Researches
1Legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulla città metropolitana, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, c.d. “legge Delrio”.2Ivi, art. 1, c. 2.3Ivi, art. 1, c. 44.4Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dicoter (2004), Linee guida per la Costruzione dei Piani strategici delle Città.
14
Inserto speciale_LaboEst_10_Stanghellini.qxp_Layout 1 08/10/15 15:15 Pagina 135

15
metropolitano. 3. Nell’area metropolitana, dunque, si prefigura unrapporto gerarchico tra la pianificazione territorialegenerale della Città Metropolitana e la pianificazioneurbanistica dei Comuni. La stessa legge indica la na-tura delle verifiche che sostanzieranno tale rapportogerarchico: le previsioni comunali saranno valutatesecondo criteri di compatibilità e di coerenza daparte della Città Metropolitana. Difficile ritenere, tut-tavia, che le verifiche di compatibilità e di coerenzapossano limitarsi alle infrastrutture, anche se nonpare che venga messo in discussione il principio disussidiarietà. 4. Sono ancora da definire i contenuti della “pianifi-cazione territoriale generale” esercitata dalla CittàMetropolitana. L’attributo “generale” si presta amolte interpretazioni. Assumendo tuttavia la mede-sima chiave di lettura che ha segnato l’evoluzionedelle forme della pianificazione territoriale e urbani-stica (Micelli E. e Lombardi P., 1999), è ragionevoleipotizzare che si tratti di una pianificazione di tipostrutturale, focalizzata cioè sulle invarianti e sullegrandi opzioni fra cui, in particolare, quelle relativealle infrastrutture. L’attendibilità di questa interpre-tazione è suffragata dal fatto che, nel dibattito suglistrumenti di governo del territorio, si è acquista laconsapevolezza che l’ambito territoriale appropriatoper la componente strutturale della pianificazionedeve essere ampio, e quindi comprendere il territoriodi più comuni. Spetterà alle unioni dei Comuni o ainuovi Comuni esito di fusioni, il compito di governare,a loro volta, la dimensione operativa della pianifica-zione, ossia le previsioni attinenti alla trasformazionee riqualificazione urbanistica.
La principale novità della legge istitutiva della Città Me-tropolitana è tuttavia la rilevanza attribuita alla connota-zione strategica della sua mission. Quindi l’accento sisposta da una pianificazione territoriale generale, proba-bilmente di tipo strutturale, ad una pianificazione di tipostrategico che quindi enfatizza gli obiettivi, i progetti, le ri-sorse da mettere in campo, gli attori, la misura dei risul-tati; cioè da un tipo di pianificazione, quella territoriale,che dovrà essere svolta con le conoscenze ed i tempi ne-cessari, e quindi orientata sul medio-lungo periodo, aduna pianificazione, quella strategica, da attivare subito eda rendere operativa nel giro di poco tempo.
Sulla pianificazione strategica in Italia
In Italia possiamo vantare ormai più di 15 anni di speri-mentazioni nel campo della pianificazione strategica ap-plicata alla città. Pressoché tutte le città che sono statericonosciute dalla legge quali città metropolitane hanno
praticato almeno una esperienza di pianificazione strate-gica. Talvolta si è trattato anche di esperienze riferite al-l’area vasta connessa alla città principale da legamifunzionali, e non solo al comune capoluogo. Tuttavia, salvoil caso di Torino (Torino Internazionale, 2000), il bilanciodi questa sperimentazione non può essere accompa-gnato da un giudizio positivo. Per lo più si è trattato di pianificazioni strategiche svolte“una tantum”, spesso additive agli altri processi decisio-nali inerenti al governo del territorio e da essi separate,e quindi con scarsa legittimazione politica, avviate congrandi ambizioni ma poi dissolte in rivoli partecipativi emancate scelte, esperienze cadute nell’oblìo dopo il pas-saggio della città attraverso la prima scadenza elettorale. Proprio perché consci tanto delle aspettative quanto deilimiti delle esperienze pregresse, oggi siamo curiosi di vi-vere una nuova stagione, che potrà portare a buoni risul-tati se si farà tesoro dell’esperienza passata. Il punto dipartenza giuridico, è infatti ben diverso dal passato. Lapianificazione strategica della Città Metropolitana non èpiù un’attività volontaristica o un impegno assunto dietrolo stimolo di specifiche sovvenzione statali o regionali,come nelle precedenti sperimentazioni. Oggi esiste unente la cui forza è connessa all’importanza delle realtàeconomiche e del numero di persone che agiscono nelterritorio da esso governato, nonché dalle risorse di varianatura esistenti ed attivabili, al quale la legge attribuiscefunzioni sia di pianificazione strategica che di pianifica-zione territoriale generale.La precedente esperienza italiana di pianificazione stra-tegica ha comunque lasciato un’importante eredità, rap-presentata dalle innovazioni che da essa ha indotto nelsistema della pianificazione territoriale e urbanistica. Lapianificazione strategica ha infatti veicolato nella pianifi-cazione territoriale e urbanistica:
a) l’assunzione di una idea di città, di una vision, qualeidea guida del processo di pianificazione;b) l’esplicitazione degli obiettivi articolati in generali especifici;c) il coinvolgimento, nelle decisioni e nelle attuazioni,dei soggetti portatori di interessi generali o comun-que rilevanti per la città;d) il confronto competitivo fra progetti e operatoriquale metodologia per la formazione delle scelte dipiano;e) la ricerca della fattibilità tecnica, economica, pro-cedurale, dei progetti individuati;f) il monitoraggio del piano nel corso della sua attua-zione e la valutazione degli effetti via via ottenuti.
L’importanza dell’inclusione nella pianificazione territo-riale ed urbanistica di alcuni importanti caratteri dellapianificazione strategica, sta nel fatto che la prima incidesull’uso del suolo e quindi sul comportamento dei sog-getti che hanno a che fare con la sua trasformazione. In
LaborEst n.10/2015
Inserto speciale_LaboEst_10_Stanghellini.qxp_Layout 1 08/10/15 15:15 Pagina 136

16
INSERTO SPECIALE
questo suo specifico requisito sta la sua rilevanza. La pianificazione strategica, invece, può incidere sul com-portamento dei soggetti che operano nella città solo sepuò avvalersi di leve finanziarie, fiscali, normative in gradodi orientare i loro comportamenti, e di un sistema di ac-cordi formalizzati, impegnativi per i loro sottoscrittori pub-blici e privati. Finora questo requisito è mancato allapianificazione strategica, salvo che nel felice caso di To-rino. Ora, invece, ci sono le premesse giuridiche perchéla pianificazione strategica evolva da attività volontaristicaa funzione di governo efficace.Per le considerazioni appena svolte, desta perplessità laprevisione di un piano strategico triennale, aggiornabileogni anno, molto più simile al “programma triennale delleopere pubbliche”, che al “piano del sindaco” metropolitano.Ciò che tuttavia rileva nella legge istitutiva della Città Me-tropolitana, è la cura dello “sviluppo strategico del terri-torio metropolitano”, funzione che evoca i concetti dicompetitività, sostenibilità, eccellenza, comunità, effi-cienza, efficacia.Da questo punto di vista, nella legge si può cogliere lo sti-molo ad intraprendere, con rapidità, processi di pianifica-zione strategica coinvolgenti i portatori di interesse diogni territorio metropolitano, sotto la guida di una regiapolitica lungimirante ed autorevole, capace di definire, inbreve tempo, la vision della città metropolitana, gli obiet-tivi e i progetti strategici, ed a responsabilizzare gli sta-keholder nell’attuazione di tali progetti attraverso specificiaccordi. La speranza è che la politica riesca a coprireadeguatamente lo spazio che le compete.
Le valutazioni nella pianificazione strategica
Per quanto riguarda l’apporto che spetta alle disciplinescientifiche, le esperienze sin qui compiute, seppur pocoefficaci dal punto di vista realizzativo, hanno messo in lucequali siano i percorsi metodologici da seguire, i dati ne-cessari, i soggetti da coinvolgere, gli errori da evitare.Spetterà al sindaco metropolitano il compito utilizzare almeglio ciò che le discipline scientifiche possono produrre,accompagnando il processo di pianificazione strategicacon l’indirizzo e il sostegno che compete ad un esercizio“alto” della politica. E’ questo un compito tutt’altro chesemplice.Un po’ più semplice, almeno apparentemente, si pre-senta il ruolo delle discipline scientifiche. Alle discipline va-lutative, in particolare, spetta il compito di convincere ildecisore politico ad accettare che i problemi siano affron-tati attraverso l’esame dell’intera gamma delle alterna-tive possibili; di recepire i valori di cui è portatore ilprogramma politico del sindaco e di tradurli in parametritecnici di valutazione interagendo con altre discipline; diallestire le metodologie atte a finalizzare al progetto l’ana-lisi dei dati e le modalità di partecipazione dei cittadini; di
mettere a disposizione del processo di pianificazione stra-tegica le tecniche capaci di rendere le scelte conclusivemotivate, trasparenti, fattibili; di allestire adeguati sistemidi monitoraggio nel tempo dell’attuazione del piano (Ar-chibugi, 2002). In conclusione, le attività di valutazione,realizzate attraverso procedure formalizzate, nutrono estrutturano l’intero processo di pianificazione strategica,di cui sono una componente imprescindibile (Moroni ePatassini, 2006).Molte esperienze dimostrano come le metodologie valu-tative rappresentino - nella pianificazione strategica - unflusso pressoché continuo di apporti tecnico-scientifici di-versamente caratterizzati. Basti pensare alle metodolo-gie chiamate in letteratura “quasi valutative”, checonsentono sintesi efficaci dei contenuti del “quadro co-noscitivo” quali l’analisi Swot (Stanghellini e Lombardi,2004), o che accompagnano le prime tappe del percorsopartecipativo (es. mappe cognitive), o che aiutano a co-struire la vision della città come le analisi degli scenari oa strutturare il sistema degli obiettivi del piano come levalutazioni tassonomiche (Comune di Trieste, 2001; Co-mune di Modena, 2004).Basterà ricordare anche il ruolo essenziale che valuta-zioni multicriteriali svolgono nella messa a punto delle al-ternative, nello sviluppo dei loro contenuti e nel loroordinamento, valorizzando l’utilità della “partecipazione”dei portatori di interessi (Fattinnanzi e Mondini, 2015).Valutazioni a criteri multipli possono inoltre combinarsicon metodologie di tipo economico-finanziario per preci-sare le caratteristiche dei progetti e migliorare la loro fattibilità. Preme evidenziare, in particolare, due aspetti della rela-zione della attività di valutazione con la pianificazione stra-tegica. Un primo aspetto è che ogni processo dipianificazione strategica, per la singolarità del contestosocio-economico e territoriale in cui si sviluppa, pone unadomanda di valutazione almeno in parte originale, che sti-mola a rispondervi con metodologie valutative che inno-vano le metodologie più consolidate, e quindi ègeneratore di innovazione disciplinare. Un secondoaspetto, è che un processo di pianificazione strategicache si esprime in un “piano d’azione” che si avvale di pro-cedure formalizzate di valutazione, assume una identitàtecnicamente solida, i cui contenuti sono rappresentabilie comunicabili alla città, e al tempo stesso modificabili inmodo motivato grazie alla sua flessibilità.Un processo di pianificazione strategica così caratteriz-zato, infine, può completarsi agendo su due fronti:
- quello della programmazione pluriennale degli inve-stimenti promossi dalla Città Metropolitana e daglistakeholder coinvolti;- e quello della “pianificazione territoriale generale”.
Poiché fra le due attività si creeranno delle interdipen-denza e si renderanno necessari reciproci aggiusta-menti, ecco che anche le molteplici dimensioni delgoverno del territorio - quella strategica, la territoriale e
Inserto speciale_LaboEst_10_Stanghellini.qxp_Layout 1 08/10/15 15:15 Pagina 137

17
quella economico-finanziaria - dovrebbero riuscire a su-perare le consuete separatezze e ad esprimersi in modounitario e dinamico (Campeol e altri, 2010).
Bibliografia
Archibugi F., Introduzione alla Pianificazione strategica, Centro di studie piani economici, 2002
Campeol G., Copiello S., Lioce R. e Stanghellini S., La valutazione inte-grata nel piano comunale della legge regionale n. 11/2014 del Ve-neto: il caso di Portogruaro, in Bentivegna V. e Miccoli S., ValutazioneProgettazione Urbanistica, DEI, Roma, 2010
Comune di Modena, Un decennio di scelte. Bilancio Sociale di mandatoper un Piano Strategico della Città, Modena, 2004
Comune di Trieste, Un Piano strategico per Trieste, Trieste, Stella ArtiGrafiche, 2001
Fattinnanzi E. e Mondini G., L’analisi multicriteri tra valutazione e deci-sione, DEI, Roma, cur., 2015
Micelli E. e Lombardi P., Le misure del piano. Temi e strumenti dellavalutazione dei nuovi piani, FrancoAngeli, Milano, 1999
Moroni S. e Patassini D., Problemi valutativi nel governo del territorioe dell’ambiente, FrancoAngeli, Milano, cur., 2006
Stanghellini S. e Lombardi P., Il Piano Strategico e i suoi principali stru-menti operativi: l’Analisi Swot e il Bilancio Sociale, in Archibugi F. e Sa-turnino A. (cur.), Pianificazione strategica e governabilità ambientale,Alinea, Firenze, 2004
Torino Internazionale, Il Piano strategico della Città, Torino, 2000
LaborEst n.10/2015
Inserto speciale_LaboEst_10_Stanghellini.qxp_Layout 1 08/10/15 15:15 Pagina 138

Finito di stampare nel mese di Giugno 2015 per Laruffa Editore SRL da Creative Artworks
pagine bianche finali 3.qxp_Layout 1 04/08/15 10:26 Pagina 3