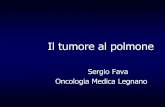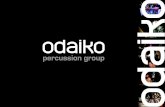International Congress of the Italian Association of ... · L’esame autoptico mostra la presenza...
-
Upload
duongxuyen -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of International Congress of the Italian Association of ... · L’esame autoptico mostra la presenza...
Close this window to return to IVIS www.ivis.org
International Congress of the Italian Association of Companion
Animal Veterinarians
29 - 31 May, 2009 Rimini, Italy
Next Congress :
65th SCIVAC International Congress May 28-30, 2010 - Rimini, Italy
Reprinted in IVIS with the permission of the Congress Organizers
COMUNICAZIONIBREVI
Le comunicazioni sono elencate in ordine alfabetico secondo il cognome dell’autore presentatore.
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
549
MICOSI POLMONARE DA ASPERGILLUS FUMIGATUS E CANDIDA FAMATA IN CONIGLIA CON ADENOCARCINOMA UTERINO E CARCINOMA EPATICO
P. Roccabianca, DVM, PhD, Dipl. ECVP1, M. Avanzi, DVM2
1 Istituto di Anatomia Patologica Veterinaria e Patologia Aviare Università degli Studi di Milano, Milano, Italia2 Libero professionista, Castelfranco Veneto, Italia
Area di interesse: Animali esotici
Introduzione. La micosi polmonare è una condizione che si osserva raramente nei conigli da compagnia. Questo caso clinico èinsolito per la contemporanea presenza a livello polmonare di un’infezione di due diversi miceti patogeni e di metastasi polmo-nari di due tipi di neoplasie. Descrizione del caso. Una coniglia da compagnia, di 8 anni di età, intera, viene portata alla visita per una difficoltà respirato-ria insorta da una decina di giorni. Dall’anamnesi risulta che il soggetto viene tenuto libero in una stanza della casa ed alimen-tato con fieno, erba e vegetali. Una terapia antibiotica, somministrata dal proprietario, non ha portato a miglioramenti. Negli ul-timi giorni il soggetto ha presentato disoressia/anoressia e dal giorno precedente la visita le condizioni generali si sono ulte-riormente aggravate. Alla visita il soggetto mostra abbattimento, pallore, moderata dispnea, senza scolo nasale, e dilatazione ad-dominale. La produzione di feci è cessata. Le radiografie di torace e addome, nelle due proiezioni standard, mostrano la pre-senza di addensamenti a carico dei campi polmonari, dilatazione gastrica e meteorismo a carico di stomaco e intestino tenue.Poiché la proposta di eutanasia viene rifiutata dal proprietario, si tenta una terapia di sostegno, ma il soggetto muore entro po-che ore dal ricovero. L’esame autoptico mostra la presenza di una voluminosa lesione a carico del polmone destro caratterizza-ta da una capsula che delimita una cavità tappezzata da micelio fungino. I polmoni sono disseminati da noduli biancastri di al-cuni mm di diametro e lesioni simili sono presenti nel parenchima epatico. L’utero è leggermente aumentato di volume, di dia-metro irregolare, con aree di calcificazione ed il lume contiene materiale purulento. Le salpingi sono notevolmente dilatate equella destra presenta aderenze con l’intestino tenue.L’esame istologico dimostra la presenza di un adenocarcinoma infiltrante a livello dell’utero e di un carcinoma indifferenziato(con morfologia diversa da quella del tumore uterino) a livello epatico. Nel polmone sono presenti noduli composti da tubuli dicellule epiteliali morfologicamente simili a quelli della neoplasia uterina e aggregati multifocali di cellule neoplastiche morfo-logicamente sovrapponibili a quelle della neoplasia epatica. La reazione di PAS mostra la presenza di ife fungine e conidiofori.Dall’esame colturale del tessuto polmonare venivano isolati Aspergillus fumigatus e Candida famata. Conclusioni. L’adenocarcinoma uterino è il tumore più comune nelle coniglie, con un’incidenza che, secondo la razza, può ar-rivare all’80%. Questi tumori hanno crescita lenta e restano spesso asintomatici per anni, fino a quando non metastatizzano agliorgani interni, principalmente i polmoni, come in questo caso. I tumori epatici di origine duttale, sia benigni che maligni, sonorelativamente frequenti (il quarto tipo di tumore spontaneo nel coniglio); in questo caso, le cellule neoplastiche erano fortementeindifferenziate, ma con caratteristiche morfologiche che ne fanno sospettare un’origine epiteliale.Sebbene il coniglio sia impiegato come modello sperimentale per lo studio delle micosi polmonari, l’incidenza spontanea di que-ste patologie è molto rara, ed è solitamente riferibile a infezioni da Aspergillus fumigatus o A. niger. Il riscontro, come in que-sto caso, di un voluminoso granuloma micotico con sviluppo di ife fungine simile a quanto si osserva nell’aspergillosi aviare èun reperto insolito, come è insolito l’isolamento dalla lesione di più specie fungine, tra cui Candida spp. Nel coniglio, non sem-brano esistere precedenti segnalazioni di lesioni polmonari da C. famata, ritenuto patogeno emergente nell’uomo e negli ani-mali. Le micosi profonde sono solitamente secondarie a condizioni di grave immunodepressione o alla presenza di una quanti-tà di spore fungine tale da sopraffare le difese immunitarie dell’ospite. In questo soggetto, la presenza di due diverse neoplasie,entrambe con metastasi polmonari, in un soggetto anziano, può aver rappresentato il fattore favorente l’insorgenza di una gravepolmonite micotica. L’abbondante substrato di fieno nell’ambiente in cui viveva il coniglio può aver rappresentato la fonte del-l’infezione.
Bibliografia
Canny1 CJ, Gamble CS. Fungal diseases of rabbits. Vet Clin North Am Exot Anim Pract. May 2003;6(2):429-33, viii.Desnos-Ollivier M, Ragon M, Robert V et al. Debaryomyces hansenii (Candida famata), a rare human fungal pathogen often misidentified as Pichia guillier-
mondii (Candida guilliermondii). J Clin Microbiol. 2008 Oct;46(10):3237-42. Epub 2008 Aug 13.Harkness J, Wagner J. The biology & medicine of rabbits & rodents. 4th edition. Philadelphia: Williams & Wilkins; 1995.Heatley JJ, Smith AN. Spontaneous neoplasms of lagomorphs. Vet Clin North Am Exot Anim Pract. September 2004;7(3):561-77.Saito K, Nakanishi M, Hasegawa A. Uterine disorders diagnosed by ventrotomy in 47 rabbits. J Vet Med Sci. June 2002;64(6):495-7.
Indirizzo per corrispondenza:Dott.ssa Marta Avanzi - Ambulatorio Veterinario Associato - Via S. Pio X 154 - 31033 Castelfranco Veneto (TV), Italia - Tel. 0423/722094
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
UTILIZZO DELLA PLACCA LCP SYNTHES IN TRAUMATOLOGIA VETERINARIA
B. Peirone, Med Vet, PhD1, P. Piga, Med Vet2, G. Baroni, Med Vet, PhD3, A. Ferretti, Med Vet, Dipl ECVS4,M. Olivieri, Med Vet, Phd5, G. Pisani, Med Vet6, A. Boero Baroncelli, Med Vet7,1
1 Dipartimento di Patologia Animale, Facoltà di Medicina Veterinaria, Torino, Italia2 Centro Veterinario Torinese, Torino, Italia - 3 Clinica Veterinaria Baroni, Rovigo, Italia
4 Clinica Veterinaria Ortopedica, Legnano, Italia - 5 Clinica Veterinaria Malpensa, Milano, Italia6 Centro Veterinario dei Dottor Pisani, Carli, Chiodo, Castelnuovo Magra, Italia
7 Clinica Albese per Animali da Compagnia, Cuneo, Italia
Area di interesse: Ortopedia
Scopo del lavoro. La fissazione interna in traumatologia ha subito una progressiva evoluzione: dal tradizionale approccio “mecca-nico”, teso ad una meticolosa ricostruzione anatomica del focolaio, ad un approccio “biologico”, caratterizzato da una minore in-vasività, dal rispetto della rete vascolare e dall’allineamento delle fratture giudicate non ricostruibili 1. L’evoluzione del design del-le placche è volta a soddisfare questa tendenza. In particolare la Locking Compression Plate (LCP) Synthes è caratterizzata dallapresenza di uno speciale foro definito “combi-hole che permette sia l’inserimento di viti bloccate che di viti standard in modo dapoter utilizzare la placca sia come un fissatore interno che come una placca tradizionale. Le scanalature che riducono il contatto traplacca e osso preservano la vascolarizzazione periostale, le estremità arrotondate e sottili ne facilitano lo scivolamento sotto i tes-suti molli in caso di osteosintesi con tecnica MIPO (Minimal Invasive Plate Osteosynthesis)2. La placca LCP è ampiamente impie-gata in Umana nel trattamento di fratture diafisarie pediatriche, fratture su osso osteoporotico o affetto da osteomielite, fratture com-minute o metafisarie, fratture complicate dalla presenza di impianti protesici e nel trattamento delle pseudoartrosi3. In letteraturaVeterinaria sono presenti pochi lavori sull’utilizzo clinico delle LCP nella traumatologia dei piccoli animali3,4. Scopo di questo la-voro è descrivere l’applicazione clinica della placca LCP Synthes nel trattamento delle fratture nel cane. Materiali e metodi. Sono stati inclusi 25 cani, di età compresa tra 5 mesi e 10 anni (media 3,3 anni / mediana 2 anni) di pesocompreso tra i 12 e i 73 kg (media 30 kg/ mediana 28 kg) trattati con placca LCP nel periodo compreso tra maggio e dicembre2008, con follow-up clinico e radiografico ad almeno 2 mesi dalla chirurgia. Risultati. Sono state trattate 22 fratture e 3 pseudoartrosi. Le fratture erano così distribuite: 8 radio e ulna, 6 omeri, 5 femori e 3 ti-bie. Di queste 10 erano fratture semplici, 9 comminute e 4 scheggiose; 24 erano chiuse, 1 esposta di 1°. Due pseudoartrosi erano acarico del femore, 1 a carico dell’omero: 2 vitali settiche, 1 non vitale non settica. L’accesso chirurgico è stato eseguito in 22 casicon tecnica tradizionale e in 3 casi con tecnica MIPO. Sono state utilizzate 17 placche LCP 3.5 standard da 6 a 13 fori, 6 placcheLCP 3.5 broad da 12 a 16 fori, 1 placca LCP 3.5 da ricostruzione 12 fori. In 11 casi sono stati associati altri impianti. La placca èstata utilizzata in 12 casi con funzione di neutralizzazione, in 7 di compressione e in 6 a sostegno. In 22 casi la placca è stata mo-dellata, mentre in 3 casi è stata applicata senza modellamento. In 16 casi è stata utilizzata una tecnica mista, inserendo sia viti cor-ticali che bloccate, mentre in 9 casi sono state utilizzate solo viti bloccate. Sono state riscontrate complicanze intra-operatorie in 5casi, tra cui: difficoltà nel posizionamento della placca (2 casi), bloccaggio della vite non ottimale (2 casi), difficoltà nell’inseri-mento del guida punte (1 caso). L’esame radiografico post-operatorio ha evidenziato: in 19 casi un corretto allineamento, in 6 casiun difetto di allineamento. Il follow-up radiografico ha evidenziato consolidazione in 20 casi, processo di consolidazione in atto neirestanti 5. In 4 casi abbiamo osservato complicanze post-operatorie: piegamento della placca, pull-out di una vite bloccata, sinovi-te del carpo, piaga da decubito. Il follow-up clinico ha evidenziato recupero eccellente in 17 casi, buono in 6, discreto in 2. Conclusioni. Il campione trattato in questo studio pilota, anche se numericamente esiguo, rispecchia sufficientemente le principa-li tipologie di pazienti fratturati di taglia medio-grande. In tutti pazienti il trattamento ha portato o stava portando a consolidazionedella frattura. Delle 22 fratture, 17 risultavano caratterizzate da un focolaio scheggioso, comminuto o da un moncone di piccole di-mensioni, che rappresentano le indicazioni principali per l’impiego della placca LCP. In particolare l’impiego delle viti bloccate èrisultato vantaggioso nel trattamento delle fratture metafisarie con piccolo moncone osseo, dove è stato sufficente inserire 2 viti perottenere adeguata stabilità. In 3 fratture altamente comminute le caratteristiche della placca hanno consentito un trattamento contecnica MIPO, con riduzione dei tempi chirurgici e di recupero funzionale. Nei 3 casi di pseudoartrosi l’osso si presentava osteo-porotico e danneggiato dalla precedente presenza di impianti: il trattamento con placca LCP ha conferito notevole stabilità alla sin-tesi ossea, permettendo un carico precoce nel periodo post-operatorio. Esaminando le complicazioni, solo in un caso, a seguito delbloccaggio non ottimale della vite, si è verificato pull-out della stessa a 30 giorni di distanza. Il piegamento della placca, osserva-to in un altro caso, è stato imputato alla scelta inadeguata dell’impianto in relazione a peso del soggetto trattato, in quanto la resi-stenza alle forze di piegamento della placca LCP è analoga a quella delle DCP standard5.
Bibliografia1. Stephan M. Perren.J Bone Joint Surg 2002;84-B:1093-110.2. Michael W.Injury 2003,34.3. C.Post, T.Guerrero, K.Voss, P. M.Montavon.VCOT 2008; 21: 166–170.4. C.S. Schwandt, P. M.Montavon.VCOT 2005; 18: 194–8.5. M. DeTora, K.Kraus. VCOT 2008; 21: 318–322.
Indirizzo per corrispondenza:Dott. Alessandro Boero Baroncelli - Clinica Albese per Animali da Compagnia - Via Vivaro 25 - 12051 Alba (CN), Italia Tel. 017335122 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
550
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
ANALISI COMPARATIVA TRA VALUTAZIONE RADIOGRAFICA E RICOSTRUZIONE 3D DELLA DEVIAZIONE ANGOLARE DEL FEMORE E DELLA TIBIA DEL CANE
E. Baroni, DMV, PhD1,3, M.F. Ciffo, DMV2, T. Baroni, DMV1, S. Meggiolaro, DMV2,3,G. Concheri, Professore, Ingeniere4, M. Isola, Professore, DMV3
1 Clinica Veterinaria Baroni, Rovigo, Italia2 Libero professionista, Padova, Italia
3 Dipartimento Scienze Cliniche Veterinarie, facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Padova, Padova, Italia4 DAUR, facoltà di Ingenieria Meccanica, Università degli Studi di Padova, Padova, Italia
Area di interesse: Ortopedia
Scopo del lavoro. Scopo di questo lavoro è quello di valutare assi ed angoli del femore e della tibia sia su un modello 3D chesulla corrispondente radiografia e compararli tra loro. Materiali e metodi. I parametri geometrici forniti dalla letteratura che oggi usiamo per la valutazione della forma di un seg-mento osseo, sono parametri adattati da punti di riferimento anatomici dell’osso in toto, traslati sulle radiografie, in una situa-zione di bidimensionalità (2D). Questi adattamenti a volte non possono avere corrispettivo univoco nella tridimensionalità (3D).Scopo di questo lavoro è quello di valutare assi ed angoli del femore e della tibia sia su un modello 3D che sulla corrisponden-te radiografia e compararli tra loro. A tale scopo sono stati scelti otto cadaveri del peso superiore ai 20 kg, nessuno deceduto percause che avessero qualcosa a che vedere con la materia di studio in esame. Tutti i soggetti sono stati radiografati seguendo idettami della bibliografia internazionale. Successivamente le radiografie sono state trasferite su computer tramite scanner (HPscanjet G4050) e su di esse sono stati tracciati gli assi secondo i vari metodi descritti in letteratura grazie ad un programma Au-toCAD 2002 (Autodesk). Si è poi passato alla fase dello sviluppo della fase 3D, previa scheletrizzazione dei segmenti ossei inoggetto e acquisizione in 3D con un sistema di scannerizzazione 3D KONIKA MINOLTA VI-910 (Konika Minolta Sensing Inc).Queste immagini vengono successivamente trasferite al software PEG (Polygon Editing Tool ver.1.22; konika Minolta SensingInc) correlato allo scanner. Dopo aver terminato la fase di acquisizione tramite scanner il modello 3D è stato importato nel pro-gramma RAPIDFORM 2006 (Inus Technology inc.) che ci ha permesso di ottenere, seguendo le definizioni tradizionali, gli as-si e gli angoli descritti per la valutazione delle deformità scheletriche. Si sono quindi calcolati:Asse meccanico. Asse epifisario.Asse cefalico.Asse cervicale.Asse epicondiloideo. L’individuazione di tale asse è stato tralasciato, visto che ci si è limitati al calcolo secondo Montavon.Asse intercondiloideo. Non è stato calcolato, in quanto ci si è limitati ad utilizzare il vettore precedentemente costruito per in-dividuare il centro del ginocchio.Asse anatomico del femore distale. Asse articolare prossimale della tibia. Asse articolare distaleAsse meccanico Risultati. Una volta definiti tutti vari piani possiamo ricavare e confrontare tra la misurazione su radiografie e in 3D:a_sym = asse anatomico secondo Symaxa_mont = asse anatomico secondo Montavona_kow = asse anatomico secondo Kowaleskia_tom = asse anatomico secondo Tomlinsonc_class = asse cervicale secondo metodo classicoc_sym = asse cervicale secondo Symaxc_hau_a = asse cervicale secondo metodo Hauptman Ac_Hau_b = asse cervicale secondo metodo Hauptman Bc_mont = asse cervicale secondo Montavonmecc = asse meccanicolinea_art_prox = linea di orientamento articolare prossimaleasse_inter= asse intercondiloideoasse_anat_dist = asse anatomico distaleaLPFA = angolo anatomico laterale prossimale femoraleaMDFA = angolo anatomico mediale distale femoralee per quel che riguarda la tibia:asse meccanicoasse articolare prossimaleasse articolare distalemMPTA = l’angolo meccanico mediale prossimale
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
551
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
mMDTA = l’angolo meccanico mediale distaleMAD = angolo di deviazione meccanica I dati ottenuti da questo studio sono molteplici e per una loro miglior comprensione devono essere valutati di caso in caso, con-frontandoli direttamente tra i valori ottenuti con la misurazione sulle radiografie che su i modelli 3D e l’indagine statistica deirisultati stessi. Conclusioni. In generale si è evidenziato un errore di stima, sia in senso positivo che negativo, del valore misurato sulle radio-grafie rispetto a quello misurato sui preparati 3D.Per quel che riguarda il femore si riesce ad apprezzare come siano soprattutto le misurazioni effettuate sull’epifisi prossimaliquelle che più spesso sono accompagnate da errori evidenti in particolar modo con riferimento all’asse cervico-diafisario e aquello di versione. Dai dati in possesso possiamo quindi affermare che il metodo migliore per l’individuazione dell’asse cervi-cale è quello Symax. Si dimostra altresì una certa inadeguatezza del metodo Montavon. Per quel che riguarda gli assi anatomi-ci il metodo Kowalesky sembra essere il più affidabile. Per quel che riguarda la tibia, in generale possiamo dire che si è evidenziato un errore di stima del valore misurato sulle radio-grafie rispetto a quello calcolato sul modello tridimensionale. Questo sembra dovuto al fatto che strutture complesse, quali adesempio le superfici articolari in questione subiscono una semplificazione forzata, un appiattimento, dovuto alle caratteristicheintrinseche dell’esame radiografico, che traspone tutto su di un unico piano. Questo potrebbe essere lo spunto per una riconsi-derazione, nella tridimensionalità, della definizione dei range fisiologici e patologici per la tibia, vista la scarsa affidabilità conil metodo tradizionale della misurazione su radiografie in 2D.
Bibliografia
1. Apelt D., Kowaleski M.P., Dyce J.: Comparison of Computer Tomographic and Standard Radiographic Determination of Tibial Torsion in The Dog. Ve-terinary Surgery, 2005, 34(5), 457-462.
Indirizzo per corrispondenza:Dott. Ermenegildo Baroni - Clinica, Via Martiri Di Belfiore, 69/D - 45100 Rovigo (RO), Italia Tel. 0425471076 - Cell. 348/7459959 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
552
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) E RISONANZA MAGNETICA (RM) NEL MIELOMA MULTIPLO DEL CANE
S. Cancedda, DMV1, M. Vignoli, DMV, SRV, Dipl. ECVDI1, A. Rapisarda, DMV, MS, Dr. Ric., SPCAA1,M. Baroni, DMV, Dipl. ECVN2, R. Terragni, DMV, MS, SPCAA1, C. Falzone, DMV, Dipl. ECVN2,
F. Rossi, DMV, SRV, Dipl. ECVDI1
1 Libero professionista, Sasso Marconi (BO), Italia2 Libero professionista, Monsummano Terme (PT), Italia
Area di interesse: Neurologia
Scopo del lavoro. Il mieloma multiplo (MM) è una rara forma tumorale caratterizzata dalla proliferazione e dall’accumulo diun singolo clone di plasmacellule nel midollo osseo. I segni clinici che si osservano sono secondari all’infiltrazione delle cellu-le neoplastiche nel midollo osseo e/o nei visceri. Per la diagnosi di mieloma multiplo devono essere presenti almeno due dei se-guenti riscontri patologici: evidenza radiografica di lesioni osteolitiche, proteinuria di Bence–Jones, iperprotidemia con gam-mopatia monoclonale, plasmocitosi midollare (plasmacellule > 20% o plasmacellule atipiche >10%). Circa un quarto/due terzidei cani affetti da MM mostrano segni radiografici di osteolisi o di diffusa osteopenia. Vista la prevalenza di queste lesioni ossee e la loro implicazione diagnostica, prognostica e terapeutica, è evidente la necessitàdi poterle identificare con certezza e potere giungere, correlandole con gli altri riscontri patologici, ad una diagnosi certa di MM.Scopo del presente lavoro è quello di analizzare in modo retrospettivo diverse tecniche di diagnostica per immagini disponibiliin Medicina Veterinaria (radiologia diretta, TC e RM) per studiare le lesioni ossee che occorrono in caso di MM. Materiali e metodi. Sono stati studiati 7 cani con diagnosi certa di mieloma multiplo: 5 maschi e 2 femmine, di età compresa tra i5 e 11 anni, appartenenti a diverse razze (1 Labrador, 1 Epagneul Breton, 1 Boxer, 1 Pastore Tedesco, 3 Meticci). I pazienti furonoriferiti alle nostre strutture per problematiche di natura neurologica (depressione del sensorio, alterazioni dell’andatura, deficit pro-priocettivi e/o dei riflessi spinali), e manifestazioni algiche alla palpazione delle ossa (soprattutto rachide), ipotrofia muscolare ge-neralizzata, anoressia e in alcuni casi poliuria e polidpsia. Tutti i cani, oltre agli esami di laboratorio del caso, sono stati sottoposti adindagini di diagnostica per immagini. Di questi 7 casi 1 veniva valutato con esame radiografico, 1 con TC, 2 con RM e 3 con radio-logia e TC associate. Le indagini radiografiche prevedevano in tutti e 4 i casi lo studio della colonna vertebrale in toto e in 2 casi an-che il torace e il bacino. L’esame TC in tutti e 4 i casi prevedeva lo studio del rachide toraco-lombare e in 2 casi anche del sacro edel bacino con metodo diretto e postcontrastografico dopo iniezione endovenosa di mezzo di contrasto iodato non ionico. Durantetutti gli studi TC si è provveduto anche ad eseguire biopsie osee percutanee TC-guidate delle lesioni osteolitiche nelle vertebre lom-bari e biopsie midollari nell’ala dell’ileo. Per tutte le biopsie sono stati utilizzati aghi tipo Jamshidi da 8-10g. Nei 2 pazienti sottopo-sti a RM sono state riprese sequenze precontrastografiche SE T1, FSE T2, STIR T2 della colonna vertebrale toraco-lombare sui pia-ni sagittale e traversale e SE T1 dopo somministrazione di mezzo di contrasto paramagnetico.Risultati. Tutte le modalità di imaging utilizzate hanno permesso di identificare le lesioni ossee a carico dei tratti di rachide in-dagati e del bacino. In tutti i 7 cani esaminati sono state riscontrate imponenti lesioni osteolitiche soprattutto a carico del rachi-de toraco-lombare; in 2 casi indagati con la radiologia e in 2 casi sottoposti a TC le stesse lesioni sono state osservate anche alivello di ileo e sacro. In 1 caso sono state evidenziate radiologicamente anche delle lesioni atipiche litico-proliferative a livellodi coste e sternebre oltre a quelle osteolitiche del rachide, del bacino e della scapola. La RM ha evidenziato segnale debolmen-te iperintenso nelle sequenze T1-pesate e buona ed omogenea captazione di mezzo di contrasto. A carico dei corpi vertebrali edei processi spinosi si evidenziavano alterazioni multiple per la presenza di aree disomogenee a segnale lievemente iperintensonelle sequenze T1 e T2 e decisamente iperintenso nelle sequenze STIR. La TC e la RM hanno inoltre permesso, a differenzadella radiologia, di evidenziare l’invasione nel canale vertebrale da parte della neoplasia, quando presente. Conclusioni. Radiologia, TC e RM sono utili modalità diagnostiche in corso di MM. La tomografia computerizzata e la riso-nanza magnetica consentono di valutare meglio la localizzazione e l’estensione della neoplasia, in particolare riguardo l’inva-sione del canale vertebrale e della compressione midollare conseguente. La RM è superiore nella valutazione dei rapporti dellaneoplasia con il midollo spinale. La tomografia computerizzata consente lo studio di tutto il paziente in un’unica seduta (“to-talbody”) ed il prelievo mirato di tessuto neoplastico per esame citologico o istopatologico.
Bibliografia
Matus Re., Leifer Ce., Macewen Eg. et al.: “Prognostic factors for multiple myeloma in the dog”, J Am Vet Med Med Assoc 1986; 188:1288-1291.Jergens Ae., Miles Kg., Moore Fm.: “Atypicall lytic proliferative skeletal lesions associated with plasma cell myeloma in a dog”, Vet Radiol Ultrasound 1990;
31:262-264.Sande Rd.: “Radiography, myelography, computed tomography and magnetic imaging of the spine”, Vet Clin North Am Small Anim Pract 1992; 22:811-831.Vignoli M., Ohlerth S., Rossi F. et al.: “Computed tomography-guided fine-needle aspiration and tissue-core biopsy of bone lesions in small animals”, Vet Ra-
diol Ultrasound 2004; 45(2):125-130.
Indirizzo per corrispondenza:Dott.ssa Simona Cancedda - Centro Oncologico Veterinario - Via San Lorenzo 1/4 - 40037 Sasso Marconi (BO), Italia Tel. 051/6751232 - Cell. 347/4919653 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
553
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
IMAGING IN UN CASO DI ECTOPIA TIROIDEA
E. Caleri, DVM1, F. Rossi, DVM, SRV, Dipl. ECVDI1, R. Terragni, DVM, SPCAA-Gastroenterologia1,B. Bacci, DVM, PhD2, E. Laddaga, DVM2, M. Vignoli, DVM, SRV, Dipl. ECVDI1
1 Clinica Veterinaria dell’Orologio, Sasso Marconi (BO), Italia2 D.V.L. Diagnostica Veterinaria di Laboratorio, Sasso Marconi (BO), Italia
Area di interesse: Diagnostica per immagini
Introduzione. Per tiroide ectopica si intende un’aberrazione embriologica caratterizzata dalla presenza di tessuto tiroideo in se-di diverse dalla normale localizzazione1,2. Tale anomalia è segnalata raramente nei piccoli animali, ed in particolare nei casi incui il tessuto tiroideo ectopico dà origine a lesioni occupanti spazio maligne (di solito carcinomi)3,4,5,6,7, o benigne3. Nel cane enel gatto la localizzazione più comune è il mediastino craniale6,7, mentre sporadici report riguardano masse di origine tiroideaalla base della lingua4,5. I pochi riferimenti bibliografici non riportano tuttavia dati specifici riferiti alle metodiche di imagingutilizzate. Nell’uomo, oltre alle sede mediastinica e cervicale, sono riportate anche ectopie tiroidee addominali (fegato, pancreas,surrene)1,8,9. Lo scopo di questo studio è quello di descrivere l’utilizzo di diverse metodiche di imaging come ausilio nella dia-gnosi di un carcinoma tiroideo ectopico nella regione laringea in un cane. Descrizione del caso. Un cane bassotto, maschio intero, di circa tre anni, in buone condizioni generali, era presentato per unamassa nella regione del collo, di consistenza dura non dolente. Gli esami ematici, compreso il profilo tiroideo, e l’esame radio-grafico del torace risultavano nella norma. Il cane è stato indagato mediante ecografia della regione cervicale, scintigrafia delcollo ed esame TC total body. All’esame ecografico la lesione si presentava di forma rotondeggiante lievemente irregolare, ipoe-cogena, disomogenea e fortemente vascolarizzata. Alla scintigrafia erano visibili due lobi tiroidei normali ed un’area di lievecaptazione nella regione laringea. La TC mostrava una massa di forma ovalare, di circa 4 cm di dimensioni, infiltrante l’ossoioide (basiiale) e l’epiglottide, con enhancement intenso e disomogeneo. Si visualizzavano chiaramente i due lobi tiroidei nor-mali, separati dalla lesione, e linfoadenopatia bilaterale dei linfonodi retrofaringei. Il torace e l’addome non mostravano lesioniriferibili a metastasi. La biopsia ed il successivo esame immunoistochimico consentivano di diagnosticare un carcinoma tubulo-papillare, con positività per il TTF-1, indicando un’origine tiroidea della lesione; pertanto la diagnosi finale era di carcinoma ti-roideo ectopico infiltrante la laringe. Le terapie successivamente proposte (intervento chirurgico associato a chemio- e/o radio-terapia) non sono state accettate dal proprietario. Il follow up radiografico ed ecografico ad un anno di distanza hanno eviden-ziato noduli polmonari multipli riferibili a metastasi, linfoadenopatia dei linfonodi sternali e lesioni focali spleniche e renali. Conclusioni. Questo è il primo report che tratta in modo specifico l’utilizzo di metodiche di diagnostica per immagini avanza-ta in un caso di carcinoma tiroideo ectopico nella regione laringea di un cane. Tra le varie metodiche utilizzate, la TC è risulta-ta la tecnica più utile per lo studio della lesione primaria e per la completa stadiazione del paziente. Tali informazioni sono ri-sultate fondamentali per il piano di trattamento del paziente.
Bibliografia
1. Arancibia P, Veliz J, et al. Lingual thyroid: report of three cases. (1998) Thyroid 8, 1055-1057.2. Batsakis JG, El-Naggar AK, et al. Thyroid gland ectopias. (1996) Annals of Otology, Rhinology, and Laryngology 105, 996-1000.3. Leav I, Shiller A, et al. Adenomas and carcinomas of the canine and feline thyroid. (1976) Journal of Pathology 83, 61-93. 4. Lantz GC, Salisbury SK. Surgical excision of ectopic thyroid carcinoma involving the base of the tongue in dogs: three cases (1980-1987). (1989) Jour-
nal of the American Veterinary Medical Association 195(11), 1606-1608.5. Patnaik AK, Peterson ME, et al. Ectopic lingual thyroid tissue in a cat. (2000) Journal of Feline Medicine and Surgery 2, 143-146.6. Costantino-Casas P, Rodriguez-Martinez HA, et al. A case report and review: the gross, histological and immunohistochemical characteristics of a carci-
noma of ectopic thyroid in a dog. (1996) British Veterinary Journal 152, 669-672.7. Sthephens LC, Saunders WJ, et al. Ectopic thyroid carcinoma with metastases in a beagle dog. (1982) Veterinary Pathology 19, 669-675.8. Karapolat S, Bulut I. Ectopic posterior mediastinal thyroid: a case report. (2008) Cases Journal 1(1), 53.9. Shiraishi T, Imai H, et al. Ectoipic thyroid in the adrenal gland. (1999) Human Pathology 30, 105-108.
Indirizzo per corrispondenza:Dott.ssa Elvanessa Caleri - Clinica Veterinaria dell’Orologio - Via Gramsci 1/4 - 40037 Sasso Marconi (BO), Italia Tel. 051/6751232 - Cell. 328/8668645 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
554
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
CISTITE CRONICA DA TRICHOSPORON ASAHII IN UN GATTO
B. Carobbi, Med Vet, MRCVS1, P. Danesi, Med Vet2
1 Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova, Padova, Italia2 Istituto Zooprofilattico delle Venezie, Padova, Italia
Area di interesse: Medicina felina
Introduzione. Il presente lavoro descrive la prima segnalazione di Trichosporon asahii a localizzazione vescicale in un gatto ela terapia effettuata. In medicina umana le infezioni da lieviti del genere Trichosporon rappresentano una patologia emergente in pazienti neutrope-nici, ed in particolare in soggetti trattati con terapie citotossiche e immunosoppressive per neoplasie ematologiche. I lieviti delgenere Trichosporon non sono considerati agenti patogeni primari perché sono normalmente presenti nell’ambiente e costitui-scono una componente minore della normale flora cutanea e mucosale dell’uomo e degli animali.Le infezioni da Trichosporon nel gatto sono caratterizzate da infezioni miste suppurative e granulomatose della mucosa o dellasottomucosa e del sottocute. In letteratura sono stati descritti soltanto 4 casi di infezioni da Trichosporon, in nessuno dei pazientiaffetti è stata evidenziata la presenza di immunosoppressione e in nessuno l’agente patologico era della specie T. asahii. Descrizione del caso. Un gatto maschio castrato di 10 anni di età è stato riferito per una cistite cronica. All’anamnesi era pre-sente una storia di cistite cronica persistente da circa 3 mesi. Il gatto era risultato FIV e FeLV negativo. Il soggetto era stato ini-zialmente trattato con Enrofloxacina che aveva portato una remissione dei sintomi per circa 3 settimane. Alla ricomparsa dei sin-tomi erano stati evidenziati calcoli vescicali che erano stati trattati con rimozione chirurgica per via cistotomica e terapia anti-biotica con Ibafloxacina. I sintomi di cistite si erano nuovamente presentati 3 giorni dopo la sospensione dell’antibiotico. Nelcorso dei 3 mesi erano stati somministrati anche dei cortisonici senza ottenere un miglioramento clinico. La sintomatologia erasempre ricomparsa invariata con presenza di ematuria, difficoltà nell’urinazione, anoressia, depressione e dimagramento.All’esame clinico il paziente risultava depresso, presentava dolorabilità alla palpazione addominale, mentre temperatura, polsoe respiro era nei limiti di normalità. All’esame ematobiochimico non erano presenti alterazioni significative. All’esame radiolo-gico dell’addome la vescica appariva di volume normale. All’ecografia addominale la parete della vescica risultava ispessita(4mm) ed irregolare. Un campione di urina prelevato per cistocentesi è stato inviato al laboratorio. All’esame del sedimento so-no state evidenziati eritrociti e tracce di cristalli, l’esame biochimico ha evidenziato la presenza di proteine e leucociti, l’esamebatteriologico non ha evidenziato la crescita di nessun agente patogeno di origine batterica, mentre l’esame micologico ha por-tato all’isolamento di Trichosporon asahii. Il gatto è stato sottoposto a terapia con Itraconazolo. La terapia ha portato alla com-pleta remissione dei sintomi e l’esame micologico delle urine ripetuto a circa 2 mesi dalla fine della terapia non ha portato allacrescita di nessuna colonia fungina. Conclusioni. Il presente lavoro descrive la prima segnalazione di T. asahii a localizzazione vescicale in un gatto con cistite cro-nica e la terapia effettuata. Infezioni primarie da T. asahii nel gatto non sono mai state riportate prima, sono invece state descritte infezioni opportunisticheda Trichosporon spp sia nell’uomo che negli animali, in particolare di soggetti immunodepressi. Nel caso descritto la cistite cro-nica da calcoli vescicali potrebbe aver contribuito all’insorgenza dell’infezione, tuttavia il lievito è stato isolato in purezza. Inol-tre il gatto non presentava deficit di immunocompetenza ed era FIV e FeLV negativo.Nel caso descritto la terapia con Itraconazolo è risultata efficace con completa guarigione della cistite, sia dal punto di vista cli-nico che dal punto di vista micologico con assenza del lievito all’esame micologico di controllo effettuato 2 mesi dopo la finedel trattamento.La cistite di origine fungina dovrebbe essere considerata nelle diagnosi differenziali delle cistiti croniche del gatto. L’esame mi-cologico dell’urina dovrebbe essere inserito nell’iter diagnostico dei gatti con cistite cronica resistente alla terapia antibiotica,specialmente nei soggetti immunodepressi, in associazione all’esame batteriologico.
Bibliografia
Sakamoto Y, Kano R, Nakamura Y, Wtanabe H, Fukuda Y, Hasagawa A (2001) Mycoses 44, 518-520.Chowdhary A, Ahmad S, Khan ZU, Doval DC, Randhawa HS (2004) Indian Journal of Medical Microbiology 22, 16-22.Greene CE, Miller DM, Blue JL (1985) J Am Vet Med Assoc 187, 946-948.Doster AR, Erickson ED, Chandler FW (1987) J Am Vet Med Assoc 190,1184-1186.
Indirizzo per corrispondenza:Dott.ssa Barbara Carobbi - Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie - Via dell’Università 16 - 35028 Legnaro (PD), Italia Tel. 049 8272 609 - Cell. 348 55 71 854 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
555
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
IL CONTROLLO PRECOVA: COME STRUMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI RIPRODUTTIVI NELL’ALLEVAMENTO DEL CANARINO
S. Catania, Med Vet, PhD1, D. Bilato, Med Vet1, M. Capitanio, Med Vet2, M. Barina, Med Vet3,A. Sturaro, Lab Tech Bio1, L. Iob, Med Vet1
1 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Padova, Italy2 Libero Professionista, Vicenza, Italy3 Libero Professionista, Padova, Iatly
Area di interesse: Animali esotici
Scopo del lavoro. Il presente lavoro si propone di valutare i fattori che possono condizionare la stagione riproduttiva in alleva-menti di canarino, cercando di proporre un approccio diagnostico e terapeutico volto al miglioramento delle condizioni sanita-rie dei riproduttori al fine di migliorare la produttività dell’aviario. Il protocollo proposto, eseguito il mese precedente la for-mazione delle coppie, si è basato su visita clinica in allevamento, esame batteriologico e parassitologico su deiezioni. La cono-scenza dei diversi parametri di allevamento, congiuntamente ai risultati della visita clinica ed ai risultati di laboratorio, ha per-messo, attraverso una metodica valutativa ed interpretativa degli stessi, di formulare una diagnosi sullo stato generale dell’alle-vamento. In seguito a tali considerazioni sono stati intrapresi interventi gestionali e terapeutici al fine di migliorare le perfor-mance riproduttive. Sulla base del confronto dei risultati riproduttivi tra allevamenti campione e allevamenti controllo ci siamoproposti di valutare il valore predittivo del controllo precova. Materiali e metodi. Sono stati selezionati 8 allevamenti di canarino. Gli aviari sono stati suddivisi in modalità del tutto casua-le in un gruppo “campione”, in cui veniva applicato completamente il protocollo da valutare, e in un gruppo “controllo” in cuisi valutava lo stato sanitario senza attuare i trattamenti migliorativi consigliati dal protocollo. Gli allevamenti sono stati sotto-posti 30-40 giorni prima della data di formazione delle coppie a visita clinica e raccolta dati anamnestici, tramite utilizzo di ap-posita scheda dati. A tutti gli allevatori, è stato chiesto di non introdurre nuovi soggetti e di non partecipare a manifestazioni or-nitologiche durante lo studio, ed inoltre di compilare durante la stagione riproduttiva una scheda relativa ai parametri di alleva-mento. Per l’esame batteriologico, il prelievo delle deiezioni è stato eseguito come descritto da Bilato et al., 2007. La terapiafarmacologica veniva formulata secondo un protocollo standardizzato, considerando anche le patologie riscontrate nei mesi pre-cedenti il periodo precova. In caso di riscontro di microrganismi considerati patogeni primari e di batteri Gram negativi (Esche-richia coli, Enterobacter spp.,) considerati indice di dismicrobismo1-3, veniva consigliata una terapia antibiotica, formulata sullabase dei risultati dell’antibiogramma. Nel caso venissero isolate più specie batteriche venivano somministrati, nell’ordine, unantimicotico, un acidificante nell’acqua di bevanda ed un antibiotico, dato che la presenza di più specie batteriche può esserecorrelata con micosi gastrica. Al terzo giorno ed al termine della terapia antibiotica venivano effettuate operazioni di disinfe-zione straordinaria delle gabbie e degli accessori. Nei casi di positività per coccidi, Atoxoplasma spp., o in seguito a rilievi cli-nici o anatomopatologici indicativi di tali patologie veniva consigliata la somministrazione di Toltrazuril. Risultati. Attraverso la raccolta e l’elaborazione dalle schede di produzione fornite agli allevatori abbiamo potuto accertarequanto segue: nel gruppo campione i parametri medi riscontrati sono stati fertilità 73.07%, schiudibilità 77.97%, rapporto trasvezzati e nati 89.61%, rapporto tra svezzati su uova deposte 50.57%, ed infine il numero di soggetti svezzati per coppia 3.90,contro i rispettivi del gruppo di controllo, 46.06%, 65.47%, 70.31%, 19.69%, 2.16. Conclusioni. Il metodo proposto in questo studio prevede la valutazione igienico-sanitaria degli allevamenti di canarini. Me-diante tale approccio è possibile pianificare, ove necessario, un intervento mirato, sia attraverso l’utilizzo di chemioterapici cheattraverso l’applicazione di accorgimenti gestionali di tipo migliorativo. I risultati confermano l’ipotesi di partenza, con la qua-le ci proponevamo di dimostrare l’efficacia del controllo precova attraverso la comparazione delle performance riproduttive trai vari allevamenti con stato sanitario di partenza conosciuto. I parametri riproduttivi del gruppo campione dimostrano che attra-verso il controllo precova è possibile impostare una adeguata e pianificata gestione dei riproduttori attraverso interventi farma-cologici e correzioni gestionali volte a migliorare lo stato sanitario dei riproduttori e di conseguenza la produttività dell’alleva-mento. In quest’ottica il controllo precova rappresenta, a nostro parere, un valido strumento in possesso del Medico Veterinario,per ottenere dati oggettivi sullo stato sanitario dell’allevamento di canarini, permettendo il miglioramento delle performance ri-produttive.
Bibliografia
1. Bilato D., Sturaro A., Corso C., Muliari R., Catania S. (2008). Metodologia di valutazione microbiologica delle deiezioni di canarino. Atti del 59° Con-gresso Internazionale Multisala Scivac, Rimini, p. 377.
2. Dolphin R.E., Olsen D. E. (1977). Fecal monitoring of caged birds. Veterinary Medicine and small animal clinician, 72:1081-1085.3. Glünder G., Hinz K.H. (1979). Vorkommen und Bedeutung von Enterobakteriaceen bei Körnerfressern. Verhandlungsber. I. Tagung Krank. D. Vögel.
Munchen: 89-95.
Indirizzo per corrispondenza:Dott. Salvatore Catania - Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle Venezie Area Diagnostica Di Padova - Struttura Territoriale Complessa 3,Viale Dell’università, 10 - 35020 Legnaro (PD), Italia - Tel. 0498084288 - Cell. 3206235205 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
556
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
EUTANASIA: ALCUNE CONSIDERAZIONI BIOETICHE APPLICATE ALLA CLINICA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE
P. Coluccio, Medico Veterinario1, A. Passantino, PhD, Prof.2, A. Giammanco, Dott.3, M. Magistro Contenta, Psichiatra4
1 Dottorato di Ricerca in “Normative dei Paesi della UE relative al benessere e protezione animale”,Università degli Studi di Messina, Messina, Italia
2 Dipartimento di Sanità Pubblica veterinaria, Facoltà di Medicina Veterinaria,Università degli Studi di Messina, Messina, Italia
3 Dottorato di Ricerca in “Normative dei Paesi della UE relative al benessere e protezione animale”,Università degli Studi di Messina, Messina, Italia
4 Dottorato di Ricerca presso UO di Psichiatria, Policlinico di Messina, Facoltà di Medicina e Chirurgia,Università degli Studi di Messina, Libero professionista Messina, Messina, Italia
Area di interesse: Medicina comportamentale
Scopo del lavoro. La consapevolezza che gli animali sono considerati esseri senzienti (Trattato di Lisbona, 3 dicembre 2007),capaci di provare dolore e sofferenza e, soprattutto, che hanno una sempre più rilevanza sociale, ha portato molti ricercatori adindagare sulla loro sensibilità e capacità di intrecciare rapporti affettivi con le persone con cui interagiscono. Siffatti studi han-no comprovato l’esistenza dell’interscambio emotivo che si istaura fra proprietario e cane/gatto. È intuibile, pertanto, come ilmutato atteggiamento nei confronti dell’animale da compagnia, anche relativamente alla soppressione eutanasica, implichi con-siderazioni di carattere non solo giuridico ed etico ma anche psicologico. Basti pensare come sia devastante e profonda la feri-ta psicologica per la perdita del proprio animale; di fronte a tale perdita, il proprietario potrebbe essere assalito da uno stato de-pressivo particolare, la cui importanza è proporzionale al tipo di rapporto che si era instaurato col proprio pet. La suddetta rela-zione potrebbe essere influenzata da varie dinamiche, quali, ad es., durata del rapporto, intensità dello stesso, contesto sociale(Cfr., Linee Guida AVMA sull’eutanasia, giugno 2007). Scopo della presente nota è quella di fornire agli operatori del settoreun supporto operativo, in termini di informazione ed aggiornamento, per operare durante la pratica eutanasica nel rispetto delbenessere emotivo del proprietario oltre che del benessere animale come criterio imprescindibile. Materiali e metodi. A tal uopo verrà effettuata un’indagine conoscitiva riguardante le reazioni emozionali dei proprietari di fronte atale evento subito o scelto in base a varie motivazioni (grave malattia o incurabilità, impossibilità di gestione per aggressività o al-tro), attraverso la compilazione di un questionario da sottoporre ai medici veterinari, nonché agli stessi proprietari di pets. L’atten-zione verrà, quindi, rivolta allo studio del rapporto che si instaura tra il medico veterinario e il cliente (partner umano del pet), te-nendo conto delle transazioni che avvengono tra le molteplici componenti dell’individuo umano e dell’ambiente in cui vive, al finedi evidenziare come fattori di natura socio-ambientale possano influenzare o meno la pratica eutanasica. La ricerca, in tal senso, ri-chiede l’apporto sinergico di approcci multidisciplinari che vanno dalla psicologia sociale e dalla sociologia alla psicologia. Risultati. Gli autori hanno visto come la reazione emozionale dei proprietari sia stata sempre molto intensa, quantunque la mo-tivazione che aveva spinto verso la soppressione eutanasica fosse molto diversa. Dai dati ci si è accorti come in genere i medi-ci veterinari siano ancora per la maggior parte poco attenti alla sfera psico-affettiva del proprietario e come invece si dedichinomaggiormente a spiegare la tecnica dell'eutanasia e le possibili complicazioni. Conclusioni. È necessario rilevare come, nel quadro di un’etica della responsabilità per l’ambiente e per gli altri esseri viventi,l’uomo non è da considerarsi il proprietario della biosfera, ma un amministratore della natura a cui spetta una gestione respon-sabile - rispettosa delle diverse esigenze - in vista del raggiungimento di un miglioramento comune. Considerato, inoltre, che,non esistendo leggi che disciplinano l’abbattimento eutanasico di un animale di proprietà, possono essere commesse delle aber-razioni, quale ad esempio la richiesta di eutanasia su un animale sano, sarebbe auspicabile la compilazione di linee guida. Di-fatti, a parere degli Autori, la creazione di linee guida su questa pratica eviterebbe, o per lo meno ridurrebbe, la scelta di deci-sioni spesso impulsive o non ben ponderate.
Bibliografia1. Linee guida AVMA sull'eutanasia Giugno 2007.2. Andrews EJ, Bennet BT, Clark JD, et al. 1993 Report on the AVMA panel on euthanasia. J Am Vet Med Assoc 1993; 202: 230–247.3. L’eutanasia negli animali da compagnia. Le procedure per una decisione clinica informata e responsabile (il consenso informato nell’eutanasia), P.Santo-
ri, Sisca Observer, Anno 7, num1 pgg21-22, Giugno 2003.4. L’eutanasia: ultimo atto terapeutico del medico veterinario per il benessere animale, F.Fassola, Sisca Observer, Anno 8, num1,pgg 7-8, Marzo 2004.5. Dalla parte dle proprietario: il cordoglio e il lutto per la morte del proprio animale, B.Alessio, Sisca Observer, Anno 8, num 1, pagg 9-11, Marzo 2004.6. La legislazione in materia di eutanasia, Giorgio Neri, Sisca Observer, Anno 8, Numero 1, pagg 21-22,Marzo 2004.7. Death of a Companion Cat or Dog and Human Bereavement: Psychosocial Variables, Lynn A. Planchon, Donald I. Templer, Shelley Stokes, and Jacque-
line Keller, Society & Animals Journal of Human-Animal Studies, Volume 10, Number 1, 2002.8. Development of the pet bereavement questionnaire, Hunt, M.; Padilla, Y, Anthrozoos. 2006. 19: 4, 308-324.9. Euthanasia- Gentle death, Painful decision, 2000 Sarah Hartwell.
10. Grief resulting from euthanasia and natural death of companion animals,McCutcheon, K. A., & Fleming, S. J., 2001/2002, anthrozoology.org.11. Influence of various early human-foal interferences on subsequent human-foal relationship., Henry, S.; Richard-Yris, M. A.; Hausberger, M.; Develop-
mental Psychobiology. 2006. 48: 8, 712-718.12. Griving pet death: normative, gender and attachment issues, T. A. Wrobel, A. L. Dye, OMEGA: The Journal of Death and Dying. Volume 47, Number
4/2003.
Indirizzo per corrispondenza:Dott. Paolo Coluccio - Via Cappelleri 136/A - 89047 Roccella Jonica (RC), Italia - Tel. 347/0110110 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
557
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
GENOTYPIC DIFFERENTIATION OF BACTERIAL STRAINS ISOLATES FROM ORAL CAVITY FROM DOGS WITH PERIODONTAL DISEASE BY RAPD
(RANDOM AMPLIFICATION OF POLYMORPHIC DNA)
L. Costinar, DVM, PhD1, V. Popa, DVM, PhD2, C. M. Pascu, DVM, PhD1
1 Faculty of Veterinary Medicine, Dept. of Infectious Diseases, Timisoara, Romania2 Pasteur Institute, Dept. of Molecular Biology, Bucuresti, Romania
Topic: Dentistry
Purpose of the work. RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) is a technique for rapidly detecting genomic poly-morphism, utilizing a single short oligonucleotide primer of arbitrary sequence in a polymerase chain reaction (PCR). RAPDanalysis has been used in numerous application including detection of strain diversity, gene maping, epidemiology, populationanalysis and the demonstration of phylogenetic and taxonomic relationships (1, 3, 4). RAPD analysis it enables the quick de-tection of polymorphism at a number of different loci using only nanogram quantites of genomic DNA.The amount of genomicDNA in a RAPD reaction can vary from as little as 1 ng to as much as 100 ng (1, 2). The aim of this paper was to evidentiategenomic diversity of the Gram positive and Gram negative bacteria isolates from dog’s periodontal disease. Materials and used methods. Bacterial strainsA total of 19 strains isolates, identificated at Institute Pasteur Bucharest, between May 2006 and June 2006, was evaluated. Bac-teria were obtained from dogs with periodontitis and gingivitis. There are the isolates analysed in this study. The strains were identified by biochemical tests: API 20 E, API 20 NE, API 20Staph, API 20 Strep (bio Merieux, France).
Strains isolated from oral cavity of the dogs with periodontal disease analysed by RAPD
Strains Gram negative Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Burkolderia ceppacia Moraxella canis Morganella spp.1 Morganella spp. 2 Providencia spp. Bergeyella zoohelcum Alcaligenes spp.
Strains Gram positiveStaphylococcus simulansStaphylococcus sciuriStaphylococcus lentusMicrococcus luteusAerococcus viridans 1Aerococcus viridans 2Gardnerella vaginalis 1Gardnerella vaginalis 2Streptococus uberisLeuconostoc spp.
DNA isolationThe bacterial DNA was isolated by the use of the previously described method (Germani 1995).
RAPD fingerprintingIn order to study the genic distance or similarities among the bacterial isolates, the RAPD fingerprinting was performed by us-ing the commercial kit “Ready To Go RAPD Analysis Beads” (Amersham Biosciences).RAPD was done in a total reaction volume of 25 µl. The amplification was performed by Gene Amp PCR System 9600, PerkinElmer, and the cycle profile used was as following:- 1 cycle 94°, 5’; - 44 cycles: 94° 40’’, 35° 1’, 72° 2’, 60-35° 50’’, 35-72° 130’’;- 1 cycle 72°, 10’.6 hours and half were necessary for amplification.
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
558
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
The amplified products were analyzed by gel-electrophoreses in 1,5% agarose with TBE 1X buffer. The gels were run at 120V,60 mA for 1,5 h and stained with ethidium bromide 2 µg/ml (Sigma). PCR marker (Sigma, 50-2000 pb) was used as DNA stan-dard. The visualization of the PCR products and the image acquisition were performed by the use of Herolab Easy RH and Im-age 2 WinPC. Un Scan IT software (Gel Software v.5.1.1998, Silk Sci. Co) was used to determine the size of the amplicons andTreecon software (Treecon for Windows v.1.3b. 1997) was used for the statistic analyses and to construct the dendrograms (3). Outcomes. The molecular screening by RAPD done with primer 1 in nine Gram negative isolates from dogs demonstrates thegenetic differences. The same result was recorded in the Gram positive isolates.The results are presented in figure 1 and figure 2. It could be observed that the Gram positive isolates from dogs with gingivi-tis and periodontitis presents more genotypes. The strains from Aerococcus spp. present the lower degree of dissimilarity. Thisdemonstrates once again that the oral microflora from dogs are genetically very complex and dynamic. Conclusions. In our study it was observed a great genetically diversity of the bacterial strains isolated from dogs gingivitis andperiodontitis.RAPD analysis is a technique for rapid detection of the genomic polymorphism and is used in molecular epidemiology. It wasnoticed also the primer 1 induced different profiles in all strains belonging to the bacterial genus studied.
Bibliography
1. Goncalves, R.B., Vaisanen, M.L., Van Steenbergen, T.J., Sundqvist, G., Mouton, C. (1999), Genetic relateness between oral an intestinal isolates of Por-phyromonas endodontalis by analysis of Random Amplified Polymorphic DNA, Res. Microbiol. Jan. Feb. 150(1), 61-68.
2. Gillespie, B.E., Jayaro, B.M., Oliver, S.P. (1997), Identification of Streptococcus species by Random Amplified Polymorphic DNA fingerprinting, J. DairySci.
3. Popa, Virgilia, Vanghele, Monica, Pascu, A., Anghel, F., Danes, M., Danes, Doina, Gruia, M., Botus, Daniela (2004), RAPD-instrument în subtipizareamoleculara a microorganismelor patogene, Volumul Subprogramului Relansin-Centre de Excelenta, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Universitatea Po-litehnica Bucuresti.
4. Truong, T.L., Menard, C., Mouton, C., Trahan, L. (2000), Identification of mutans and other oral streptococci by Random Amplified Polymorphic DNAanalysis.
Corresponding Address:Dr. Luminita Costinar - Faculty of Veterinary Medicine, Infectious Diseases Department, Calea Aradului 119, Timisoara/Timis/300645,Romania - Mobile: 40723279123 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
559
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
PLASMID PROFILE OF SOME GRAM POSITIVE STRAINS ISOLATES FROM DOG’S ORAL CAVITY
L. Costinar, DVM, PhD1, C.M. Pascu, DVM, PhD1, V. Herman, DVM, PhD1
1 Faculty of Veterinary Medicine, Dept. of Infectious Diseases, Timisoara, Romania
Topic: Dentistry
Purpose of the work. Some virulence factors can be mediated by extrachromosomal DNA elements carrying genes able to syn-thesis substances destroying host tissues. In this study, the plasmid profile of some Gram positive strains isolates from dog’s oralcavity were evaluated. Plasmids were classified into two groups according to size. Staphylococci and streptococci are Gram pos-itive bacteria, aerobe, facultative anaerobe, non-sporeforming, usually immobile and are indigenous of dog oral cavity. Theseorganisms are commonly recovered from different skin, upper respiratory and lower urogenital system infections in humans an-imals both2, 3. Some virulence factors can be mediated by extrachromosomal DNA elements carrying genes able to synthesis sub-stances destroying host tissues. The presence of plasmids in genus Staphylococcus and Streptococcus has been reporter in lit-erature. It is known that genus Micrococcus strains carrying plasmids. The aim of these researches was to evaluated the plas-mid profile of some Gram positive strains isolates from dog’s oral cavity. Materials and used methods1. Bacterial isolating and identification. There are study the next bacterial strains: one strain from Staphylococcus simulans,Staphylococcus sciuri, Staphylococcus lentus, Micrococcus luteus, Streptococcus uberis, Gardnerella vaginalis each one, and twostrains from Aerococcus viridans. From healthy dogs were isolated strains of Staphylococcus simulans, Staphylococcus sciuri,Streptococcus uberis and Aerococcus viridans. Staphylococcus lentus, Micrococcus luteus and Gardnerella vaginalis were isolat-ed from dogs with periodontal disease. Identification of the bacteria was performed with API 20 Strep (bio Merieux, France) andAPI 20 Staph (bio Merieux, France). After identification the strains were stored in BHI broth and glycerol 40%, at - 40°C.2. Plasmids DNA extraction. Plasmid DNA extraction was performed using a Takahashi and Nagano method, modified by usingDNA Minipreps Wizard Plus kit (Promega). This technique evidentiate plasmids with size between 2 and 190 kb. The bacterialwalls were lyses by adding of a lizozim solution. Plasmid DNA was analyzed by electrophoresis in 0,8% agarose gel the ethid-ium bromide 0,5 µg/ml was added. The electrophoresis was performed with Bioblock Consort E425 at 120V, 60 mA, one hour4,
5. Next E. coli strains were used as reference plasmids or DNA standards: R 112 (100 kb), RSa (35kb), V 517 (55 kb, 7,4 kb, 5,7kb, 5,2 kb, 4,0 kb, 3,1 kb, 2,8 kb, 2,2 kb), R 55 (165 kb), R 135 kb) INRA Tours France. There were used Herolab Easy RH andImage 2PC software. Outcomes. The strains were classified in two categories: strains harboring plasmids and strains neharboring plasmids. Strains(Staphylococcus lentus, Micrococcus luteus, Gardnerella vaginalis) harboring plasmids were recovered from dog with 3-rdstage of periodontal disease. Strains isolated from healthy dogs: Staphylococcus simulans, Staphylococcus sciuri, Streptococ-cus uberis and Aerococcus viridans not presented DNA plasmid. It could be observed that 3 (37,5%) out of 8 studied strains pre-sented DNA plasmid bands. Plasmid are not detected in 62,5% (5 strains). The plasmid molecular weight were between 4,64 kband 14,11 kb. This weight was characteristically from small size plasmids. It is known that high size plasmids are presents invirulent strains. We believe that aerobe Gram positive bacteria have a minor role in periodontal disease in dog. Anaerobe Gram negative bacteria Porphyromonas spp., Prevotella spp., Fusobacterium spp. and Bacteroides fragilis group arevery important role in gingivitis and periodontitis dog1. Conclusions. Our results indicate the need of a better plasmid characterization of the oral cavity bacteria strains and deter-mining the role of these elements could play in periodontal disease. Plasmids were observed in 3 out of 8 strains. This result in-dicates that in periodontal pockets ecosystem it could be present strains high weight plasmids (100 kb) responsible for the le-sions from periodontal disease. We considers that is necessary an extensive study about plasmid profile and the role of theseplasmids from the mostly indigenous oral flora from dogs and others species.
Bibliography
1. Forsblom, B., Sarkiala-Kessel, E., Kanervo, A., Väisänen, M.L., Helander, I.M. (2002), Characterization of aerobic gram-negative bacteria from subgin-gival sites of dogs-potential bite wound pathogens, J. Med. Microbiol., 51, 207-220.
2. Germani, Y. (1997), Methodes de laboratorie, Pouvoir enteropathogene des bacteries, I. Pasteur, France.3. Guardabassi, L, Schwarz, S., Lloyd, D. H. (2004), Pet animals as reservoirs of antimicrobial-resistant bacteria, J. of Antimicrobiol. Chemo. 54, 2, 321-332.4. Guardabassi, L, Schwarz, S., Lloyd, D. H. (2004), Pet animals as reservoirs of antimicrobial-resistant bacteria, J. of Antimicrobiol. Chemo. 54, 2, 321-332.5. Paula, M.O., Jardim-Gaetti, E., Campos-Avila, M.J. (2003), Plasmid profile in oral Fusobacterium nucleatum from humans and Cebus apella monkeys,
Rev. Inst. Med. Trop. S. Paulo, 45, 1, 5-9.
Corresponding Address:Dr. Luminita Costinar - Faculty of Veterinary Medicine, Infectious Diseases Department, Calea Aradului 119,Timisoara/Timis/300645, Romania - Mobile: 40723279123 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
560
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
LA CONCENTRAZIONE SIERICA DI LATTICODEIDROGENASI PREDICE RECIDIVA IN CANI CON LINFOMA
L. Marconato, DVM, DECVIM-CA (Oncology)1, G. Crispino, DVM1, R. Finotello, DVM1,S. Mazzotti, DVM1, E. Zini, DVM, PhD, DECVIM2
1 Clinica Veterinaria L’Arca, Napoli, Italia2 Clinic for Small Animal Internal Medicine, Vetsuisse Faculty, University of Zurich, Zurigo, Svizzera
Area di interesse: Oncologia
Scopo del lavoro. La latticodeidrogenasi (LDH), enzima tetramerico che converte lattato in piruvato, è sintetizzato in vari di-stretti dell’organismo, e la sua concentrazione sierica può aumentare in corso di alcune patologie, tra cui tumori. In medicina umana, LDH aumenta in caso di linfoma (LSA) non Hodgkin (NH), leucemia linfoblastica acuta, leucemia mieloi-de cronica, mieloma multiplo ed altre neoplasie. In particolare, in pazienti con LSA NH e livelli sierici elevati di LDH si isti-tuisce chemioterapia intratecale profilattica per prevenire recidive nel SNC.1 LDH è quindi considerato importante parametro didiagnosi, stadiazione e gestione di pazienti con LSA NH.2 Nel LSA del cane, invece, non è ancora stato chiarito il ruolo di LDH.Appare ovvio che il precoce riconoscimento di recidiva in cani ancora in remissione completa (CR) potrebbe permettere di isti-tuire tempestivamente protocolli rescue. Scopo del lavoro è di valutare se elevati livelli sierici di LDH predicano, alla diagnosi,intervallo libero da malattia (DFI) e sopravvivenza più brevi e, dopo chemioterapia, precoce recidiva in cani asintomatici. Materiali e metodi. Cani con LSA high-grade non precedentemente trattati erano inclusi in senso prospettico. Dopo stadiazio-ne completa (citologia linfonodale, CBC, ematochimica inclusa LDH totale, ecografia addominale, citologia di milza, fegato emidollo osseo, radiografie del torace, immunofenotipizzazione (IF) su linfonodo, sangue periferico e midollare), i cani veniva-no trattati con protocollo chemioterapico VCAA (con aggiunta di citosina arabinoside in caso di coinvolgimento midollare).LDH era poi dosata al termine di chemioterapia, dopo 1, 3 e 6 mesi dal suo completamento. Per ogni cane si valutavano risposta al trattamento, tempo alla recidiva, sopravvivenza e causa di morte. Per valutare se LDHanticipa la recidiva in cani in remissione clinica, la proporzione di cani in CR con elevati livelli di LDH (>280 U/L) a fine trat-tamento, ad 1, 3 e 6 mesi dopo, era confrontata con cani che sviluppavano o meno recidiva entro i successivi 45 giorni. Risultati. Si includevano 55 cani con LSA. Di questi, 4 erano in stadio III, 28 in stadio IV e 23 in stadio V (di cui 13 avevanocoinvolgimento midollare) secondo WHO. 35 cani avevano IF B, 20 IF T. 50 cani erano sottoposti a chemioterapia; di questi,41 ottenevano CR. 29 cani recidivavano entro un periodo mediano di 87 giorni (range, 8-420), mentre 12 restavano in CR.Alla fine dello studio, 40 di 55 cani erano morti (35 per LSA, 5 per cause non correlate), con sopravvivenza mediana di 286giorni (range, 1-1945). Alla diagnosi, il livello mediano di LDH nei 55 cani era di 423 U/L (range, 86-3325). 12 cani avevanoLDH normale, e 43 LDH elevata. I livelli di LDH alla diagnosi non correlavano né con DFI né con sopravvivenza.Al termine di VCAA, 41 cani ottenevano CR: 9 recidivavano entro 45 giorni, e 3 (33.3%) di questi mostravano livelli elevati diLDH (>280 U/L). Nessuno (0%) dei restanti 32 casi che non recidivava entro 45 giorni mostrava LDH elevata. La proporzionedi cani in CR con LDH elevata che recidivava entro 45 giorni era significativamente più alta rispetto ai cani che restavano in CR(P=0.007). Dopo 1 mese dal termine di VCAA, 35 cani erano in CR. Tra loro, 9 recidivavano entro 45 giorni. Di questi, 7(77.8%) mostravano LDH elevata 1 mese dopo termine di chemioterapia. Soltanto 1 (3.8%) dei rimanenti 26 cani ancora in CRdopo 45 giorni aveva LDH elevata 1 mese dopo VCAA. La proporzione di cani in CR con LDH elevata che recidivava entro 45giorni dopo 1 mese dal termine di VCAA era significativamente più alta di cani che restavano in CR (P<0.0001). Dopo 3 mesi dal termine di chemioterapia, 22 cani erano in CR. La proporzione di cani con LDH elevata non era significativa-mente diversa tra quelli che sviluppavano o meno recidiva entro 45 giorni. Dopo 6 mesi dal termine di chemioterapia, 7 cani era-no in CR e nessuno recidivava entro 45 giorni. Conclusioni. Nei pazienti umani con LSA NH, livelli elevati di LDH alla diagnosi correlano con breve DFI e sopravvivenza.2Tale risultato non era confermato in questo studio. Tuttavia, si dimostrava che LDH è parametro dinamico e prognostico nel fol-low-up di cani con LSA, consentendo di anticipare precoce recidiva. Infatti, cani con LDH elevata al termine di chemioterapiae un mese dopo, recidivavano entro 45 giorni. Il monitoraggio seriale di LDH consente quindi di identificare una popolazione arischio di precoce recidiva. Al momento, istituire protocolli rescue in cani in remissione clinica ma con LDH elevata appare an-cora rischioso. Alla luce dei risultati suggeriamo invece di ristadiare questa popolazione di cani, eventualmente valutando ma-lattia minima residua, e di monitorarla a brevi intervalli. Concludendo, la valutazione seriale di LDH al termine di chemiotera-pia ed un mese dopo appare metodica non invasiva utile ai fini prognostici.
Bibliografia
1. Tomita N, Kodama F, Sakai R, et al. Predictive factors for central nervous system involvement in non-Hodgkin’s lymphoma: significance of very high se-rum LDH concentrations. Leuk Lymphoma. 2000; 38: 335-43.
2. Dumontet C, Drai J, Bienvenu J, et al. Profiles and prognostic values of LDH isoenzymes in patients with non-Hodgkin’s lymphoma. Leukemia. 1999;13: 811-17.
Indirizzo per corrispondenza:Dott.ssa Laura Marconato - Animal Oncology and Imaging Center, Rothusstrasse 2, CH-6331 Hünenberg, Svizzera Tel. +41 (0)41 783 07 77 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
561
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
ISOLAMENTO DI STAPHYLOCOCCUS INTERMEDIUS DALLE CAVITÀ NASALI DEL PERSONALE DI UNA CLINICA VETERINARIA PER ANIMALI DA COMPAGNIA
M. De Lucia, Medico Veterinario1, A. Giordano, Biologa2, M. Caldin, Medico Veterinario, ECVP1,T. Furlanello, Medico Veterinario, ECVCP2, A. Fondati, Medico Veterinario, ECVD, PhD3
1 Clinica Veterinaria San Marco, Padova, Italia2 Laboratorio di Analisi Veterinarie San Marco, Padova, Italia
3 Centro Veterinario Prati, Roma, Italia
Area di interesse: Medicina interna
Scopo del lavoro. È stato riportato che la frequenza di isolamento di Staphylococcus intermedius dalle cavità nasali umane èpressoché pari a zero (0.0006%). Tuttavia, recentemente è stato proposto che il contatto con animali da compagnia, in parti-colare con cani, in cui S. intermedius risiede nel cavo orale e nelle giunzioni muco-cutanee, possa rappresentare un fattore diesposizione al rischio di colonizzazione, da parte di S. intermedius, delle mucose esterne umane. Lo scopo di questo lavoro èvalutare la frequenza di isolamento di S. intermedius dalle cavità nasali del personale di una clinica veterinaria per animali dacompagnia. Materiali e metodi. Ventisei soggetti operanti in una clinica veterinaria per animali da compagnia (Padova, Italia) sono statiinclusi nello studio. Da ciascun soggetto sono stati ottenuti i dati anagrafici ed informazioni relative alle mansioni svolte nel-la clinica, la durata del rapporto di lavoro, il contatto extra-lavorativo con animali domestici/selvatici e le terapie con antibio-tici eseguite nei 6 mesi precedenti lo studio. Nell’arco di 24 ore è stato raccolto da ogni individuo un campione per esame bat-teriologico con la seguente procedura: un tampone sterile, inumidito con soluzione fisiologica, è stato introdotto in entrambele cavità nasali e sfregato per tre secondi sul setto nasale. I campioni sono stati immediatamente seminati su piastre contenen-ti salt agar mannitolo e l’identificazione di specie è stata eseguita attraverso il sistema automatizzato API ID32-STAPH (bio-Mérieux; Marcy l’Etoile, France). In caso di isolamento di S. intermedius, l’esame è stato ripetuto dopo 4 settimane seguendola stessa procedura.Risultati. Sono stati inclusi nello studio 19 donne (età media 34 anni) e 7 uomini (età media 39 anni). Ventiquattro/26 soggettierano medici veterinari (20 occupati nell’attività clinica e 4 in laboratorio) e 2 erano impiegati in attività amministrative. La du-rata media del rapporto di lavoro con la clinica era 6 anni (6 mesi-20 anni). Ventuno/26 soggetti vivevano in contatto con ani-mali da compagnia, 6/26 erano frequentemente in contatto extra-lavorativo con animali esotici/selvatici, 1/26 non aveva alcuncontatto con animali. Nei 6 mesi precedenti lo studio, 8/26 soggetti erano stati trattati con antibiotici beta-lattamici e 1/26 consulfamidici potenziati. S. intermedius è stato isolato dalle cavità nasali di 2 medici veterinari impegnati in attività clinica da cir-ca 1 anno, che vivevano in contatto con animali da compagnia e che nei 6 mesi precedenti lo studio erano stati sottoposti a te-rapia con antibiotici beta-lattamici (n=1) e sulfamidici potenziati (n=1). L’esame, ripetuto a distanza di 4 settimane, è risultatonegativo per S. intermedius in entrambi i medici veterinari precedentemente risultati positivi. Conclusioni. Pur non essendo considerato normalmente agente zoonosico, S. intermedius può occasionalmente causare infe-zioni umane ed essere fonte potenziale di geni di resistenza. I risultati qui ottenuti concordano con i pochi dati precedente-mente pubblicati e confermano che S. intermedius può colonizzare transitoriamente le cavità nasali di individui che lavoranoe vivono con animali da compagnia. Tuttavia, ulteriori studi sono necessari per valutare se il contatto con animali da compa-gnia possa rappresentare un reale fattore di esposizione al rischio di colonizzazione persistente delle cavità nasali umane daparte di S. intermedius.
Bibliografia
Mahoudeau I, Delabranche X, Prevost G, Monteil H, Piemont Y. Frequency of Isolation of Staphylococcus intermedius from Humans. Journal of Clinical Mi-crobioly, Aug. 1997, 2153-2154.
Harvey RG, Marples RR, Noble WC. Nasal carriage of Staphylococcus intermedius in humans in contact with dogs. Microbial Ecology in Health and Disease1994, 7:225.
Indirizzo per corrispondenza:Dott.Ssa Michela De Lucia - Clinica Veterinaria San Marco - Via Sorio 114 - 35141 Torreglia (PD), Italia Tel. 049/8561098 - Cell. 346/0252740 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
562
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
CORPI ESTRANEI VEGETALI MIGRANTI NEL CANE: RILIEVI ECOGRAFICI E RIMOZIONE ECOGUIDATA (7 CASI)
D. Della Santa, DMV, PhD, Dipl. ECVDI1
1 Ambulatorio Veterinario San Cristoforo, Firenze, Italia
Area di interesse: Diagnostica per immagini
Scopo del lavoro. Nel cane i corpi estranei vegetali migranti costituiscono una condizione patologica relativamente frequenteper la cui diagnosi e relativo trattamento sono spesso necessari mezzi diagnostici avanzati e interventi chirurgici invasivi. Obiet-tivo del presente lavoro è descrivere i rilievi ecografici riscontrati in cani con corpi estranei vegetali migranti e la tecnica di ri-mozione ecoguidata. Materiali e metodi. Sono stati descritti nello studio i rilievi ecografici e la tecnica di rimozione ecoguidata impiegata in 7 canicon corpi estranei vegetali migranti a localizzazione superficiale o sottolombare. Risultati. 9 corpi estranei vegetali migranti sono stati localizzati in 7 cani. In un soggetto sono stati evidenziati due corpi estra-nei; in un altro paziente è stato evidenziato un solo corpo estraneo, mentre ne erano in realtà presenti due. In 5 cani il corpoestraneo è stato localizzato in sede superficiale (regione cervicale: n=3, parete toracica: n=2) e in due a livello sottolombare. Igranulomi/ascessi localizzati a livello superficiale avevano un diametro compreso tra 2 e 17 cm; quelli a livello sottolombareerano entrambi di dimensioni di poco superiori alle dimensioni del corpo estraneo. In questi ultimi casi era tuttavia presente unascesso di maggiori dimensioni localizzato a livello sottocutaneo nella regione del fianco; in entrambi i casi le due cavità (su-perficale e sottolombare) erano connesse da un tragitto fistoloso che però è stato evidenziato ecograficamente solo in 1/2 casi.Nel secondo caso il tragitto è stato evidenziato durante la procedura di rimozione ecoguidata. Una fistola aperta all’esterno erapresente in 1/5 cani con localizzazione superficiale e 1/2 con localizzazione sottolombare del corpo estraneo. La rimozione ecoguidata è stata eseguita per tutti i corpi estranei evidenziati ecograficamente. La procedura prevede l’inseri-mento, sotto guida ecografica, di una pinza di Hartmann all’interno del granuloma/ascesso (qualora presente attraverso la fisto-la, oppure attraverso una nuova incisione cutanea di circa 3-4 mm) e quindi la rimozione, sempre sotto guida ecografica, delC.E. stesso. La procedura ha avuto successo in tutti i casi; solo in un caso in cui erano presenti due corpi estranei, ma ne è sta-to evidenziato ecograficamente solo uno, si è verificata una recidiva dopo circa due settimane dalla procedura. Al momento del-la diagnosi del secondo corpo estraneo, questo è stato rimosso. Conclusioni. L’esame ecografico è un utile ausilio diagnostico nei soggetti con sospetto corpo estraneo migrante in quanto puòconsentirne l’evidenziazione e localizzazione. In questi casi, il trattamento mediante rimozione mini-invasiva ecoguidata conpinza di Hartmann sembra essere un’alternativa efficace e sicura alla chirurgia tradizionale. L’esame ecografico dovrebbe esse-re eseguito quando l’ascesso ha le massime dimensioni e, se possibile, prima della sua rottura. Dal punto di vista tecnico è im-portante, qualora una fistola aperta all’esterno non sia presente, scegliere adeguatamente il sito dell’incisione cutanea. È altresìimportante, dopo la rimozione di un corpo estraneo vegetale, controllarne integrità e completezza e verificare che non ne sia pre-sente un secondo. Nei casi in cui il corpo estraneo non possa essere localizzato o rimosso con tale metodica, è indicato impie-gare dei mezzi diagnostici più avanzati quali la tomografia computerizzata o la risonanza magnetica per consentirne un’adeguatalocalizzazione.
Bibliografia
Armbrust LJ, Biller DS, Radlinsky MG, Hoskinson JJ. Ultrasonographic diagnosis of foreign bodies associated with chronic draining tracts and abscesses indogs. Vet Radiol Ultrasound 2003; 44:66-70.
Della Santa D., Rossi F., Carlucci F., e coll. Ultrasound-guided retrieval of plant awns. Vet Radiol Ultrasound 2008; 49:484-486.Gnudi G, Volta A, Bonazzi M e coll. Ultrasonographic features of grass awn migration in the dog. Vet Radiol Ultrasound 2005; 46:423-426.Staudte KL, Hopper BJ, Gibson NR, Read RA. Use of ultrasonography to facilitate surgical removal of non-enteric foreign bodies in 17 dogs. J Small Anim
Pract 2004; 45:395-400.
Indirizzo per corrispondenza:Dott. Daniele Della Santa - Via Amendola, 12 - 56017 San Giuliano Terme (PI), Italia Tel. 050/890745 - Cell. 340/8218564 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
563
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
PALMITOILETANOLAMIDE (PALMIDROL, INN) NEL MANAGEMENT DELLA DERMATITE ATOPICA DEL CANE. STUDIO RANDOMIZZATO, IN DOPPIO CIECO,
CONTROLLATO VERSUS PLACEBO
S. Waisglass, BSc, DVM, CertSAD, DACVD1, J. Araujo, BSc2,M. F. della Valle, MSc(Biol)5, N. W. Milgram, MD, PhD3,4
1 Libero Professionista, Thornhill, Ontario, Canada2 CanCog Technologies Inc., Toronto, Ontario, Canada
3 Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Medicine, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada4 Division of Life Sciences, University of Toronto at Scarborough, Scarborough, Ontario, Canada
5 CeDIS Innovet (Centro di Documentazione e Informazione Scientifica), Saccolongo, Padova, Italia
Area di interesse: Dermatologia
Scopo del lavoro. La dermatite atopica del cane (o canine atopic dermatitis, CAD) è una dermatopatia cronico-infiammato-ria a carattere pruriginoso, che colpisce il 15-30% della popolazione canina 1. Le esacerbazioni di CAD possono anche esse-re causate da allergeni alimentari; di conseguenza, le reazioni avverse al cibo (o cutaneous adverse food reactions, CAFR)possono manifestarsi clinicamente come CAD2. La diagnosi differenziale si basa esclusivamente sulla dieta di eliminazionee successivo test di provocazione. Le principali opzioni terapeutiche per la CAD sono attualmente rappresentate da: corticosteroidi, immunoterapia allergene-specifica, antistaminici, acidi grassi essenziali e ciclosporina A 3. I corticosteroidi possiedono effetti collaterali a breve ter-mine (es. poliuria, polidipsia e polifagia) e, nel medio-lungo, possono predisporre allo sviluppo di infezioni croniche, lassi-tà articolare e nefropatie. Gli antistaminici, efficaci solo in alcuni casi, sono spesso associati a sonnolenza. La ciclosporinaA è piuttosto costosa. Palmidrol è la denominazione comune internazionale della palmitoiletanolamide (PEA), un compostoendogeno appartenente alla famiglia delle aliamidi e noto esercitare effetti antinfiammatori sia in animali sperimentali che inpazienti veterinari4-6. Scopo del presente studio è verificare l’efficacia della PEA nel trattamento di cani affetti da CAD, cono senza CAFR. Materiali e metodi. Sulla base di specifici criteri di inclusione ed esclusione, sono stati selezionati 20 cani di proprietà con dia-gnosi clinica standard di CAD. Durante tutto lo studio, i soggetti venivano sottoposti a trattamento per il controllo di pulci e zec-che. Prima dell’inclusione, ai soggetti non venivano somministrati test dietetici di eliminazione/provocazione, lasciando apertala possibilità di includere casi di CAFR. Lo studio veniva condotto con disegno randomizzato, in doppio cieco versus placebo,di tipo cross-over. Ciascun cane veniva trattato per 45 giorni con placebo o PEA (15 mg/Kg/die PO), e, dopo un wash-out di almeno 4 settimane,riceveva l’altro trattamento di pari durata (PEA, se aveva inizialmente assunto placebo, o viceversa). Prima e dopo ciascuna fa-se del cross-over, il veterinario determinava la gravità di eritema, lichenificazione ed escoriazione, tramite il sistema di valuta-zione CADESI (Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index)7. La gravità di questi segni clinici veniva misurata in 40aree corporee, come di seguito indicato: 0=nessuna; 1=lieve; 2=moderata; 3=grave. Durante le visite di controllo, al proprieta-rio veniva chiesto di valutare la tollerabilità del prodotto, secondo una scala VAS (visual analog scale): linea di 100 mm che, alpunto di origine, riportava la dicitura “tollerabilità eccellente” e, in corrispondenza del termine, “tollerabilità molto scarsa”. L’a-nalisi statistica dei dati veniva condotta con il test non-parametrico Kruskal-Wallis. P<0,05 veniva assunto come limite di si-gnificatività. Risultati. Diciotto cani completavano lo studio. Di questi, 10 erano maschi e 8 femmine. L’età media era 5,3 anni (range 1-9 aa); 11 erano di taglia piccola e 7 di taglia grande-gigante. Al momento dell’inclusione, i punteggi medi erano i seguenti:eritema = 9,1; lichenificazione = 5,2; escoriazione = 2,2. A differenza del placebo, PEA riduceva l’eritema in modo statisti-camente significativo (P=0,032). La gravità di lichenificazione ed escoriazione, nonché il punteggio totale CADESI non di-minuivano in modo significativo in seguito al trattamento. La tollerabilità della PEA non risultava significativamente diver-sa da quella del placebo. Conclusioni. Per quanto ci è dato sapere, questo è il primo studio che valuta l’efficacia della PEA nel trattamento dellaCAD ad insorgenza spontanea, in presenza o assenza di concomitante CAFR. In particolare, abbiamo dimostrato un effet-to statisticamente significativo della PEA sull’eritema, un noto marker di infiammazione cutanea acuta. La mancanza di ef-fetto su lichenificazione, escoriazione e punteggio totale CADESI potrebbe essere correlata alla scarsa gravità dei segni almomento dell’inclusione. Ciò, a sua volta, potrebbe essere riconducibile alla riluttanza del proprietario a trattare il proprio ca-ne con placebo, anche se solo per metà dello studio. Alternativamente, è possibile ipotizzare che la mancanza di effetto dellaPEA sulle suddette lesioni dipenda dalla loro cronicità: potrebbero essere necessari periodi di trattamento più lunghi per evi-denziarne il miglioramento, così come discusso in precedenza da altri Autori7. È anche necessario sottolineare che, nel corsodello studio, non erano ammessi trattamenti antibiotici o antifungini.I dati sulla tollerabilità, ottenuti dal presente studio, confermano la sicurezza della PEA.Concludendo, possiamo affermare che la PEA può essere utilmente impiegata nel trattamento delle forme lievi di CAD. Si ren-dono necessari ulteriori studi in soggetti con forme medio-gravi.
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
564
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
Bibliografia
1. Hillier A and Griffin CE. Vet Immunol Immunopathol. 2001;81:147–512. Olivry T et al. Vet Dermatol. 2007;18:390–13. Olivry T and Mueller RS. Vet Dermatol. 2003;14:121-464. Wise LE et al. Neuropharmacology 2008;54:181-85. Scarampella F et al. Vet Dermatol. 2001;12:29-396. Marsella R et al. Vet Dermatol. 2005;16:2027 Olivry T et al. Vet Dermatol. 2002;13:77-87
Indirizzo per corrispondenza:Maria Federica della Valle - CeDIS Innovet (Centro di Documentazione e Informazione Scientifica),Via Einaudi 13, I-35030 Saccolongo (Pd), Italy - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
565
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
TRATTAMENTO DI UNA NEOPLASIA SURRENALICA CON TERMOABLAZIONE PERCUTANEA ECOGUIDATA
G. M. Gerboni, Dr Med Vet1, G. Biondi, Dr Med Vet1, S. Scarso, Dr Med Vet1,M. Olivieri, Dr Med Vet1, G. Carrafiello, MD2
1 Clinca Veterinaria Malpensa, Samarate, Varese, Italia2 Dipartimento di Radiologia; Università dell’Insubria, Varese, Italia
Area di interesse: Diagnostica per immagini
Introduzione. Le neoplasie surrenaliche sono rappresentate nel 41% da adenoma corticale, nel 14% da adenocarcinoma corti-cale, nel 15% da feocromocitoma, nel 3% da lesioni metastatiche e nel 28% da altre neoplasie. Non tutte le neoplasie surrena-liche sono funzionali, ma costituiscono il 10 -15 % dei cani affetti da iperadrenocorticismo. Il trattamento convenzionale di que-sti tumori è la surrenalectomia. Lo scopo di questa esperienza preliminare è quello di valutare i vantaggi di un trattamento abla-tivo eseguito a mezzo di singola antenna ad emissione di microonde con tecnica percutanea ed ecoassistita Descrizione del caso. Un cane meticcio, maschio, di 13 anni veniva riferito per anoressia improvvisa e vomito. Nella raccoltadei dati anamnestici, i proprietari segnalavano episodi di ematuria e stranguria. Un esame ecografico precedentemente eseguitoaveva permesso di rilevare una massa surrenalica sinistra. All’esame clinico il cane presentava riluttanza al movimento e cifosi,dolore alla palpazione profonda dell’addome craniale e della regione renale. L’esame radiografico mostrava un aumento dellaradio-opacità con perdita di definizione dell’area retro-peritoneale. Con l’ecografia addominale veniva diagnosticata una iper-plasia prostatica cistica, un aumento del volume e della ecogenicità del fegato ed una massa surrenalica sinistra, caratterizzatada forma arrotondata con diametro di 40 mm, ecostruttura disomogenea, iperecoica e margini regolari. La ghiandola surrenali-ca controlaterale era di forma e dimensioni normali. Non si notavano segni di invasività locale. In contiguità alla massa e cra-nio-dorsalmente al rene sinistro era presente una raccolta di liquido infiltrante lo spazio retroperitoneale. Formulato il sospettodi rottura della massa surrenalica, il paziente veniva sottoposto a terapia analgesica ed antiemetica. A due settimane dalla riso-luzione dei sintomi il cane presentava un secondo episodio acuto di vomito e dolore addominale. L’esame ecografico di con-trollo evidenziava nuovi segni di rottura della massa. Veniva quindi programmato il trattamento di termoablazione tumorale per-cutanea. Nei controlli ematologici eseguiti pre-trattamento, i test di valutazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, il cortisolourinario e stimolazione con alte dosi di desametasone sono risultati nei range di normalità, così come i rilievi della pressione si-stemica. La termoablazione è stata effettuata in anestesia generale con il cane in decubito dorsale. Sotto assistenza ecograficasono stati effettuati i prelievi ago-bioptici dalla massa. Sempre con guida ecografica, in scansione parasagittale sinistra, si è ese-guita l’infissione percutanea dell’antenna per la trasmissione delle microonde al centro della massa surrenalica. L’antenna uti-lizzata aveva diametro di 14,5 gauge ed un apice radiante lungo 37 mm. L’antenna era collegata a mezzo di un cavo coassiale algeneratore di microonde, capace di produrre 45 W di potenza ad una frequenza di 915 MHz. Si è eseguita una singola proce-dura ablativa della durata di 7 minuti al fine di ottenere un’area di necrosi approssimativa di 35 mm di diametro. Al termine deltrattamento ablativo l’antenna è stata sfilata ed il paziente risvegliato. Controlli ecografici a cadenza settimanale hanno eviden-ziato la scomparsa del segnale Doppler a codice di colore all’interno della massa con una costante riduzione della ecogenicitàin assenza di riduzione del diametro e del volume. Conclusioni. I tumori surrenalici rappresentano 1,5 % delle neoplasie che affliggono la popolazione canina. La loro rottura è unevento non frequente, ma è una grave complicanza che aumenta la mortalità e la morbilità del loro trattamento chirurgico. Lascelta di un trattamento ablativo mini-invasivo è stata suggerita dalla possibilità di indurre una necrosi coagulativa abbassandoi rischi operativi. L’ablazione con microonde è stata preferita alle altre tecniche, quali chemioablazione e radiofrequenza, in fun-zione delle dimensioni della lesione e della necessità di generare un’ampia necrosi. In accordo con i lavori disponibili in lette-ratura la procedura ha avuto un riscontro tecnico positivo in assenza di complicanze, mentre l’effettiva efficacia clinica dovràessere valutata nei controlli eseguiti a lungo termine. In conclusione il risultato conseguito nel trattamento percutaneo, sotto controllo ecografico, della massa surrenalica ha eviden-ziato le potenzialità terapeutica della termoablazione a microonde. Controlli a lungo termine e appropriati criteri di selezione delpaziente sono indispensabili per comprendere il futuro di questa tecnica mini-invasiva.
Bibliografia
Carraffiello G, et al. Microwave tumors ablation: principles, clinical applications and review of preliminary experiences. Int J Surg 2008; Dec 14. Kigure T, et al. Microwave ablation of the adrenal gland: experimental study and clinical application. Br J Urol 1996; 77 (2): 215-20.Barthez PY, et al. Ultrasonography of adrenal gland in dog, cat and ferret. Vet Clin North Am Small Anim Pract 1998; 28: 869-885.
Indirizzo per corrispondenza:Dott. Gianmarco Gerboni - Clinica Veterinaria Malpensa - Via Marconi 27 - 21017 Samarate (VA), Italia Tel. 0331-228155 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
566
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
800 TEST INTRADERMICI ALLERGOMETRICI IN CANI CON DERMATITE ATOPICA IN DIVERSE REGIONI ITALIANE: ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE
DELLE RAZZE E DELLE POSITIVITÀ AI SINGOLI ALLERGENI
G. Ghibaudo, Med Vet1, C. Noli, Med Vet, Dipl. ECVD2, P. Persico, Med Vet3
1 Clinica Veterinaria Malpensa, Samarate (Varese), Italia2 Ospedale Veterinario Cuneese, Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Italia
3 Libera professionista, Milano, Italia
Area di interesse: Dermatologia
Scopo del lavoro. La valutazione delle differenze di distribuzione di razza della positività ai differenti allergeni in cani affettida dermatite atopica abitanti in zone urbane o rurali in diverse regioni italiane in cui sono stati effettuali test intradermici aller-gometrici. Materiali e metodi. Sono stati analizzati i dati di segnalamento e i risultati dei test intradermici allergometrici effettuati con glistessi 33 allergeni ambientali (alberi, pollini di graminacee ed erbe infestanti, muffe, polvere di casa ed acari, epitelio di uomoe di gatto, pulce e Malassezia) effettuati su 800 cani affetti da dermatite atopica provenienti da 12 regioni italiane nel periodo1998-2008. La prevalenza di ciascuna razza nella casistica di questo studio è stata confrontata con la prevalenza razziale sul ter-ritorio. La percentuale di positività per ciascun allergene è stata valutata nei cani provenienti da ambiente urbano e rurale, comeanche sono stati determinati gli allergeni outdoor più frequentemente positivi per ciascuna regione. Risultati. I meticci sono stati i più rappresentati con un 26% della casistica, circa la metà della percentuale presente sul territo-rio, che testimonia una minore predisposizione dei meticci alla dermatite atopica o una minore predisposizione dei loro pro-prietari ad effettuare i test intradermici. Fra i cani di razza pura i più rappresentati nella casistica di questo studio sono: PastoreTedesco (16,2%), Labrador (13,5%), Boxer (9,5%), West Highland White Terrier (WHWT) (6,7%), Bulldog Inglese e Pitbull(4,4% ciascuno). A confronto con la popolazione canina italiana si determina che il Pastore Tedesco non è particolarmente pre-disposto alla dermatite atopica, mentre lo sono Labrador (2,5x), Boxer (2x), WHWT e Bulldog Inglese (7x). Gli allergeni piùfrequentemente positivi nei test sono stati gli acari della polvere di casa, seguiti dai pollini di graminacee ed erbe infestanti, ipollini di alberi, gli epiteli e le muffe. Il Dermatophagoides farinae è risultato positivo nel 77,9% dei cani in ambiente urbano esolo nel 54,3% di quelli in ambiente rurale. Una distribuzione simile si è osservata per tutti gli altri acari. I cani in ambiente ur-bano hanno dato positività maggiori rispetto a quelli in ambiente rurale anche per l’ambrosia, l’Anthoxanthum, il tarassaco, laparietaria, la bambagiona (Holcus lanatus), la gramigna (Cynodon dactylon), la piantaggine, l’epitelio del gatto e le muffe. Pernessun allergene i cani in ambiente rurale hanno dato risultati marcatamente più positivi dei cani in ambiente urbano. Il loglia-rello (Lolium perenne) e la parietaria hanno dato risultati positivi in modo uguale tutte le regioni, la piantaggine e il tarassacoin tutte tranne la Liguria, l’artemisia in tutte tranne Umbria e Toscana. In Lombardia sono risultate più frequenti le positività abetulla, bambagiona, Anthoxanthum, tarassaco, parietaria, artemisia e ambrosia; in Emilia Romagna sono risultati più frequen-temente positive le graminacee; nelle Marche, il tarassaco e l’ambrosia, in Toscana la parietaria, la piantaggine e il logliarello,in Puglia l’olivo, l’ortica, l’ambrosia l’Anthoxanthum e l’artemisia. In particolare l’ambrosia è risultata particolarmente impor-tante in Lombardia (43% dei cani testati in questa regione). La pulce ha dato risultati positivi più frequentemente in Liguria, Pie-monte ed Emilia Romagna. Conclusioni. I cani di razza pura sono risultati più predisposti alla dermatite atopica, ed in particolare le razze Labrador, Bo-xer, WHWT, Bulldog Inglese e Pitbull. I cani in ambiente urbano hanno avuto più positivi, negli skin test, agli acari della pol-vere di casa e delle derrate alimentari, ma anche ai pollini di alberi e graminacee rispetto ai cani provenienti da ambienti ru-rali. Si sono osservate differenti distribuzioni di pollini nelle diverse regioni, la Lombardia ha mostrato il maggior tasso dipositività, soprattutto per l’Ambrosia. Questi risultati possono essere da guida per l’allestimento di kit regionali di allergenida testare in futuro.
Bibliografia
1. Saridomichelakis MN, Koutinas AF, Gioulekas D, Leontidis L. Canine atopic dermatitis in Greece: clinical observations and the prevalence of positiveintradermal test reactions in 91 spontaneous cases. Vet Immunol Immunopathol. 1999 Jul 1;69(1):61-73.
2. Zur G, Ihrke PJ, White SD, Kass PH. Canine atopic dermatitis: a retrospective study of 266 cases examined at the University of California, Davis, 1992-1998. Part I. Clinical features and allergy testing results. Vet Dermatol. 2002 Apr;13(2):89-102.
3. Noli C., Candian M., Scarpa P. Analisi di una casistica specialistica dermatologica nel nord Italia: 1188 casi (1995-2002). Veterinaria, Anno 20, n. 2, Apri-le 2006.
Indirizzo per corrispondenza:Dott. Giovanni Ghibaudo - Via A. De Gabrielli, 19 - 61032 Fano (PU), Italia Tel. 0721-805792 - Cell 340/1577480 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
567
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
UN CASO DI RINITE CRONICA IN CORSO DI LEISHMANIOSI FELINA
F. Ibba, DVM1
1 Private Pratictioner, Capoterra, Italy
Topic: Respiratory Diseases
Introduzione. La leishmaniosi è un complesso di patologie protozoarie a carattere zoonotico causate da microrganismi appar-tenenti al genere Leishmania. L’Italia, e più in generale il bacino mediterraneo, sono considerate aree endemiche per ciò che ri-guarda la leishmaniosi canina e umana, mentre i casi di leishmaniosi felina, dovuti tutti a L. infantum, sono assai rari.Il caso presentato riguarda un gatto comune europeo in cui il quadro sintomatologico ha assunto caratteristiche cliniche mai de-scritte nei circa 40 casi riportati al 2007 in letteratura. Descrizione del caso. Il caso riguarda un gatto europeo, maschio intero, 12 anni di nome Cangurotto, residente in una localitàcostiera del Sud Sardegna. Il gatto veniva sottoposto regolarmente a profilassi vaccinale e solo saltuariamente a trattamenti an-tiparassitari. Il gatto fu visitato per una rinite cronica trattata dai proprietari di propria inziativa con antibiotici, per salivazioneeccessiva, poliuria/polidipsia e perdita di peso. I sintomi erano comparsi due mesi prima e si erano via via aggravati. Le condi-zioni generali del gatto al momento della visita erano piuttosto scadenti. La temperatura rettale era di 36,9°C, le mucose palli-de, lo stato del sensorio depresso. I linfonodi periferici erano facilmente palpabili, leggermente megalici, in particolar modo isottomandibolari. All’esame della cavità orale si notò una grave faucite/stomatite. Il tartufo era ulcerato e dalle narici fuoriusci-va abbondante secrezione di aspetto muco-emorragico. La cute era molto anelastica, si manteneva in plica per un grado stima-to di disidratazione del 10%, ed erano presenti aree alopeciche crostose, tondeggianti, variamente distribuite sulla cute dorsale,che i proprietari asserivano essere comparse nell’ultima settimana. L’esame otoscopico permise di rilevare una otite che all’e-same citologico del cerume si è rivelò di origine parassitaria. All’auscultazione del torace non si rilevavano anomalie, la palpa-zione dell’addome non forniva riscontri degni di nota. Fu eseguito un profilo biochimico, un esame emocromocitometrico, unesame delle urine e campioni citologici di secrezioni nasali, raschiati cutanei e un ago aspirato linfonodale. L’esame emocro-mocitometrico mise in evidenza una grave anemia non rigenerativa (HCT 13%) normocitica, e una lieve monocitosi. Il profilobiochimico rivelò una modica iperazotemia e iperfosfatemia con creatinina normale, ipocalcemia, ipomagnesemia, ipercoleste-rolemia e una notevole alterazione del quadro proteico, con proteine totali 11,5 ed ipoalbuminemia e marcata ipergammaglobu-linemia (rapporto A/G 0,18). L’esame delle urine evidenziava un peso specifico di 1015, inadeguato alla disidratazione del pa-ziente, con forte proteinuria (3+ al dipstick e rapporto PU/CU di 2,2) e sedimento attivo (neutrofili ++ e batteriuria +). Si è prov-veduto a testare il gatto per malattie retrovirali con esito positivo per FIV e negativo per FeLV. I raschiati cutanei non hanno per-messo di evidenziare una causa parassitaria o fungina delle lesioni alopeciche mentre all’esame citologico degli essudati nasalisi osservava un quadro infiammatorio neutrofilico con numerosi cocchi fagocitati. Oltre a quantità variabili di cellule epitelialie plasmacellule si repertarono numerosi organismi assimilabili a leishmania spp, che sono stati identificati anche nell’FNB dellinfonodo prescapolare. Fu eseguito il test sierologico anticorpale IFAT ottenendo un titolo di 1:800, sebbene questo test non siavalidato per il gatto. Inizialmente fu impostata una terapia antibiotica a base di enrofloxacina e clindamicina per la rinite batte-rica e l’infezione urinaria. Nonostante in letteratura sia riportato per la terapia della leishmaniosi felina unicamente l’utilizzodell’allopurinolo si preferì utilizzare gli antimoniali alla dose di 50mg/Kg die per 30gg. Furono somministrati anche benazeprile acidi grassi omega-3 per la glomerulonefrite proteinurica ed interferone alfa umano per via orale. Già dopo la prima settima-na di antimoniali la rinite scomparve e gli amastigoti di Leishmania non erano più riscontrabili alla citologia nasale e linfono-dale, e dopo un mese i miglioramenti clinici erano evidenti, con scomparsa della sintomatologia cutanea. Il gatto era aumenta-to di peso e si mostrava più attivo. Permanevano la condizione di anemia non rigenerativa, sebbene l’HCT fosse risalito di trepunti percentuali, e l’iperazotemia, mentre il monitoraggio dei parametri urinari mostrava un abbassamento del PU/CU (1,4). Purtroppo il gatto morì in seguito ad incidente stradale quindici giorni dopo il termine della terapia con antimoniale. Conclusioni. Sebbene rara, l’infezione del gatto da parte di leishmania spp non può essere ignorata ed andrebbe inclusa nellediagnosi differenziali in gatti immunosoppressi. La terapia con antimoniali si è dimostrata efficace e priva di effetti indesidera-ti immediati, con nessun segno ematochimico di danno renale ed epatico.
Bibliografia
Martin Sanchez et al. Infection by Leishmania Infantum in cats: epidemiological study in Spain. Vet Parasitol. 2007 apr 30; 145(3-4):267-73.Barnes JC et al. Diffuse cutaneous leishmaniasis in a cat. JAVMA 1993 feb 1; 202(3):416-8.Pennisi et al. Case report of leishmaniasis in four cats. Veterinary research communications 28 (2004) 363-366.Leiva, Loret, Roura et al. Therapy of ocular and visceral leishmaniasis in a cat.
Corresponding Address:Dott. Fabrizio Ibba - Ambulatorio Veterinario Dr. Ibba Fabrizio Strada 40 N. 5, Località Poggio Dei Pini, 09012 Capoterra (CA), Italy Phone 070/725552 - Mobile: 3339116263 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
568
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
IDENTIFICATION OF REPRODUCTIVE PARAMETERS IN SIBERIAN HUSKY BITCHES
V. Igna, DVM, PhD1, H. Cernescu, DVM, PhD1, C. Mircu, DVM, PhD1
1 Dept. Reproduction, obstetrics, gynecology, Univ. of Agricultural Science and Veterinary Medicine of Banat,Timisoara, Romania
Topic: Reproduction
Purpose of the work. The purpose of the present study is to establish the parameters of sexual activity on a Siberian Husky fe-male (bred in Romania) and the reproductive features of this breed.The main objectives were: the establishment of a sexual cycle duration, identification of the fertile period, breeding indices (therate of pregnancy, the mean litter size, insemination index and sex-ratio). Materials and used methods. This study included 12 Siberian Husky females aged between 7 months and 8 years. Each femalewas pursued rigorously, notifying all changes related to sexual activity: the age of the first manifestation of the oestrus cycle,duration of heat, clinical and behavioral changes associated with this period, the date of each mating or artificial insemination,pregnancy length, the parturition process, litter size and sex ratio in each nest.To establish and identify the fertile period and ovulation, the following were performed:- the onset of proestrus was fixed. Through clinical examinations changes of sexual behavior and the genital track were pursued
(the aspect of vulvar labia, vaginal discharge and vaginal mucosa);- the cytology status of the sexual cycle was specified through daily examination of cytovaginal smear, beginning with 5th-6th
day of heat, until the installation of cytological metoestrus. - serum concentrations of progesterone were determined using ELISA technique, in 15 oestral cycles.To establish indicators for breeding in bitches (the pregnancy rate, the mean litter size and sex ratio), the following were per-formed:- all matings or artificial insemination were registered and the mean was determined for each cycle and female;- ultrasound examinations were made, in order to diagnose pregnancy, at 25 - 29 days after the last mating or artificial insem-
ination.- all data related to pregnancy and parturition have been registered: pregnancy length, duration of parturition and behavioral
events preceding, during and after parturition, the number of puppies and the relationship between sex. Outcomes. The analysis of the recorded data after the behavioral and clinical exams, cytology, hormonal assay and ultra-sonography, reveals the following aspects:The mean age at puberty was 8.58 months, with limits between 6 and 11 months.The average length of the sexual cycle in Siberian Husky bitches, calculated for 12 females, on 96 sexual cycles, was 175.08 ±30.07 days.The heat period or folicular phase of the sexual cycle was 19.33 ± 1.84. It is considered that the duration of this phase is be-tween 12 and 20 days (1,4). The results of this study place the duration of heat (proestrus + oestrus) at the maximum limit ofcanine species.The mean length of proestrus was 15.17 ± 1.62 days and the length of oestrus was 4.17 ± 0.80 days. The values of standard de-viation indicate a uniformity of the duration of stages between individuals as well as between the various oestral cycles of thesame female. It is observed that the duration of cytologic proestrus in the Siberian Husky breed is longer than maximum valuesfor canine species assigned to this stage, according to the literature in canine species (2). Most specialists consider proestrusperiod between 7-10 days. The average duration of cytological oestrus is placed towards the minimum value mentioned in spe-cialty literature, different authors (1,2,3) surrounding oestrus in a wide range: 3-21 days.The values of serum progesterone in oestrus, were between 8.2 - 20.3 ng/ml. The minimum limit for mating was considered at8-10 ng/ml. In two cases, hormonal assay allowed detection of disorders of the the sexual cycle: a split oestrus and a luteal in-sufficiency.The average gestation length was 62 days, ranged between 57 and 67 days. Pregnancy rate was 78% in females monitored during oestral period by vaginal exfoliative cytology. In cases of complex mon-itoring of cycle, including serum progesterone assay for estimating ovulation time, a pregnancy rate of 83% was obtained. In-semination index was 2.68.The behavior during parturition and puerperal period corresponds to that generally described in canine species. The average duration of parturition calculated for 20 whelpings was 15 hours. Other five parturitions presented dystocia: threeby excessive size of the fetus and two by abnormal position of the fetus and required cesarean section. The mean litter size was6.16 puppies, with limits between 2-9 puppies. For all births with more than 8 puppies fetal mortality was recorded, one or twodead fetus being expulsed. The gender of the puppies: 45.3% female and 54.3% male. Conclusions. The average length of the female sexual cycle of Siberian Husky breed is 175 days. Follicular phase of the sexu-al cycle is 19.33 ± 1.84 with longer duration of proestrus compared to other breeds. Average gestation period was 62 days, with limits between 57 and 67 days. Pregnancy rate was 78% in females monitored bycytovaginal smear and 83% for oestral cycle monitored by vaginal cytology and serum progesterone assay. The average littersize was 6 puppies with limits between 2-9 puppies.
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
569
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
Bibliography
1. Cernescu H., Ginecologie veterinara, Ed. Cecma, 20042. Dumon, C., Fontbonne, A., Reprod du chien et du chat, Ed. P.M.C.A.C., Paris, 19923. Guerin, C., L’insemination artificielle dans l’espece canine, Ed. Point Vet., 19974. Mialot, P., Pathologie de la reproduction, Ed. Point Vet, Paris, 1984
Corresponding Address:Dr. Violeta Igna - Reproduction, Obstetrics And Gynecology/University Of Agricultural Science And Veterinary Medicine Of Banat Reproduction, Obstetrics And Gynecology, 119, Calea Aradului, 300645 Timisoara/Romania, Romania Phone 040256277275 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
570
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
UTILIZZO DI VIAGRA® IN UN CASO DI PDA INVERTITO
P. Knafelz, DVM1, B. Maciocchi, DVM2, A. Baio, DVM3, S. Piccinini, DVM4
1 Libero Professionista, Roma, Italia2 Libero Professionista, Roma, Italia3 Libero Professionista, Roma, Italia4 Libero Professionista, Roma, Italia
Area di interesse: Cardiologia
Introduzione. Il PDA (persistenza del dotto arterioso) è un difetto congenito di comune riscontro nel cane. Il dotto arterioso è un vaso fetale che deriva dal sesto arco aortico di sinistra e l’arteria polmonare con l’aorta discendente pros-simale, consentendo il passaggio di sangue ossigenato alla circolazione sistemica. Con il primo atto respiratorio l’aumento re-pentino della tensione parziale di ossigeno, con la conseguente inibizione delle prostaglandine vasodilatatrici locali e la drasti-ca riduzione delle resistenze vascolari polmonari, determina contrazione della muscolatura liscia del dotto e la sua chiusura. Il PDA con shunt sx-dx consiste nel passaggio di sangue dall’aorta all’arteria polmonare durante tutto il ciclo cardiaco. In una piccola percentuale di cani con PDA si instaura ipertensione polmonare che inverte la direzione del flusso con conse-guente passaggio di sangue dall’arteria polmonare all’aorta discendente (PDA invertito). Descrizione del caso. Tiffany, Yorkshire Terrier toy, femmina intera di 18 mesi, veniva riferita presso la nostra struttura per af-faticabilità e debolezza sul treno posteriore dopo sforzi o stati emozionali.All’esame clinico rivelava mucose buccali rosee, mucosa vulvare lievemente cianotica; all’ascultazione non erano percepibilisoffi ed il polso femorale risultava nella norma.Lo studio radiografico del torace, eseguito in doppia proiezione L/L destra e D/V, evidenziava cardiomegalia destra, dilatazionedell’arteria polmonare principale e decorso tortuoso delle arterie polmonari lobari caudali. All’esame ecocardiografico presentava severa ipertrofia concentrica ventricolare destra, marcata dilatazione dell’arteria polmo-nare principale in assenza di stenosi, moderato sovraccarico volumetrico atriale destro e rigurgito tricuspidale con gradientepressorio di 74mmHg, indicativo di severa ipertensione polmonare. Si osservava, infine, la presenza del dotto arterioso con aper-tura polmonare di calibro più ampio rispetto alle caratteristiche anatomiche del dotto tipico.Si eseguiva quindi un “bubble-gram”, con inoculazione attraverso la vena cefalica di soluzione fisiologica miscelata a sangueperiferico, per escludere eventuali shunt intracardiaci. La visualizzazione di microbolle all’interno dell’aorta addominale con-fermava il PDA con inversione dello shunt.Dalla valutazione emogasanalitica effettuata dall’arteria femorale si evidenziavano valori di Hct 68% e pO2 35 mmHg, indica-tivi di probabile policitemia compensatoria. Si procedeva quindi a salasso dalla vena giugulare, assicurando adeguata fluidote-rapia. All’emogasanalisi di controllo si evidenziava riduzione dell’ematocrito a 64%. Si decideva di impostare una terapia con sildenafil (Viagra ®) a 2mg/kg sid.Il sildenafil è un potente inibitore selettivo della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5) cGMP-specifica, l’enzima responsabile delladegradazione di cGMp. Questo enzima è presente nella muscolatura liscia dei vasi polmonari. Pertanto il sildenafil aumenta laCGMP nelle cellule della muscolatura liscia vascolare polmonare determinando, nei pazienti con ipertensione polmonare, unavasodilatazione del letto vascolare polmonare e, in minor misura, una vasodilatazione della circolazione sistemica.Follow up. Il soggetto si presentava ai successivi controlli settimanali, mostrando un notevole miglioramento della sintomatolo-gia clinica, in particolare una riduzione della frequenza e dell’intensità degli episodi riferiti. I controlli emogasanalitici rileva-vano un progressivo decremento dell’ematocrito fino al raggiungimento di un valore pari a 62% ed una pO2 finale di 50mmHg. Conclusioni. Conclusioni Gli studi preliminari effettuati sui PDE-5 indicano che questa classe farmacologica potrebbe avereimportanti e rivoluzionarie implicazioni terapeutiche nel trattamento dell’ipertensione polmonare, sia essa di natura primaria osecondaria.I primi confortanti risultati ottenuti con l’utilizzo del Viagra® ci inducono a validare l’uso di tale molecola come possibile scel-ta terapeutica nel trattamento farmacologico del PDA invertito, per garantire una soddisfacente qualità di vita, in corso di unapatologia per la quale non risulta attuabile un approccio chirurgico.
Bibliografia
Cotè E., Ettinger SJ. Long-term clinical management of right-to-left (“Reversed”) Patent Ductus Arteriosus in 3 dogs. J Vet Intern Med 2001; 15:39-42.Kellum HB, Stepien RL. Sildenafil citrate therapy in 22 dogs with pulmonary hypertension. J Vet Intern Med 2007; 21:1258-1264.Kittleson MD. Patent ductus arteriosus. In: Kittleson MD, Kienle RD, eds. Small Animal Cardiovascular Medicine. St Louis, MO: Mosby;1998:218-230.
Indirizzo per corrispondenza:Dott.ssa Patrizia Knafelz - Piazza di Villa Carpegna 52 - 00167 Roma (RM), Italia Tel. 06/660681 - Cell. 333/2703757 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
571
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
ASPETTI ANATOMOPATOLOGICI DEI TUMORI CARDIACI NEL CANE E NEL GATTO:OSSERVAZIONI PERSONALI E REVISIONE DELLA LETTERATURA
E. Lepri, Med Vet, PhD, dipl. ECVP1
1 Dipartimento di Scienze Biopatologiche e Igiene delle Produzioni Animali ed Alimentari Sez. Patologia e Igiene Veterinaria, Facoltà di Medicina Veterinaria, Perugia, Italia
Area di interesse: Cardiologia
Scopo del lavoro. I tumori cardiaci sono rari nel cane ed ancor più nel gatto, ammontando, nelle diverse casistiche, allo 0,12%- 4,33% dei cani sottoposti a necroscopia; secondo alcuni autori prevalgono i tumori primari, mentre altri hanno osservato unamaggiore frequenza di tumori metastatici. La sintomatologia dei tumori cardiaci e la possibilità di una terapia chirurgica dipen-dono dalla localizzazione precisa del tumore nell’organo, oggi ben valutabile con le moderne tecniche di diagnostica per im-magini. I tumori del cuore possono essere intramurali, intracavitari, intrapericardici o originare intorno alla base del cuore. Sco-po della comunicazione è di descrivere gli aspetti anatomopatologici e topografici dei tumori cardiaci del cane e del gatto me-diante la descrizione di casi osservati personalmente ed un riesame della letteratura disponibile. Materiali e metodi. Nel periodo 1998-2008 sono stati osservati 65 tumori cardiaci di cane e 6 di gatto; di questi la maggior par-te erano tumori primari (52 nel cane, 2 nel gatto) con un numero inferiore di tumori secondari. Risultati. Nel cane il tumore più comunemente osservato è stato l’emangiosarcoma (HSA) con 22 casi. Il tumore era localizza-to nella maggior parte dei casi (10) all’appendice dell’orecchietta destra, in 6 casi alla giunzione atrio-auricola destra, in 3 casialla base dell’atrio, sopra l’ostio tricuspidale, ed in altri 3 casi sul margine dorsale dell’auricola, in prossimità del solco termi-nale e della vena cava craniale. L’HSA può apparire come una proliferazione esofitica sporgente nel pericardio (7 casi), averecrescita infiltrativa intramurale (7 casi) o più raramente intracavitaria (3 casi), con modelli misti nei restanti casi. L’HSA è co-munemente associato ad emopericardio, in particolare quelli a crescita esofitica o murale, con eventuale disseminazione intra-celomatica, osservata in 2 casi. Metastasi a polmone o altri organi erano presenti in 13 casi, mentre in 7 casi il tumore era limi-tato al cuore. In tutti i casi osservati l’HSA era responsabile della malattia o della morte del soggetto. Al contrario il frequenterilievo di tumori alla base del cuore (HBT: 20 casi) può rappresentare un reperto accidentale, non associato a sintomatologia cli-nica evidente, soprattutto per tumori di piccole dimensioni; per i tumori più grandi aumenta la possibilità che essi inducano unasintomatologia per compressione di atri e grossi vasi, diversa a seconda di localizzazione e dimensioni del tumore. Gli HBT era-no rappresentati quasi esclusivamente da chemodectomi (19 casi) con un solo caso di carcinoma tiroideo ectopico. I chemodec-tomi riconoscevano tre localizzazioni principali: alla base dell’aorta, sia medialmente tra aorta e arteria polmonare (5 casi), chelateralmente tra aorta e auricola destra (9 casi), oppure alla base dell’arteria polmonare, lateralmente ad essa ed a ridosso del-l’auricola sinistra (4 casi). Nel primo caso il tumore tende a crescere maggiormente prima di dare compressione e quindi sinto-matologia, mentre i tumori originati lateralmente all’aorta o alla polmonare insistono immediatamente sugli atri destro e sini-stro rispettivamente, e la compressione su queste strutture è più precoce, anche per tumori di dimensioni più ridotte. In 4 casi iltumore originava lungo l’arco aortico con compressione della vena cava. È stato osservato un singolo caso di chemodectomaprimitivo intratriale. Non sono mai state osservate metastasi a distanza ma in 3 casi erano presenti metastasi intracelomatichepericardiche. Altri tumori raramente osservati sono stati linfomi, sia in forma nodulare che diffusa, rabdomiosarcomi (uno in ca-ne ed uno in un gatto, sempre come masse intramurali nel ventricolo), tumori mixomatosi della valvola tricuspide (un mixomaed un mixosarcoma, quest’ultimo associato a metastasi polmonari) e tumori pericardici (un singolo sarcoma in un gatto). Re-perto interessante è risultato essere l’esteso coinvolgimento cardiaco, intramurale ed intracavitario, nel corso di tumori multiplidisseminati, istologicamente riferibili a sarcomi a cellule fusate. Conclusioni. I dati illustrati non si discostano significativamente da quanto riportato in letteratura per la frequenza delle singoleforme neoplastiche. Un’osservazione potrebbe essere la relativa frequenza di emangiosarcomi dell’auricola non associati a gene-ralizzazione metastatica (5/10), con possibili ripercussioni sulla trattabilità chirurgica del tumore. Anche la relativa frequenza dichemodectomi posti lateralmente alla base delle arterie, soprattutto polmonare, sede non comunemente riportata in letteratura, po-trebbe rappresentare una peculiarità della casistica presentata. Le localizzazioni atipiche di alcuni tumori, come il chemodectomaatriale o il mixosarcoma valvolare, rappresentano reperti “eccezionali”. Infine l’esteso coinvolgimento cardiaco in corso di tumo-ri sistemici morfologicamente riferibili a tumori a cellule fusate (d/d emangiopericitoma-PNST) può fare sorgere interessanti con-siderazioni di patologia comparata nei confronti della sindrome della neurofibromatosi dell’uomo e del bovino.
Bibliografia
ARONSHON M. Cardiac hemangiosarcoma in the dog: a review of 38 cases. JAVMA 187: 922, 1985.AÜPPERLE H ET AL: Primary and Secondary Heart Tumours in Dogs and Cats. J Comp Path 136: 18, 2007.VICARI ED ET AL: Survival times of and prognostic indicators for dogs with heart base masses: 25 cases. JAVMA 219: 485, 2001.
Indirizzo per corrispondenza:Dott. Elvio Lepri - Dipartimento di Scienze Biopatologiche e Igiene delle Produzioni Animali ed Alimentari Sez. Patologia e Igiene Veterinaria, Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia - Via S.Costanzo, 4 - 06126 Perugia (PG), Italia Tel. 075/5857629 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
572
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
LA CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000 DI UN’AZIENDA SANITARIA VETERINARIA
L. Lideo, DVM1,3, R. Milan, DVM1,3, A. Verme, DVM2,3, C. Scotti, DVM 3, E. Baroni, DVM, PhD1,3
1 CLINICA VETERINARIA BARONI, ROVIGO, ITALIA2 QUALITALIA, TORINO, ITALIA3 GruppoCVIT, TORINO, ITALIA
Area di interesse: Practice management
Scopo del lavoroINTRODUZIONE. Il ricorso alla certificazione ISO rappresenta uno strumento organizzativo per ottimizzare la gestione dei si-stemi produttivi riconosciuto da un organismo di certificazione esterno che si rende garante nei confronti di chi usufruisce delservizio. L’indirizzo di molte associazioni di categoria tra cui ANMVI a sviluppare sistemi di gestione qualità (SGQ) all’inter-no delle strutture veterinarie unito alla filosofia del miglioramento continuo secondo indicatori oggettivi ben misurabili ha por-tato la nostra clinica ad intraprendere il percorso di certificazione ISO. Tale percorso è stato condiviso da un intero gruppo distrutture veterinarie tra loro affiliate sul territorio nazionale. SCOPO DEL LAVORO. La norma ISO 9001 può essere applicata a qualunque organizzazione che produce prodotti o servizi.Essere certificati ISO 9001 significa rispondere a standard organizzativi tesi a dare garanzia delle capacità di soddisfare le atte-se del cliente e della tendenza al miglioramento continuo della singola azienda, così come impostato dalla norma ISO stessa.Questo lavoro offre uno spunto pratico di quello che è il percorso di certificazione di una singola struttura veterinaria e riportaalcuni elementi critici iniziali per ottenere tale riconoscimento. Materiali e metodi. La costruzione di un SGQ prevede innanzitutto che vengano stabiliti gli obiettivi della propria struttura formaliz-zandoli nel documento di politica della qualità, pianificando e organizzando il sistema seguendo un approccio per processi produttivi,assegnando compiti e responsabilità, mettendo a disposizione le risorse e verificando periodicamente l’efficacia del sistema. All’inter-no di un circuito di cliniche affiliate tale sistema si esplica a tutti i livelli da quello direttivo centrale dove viene stabilita la politica del-la qualità condivisa da tutti gli affiliati e dove viene regolamentato il rapporto tra affiliati, a quello periferico dove, pur mantenendo l’in-dipendenza organizzativa, sono stati creati dei sistemi qualità adattati ad ogni singola struttura secondo quanto impostato dalla dire-zione organizzativa del gruppo. Dal punto di vista pratico Il processo di certificazione prevede una prima analisi della struttura nel suoinsieme, delle persone che vi operano, dei servizi offerti e dei processi coinvolti per il raggiungimento del servizio finale. Una volta in-dividuati i processi e le interconnessioni presenti tra di loro è necessario formalizzare le singole operazioni svolte con delle procedurescritte ben definite e sottoposte a rigido controllo per stesura, approvazione ed eventuali modifiche, a queste vanno aggiunte delle istru-zioni operative ed una adeguata modulistica che serve a dare evidenza delle singole operazioni svolte. Risultati. Il lavoro svolto ha portato al risultato di estendere la certificazione ISO (certificato 6867 approvato da CERMET) delgruppo anche alla nostra clinica. Dal punto di vista organizzativo ha portato a formalizzare le procedure lavorative con indub-bio impatto sulla consapevolezza operativa del personale. Inoltre molti processi che hanno una diretta influenza sul servizio fi-nale sono sottoposti a maggior attenzione come la gestione della manutenzione e della taratura delle apparecchiature in uso, laformazione del personale e la registrazione delle non conformità rispetto a quanto stabilito nelle procedure.Un primo dato positivo che emerge dall’applicazione del SGQ è quello di un controllo dei costi tramite la gestione delle scorteaziendali ed una valutazione di indicatori economici che vengono comparati tra le strutture affiliate al gruppo. Queste prime im-pressioni nell’utilizzo di un SGQ, richiedono una serie di sforzi da parte del personale che deve condividere il sistema imposta-to ed essere sensibilizzato sulla puntuale compilazione della modulistica e segnalazione delle non conformità. In questo primo anno di impostazione e di utilizzo del SGQ le difficoltà hanno riguardato la formalizzazione dei processi azien-dali partendo da un importante impianto documentale, fornito dalla direzione del gruppo, che è stato adattato alla nostra realtàoperativa. Particolarmente impegnativa inoltre è stata la verifica dell’ente di certificazione condotta tramite audit in cui è statovisionato e validato il sistema documentale e la sua applicazione. Conclusioni. Per i prossimi anni di utilizzo del SGQ ci si propone di renderlo operativo a tutti i livelli all’interno della nostraclinica al fine di creare una comune cultura della qualità, che deve essere condivisa anche con tutte le strutture affiliate, lavo-rando secondo standard organizzativi riconosciuti a livello internazionale.
Bibliografia
1. F.Marello, Qualità certificabile, LA Settimana Veterinaria pp.4-8, 2009.2. E. Bellavance, Continuous quality improvement, in Blackwell’s-five minute veterinary practice management consult, Blackwell Publishing, pp.350-351,
2007.3. D.E.Lee, Vet. Clin. North Am., Practice management, Elsevier saunder, 36(2)2006. 4. P.L.Schmidt, Vet. Clin North Am., Evidence based veterinary medicine, 37 (3)2007.5. K.K. Cornell, J.C.Brandt, K.A.Bonvicini, Vet. Clin. North Am., Effective communication in veterinary practice, 37 (1)2007. 6. R. Montefusco, Il sistema qualità nelle aziende sanitarie, time science, 2004.7. C. Jevring, Managing a veterinari practice, saunder, 1996.
Indirizzo per corrispondenza:Dott. Luca Lideo - Clinica Veterinaria Baroni srl - Via Martiri di Belfiore, 69/D - 45100 Rovigo (RO), Italia Tel. 0425471076 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
573
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
LINFOMA A MEDIE CELLULE MACRONUCLEOLATE:ASPETTI CLINICO-PATOLOGICI E FOLLOW-UP IN OTTO CANI
S. Mazzotti, DVM1, S. Comazzi, DVM, PhD, DECVCP2, E. Zini, DVM, PhD, DECVIM3, G. Crispino, DVM1,L. Ciaramella, DVM1, E. Treggiari, DVM1, L. Marconato, DVM, DECVIM (Oncology)1
1 Clinica Veterinaria L’Arca, Napoli, Italia2 department of veterinary pathology, hygiene and health, Milano, Italia
3 Clinic for Small Animal Internal Medicine, Vetsuisse Faculty, University of Zurich, Zurigo, Svizzera
Area di interesse: Oncologia
Scopo del lavoro. Il linfoma, la neoplasia ematopoietica più comune del cane, origina dall’espansione clonale di cellule linfoidicon diverse caratteristiche morfologiche ed immunofenotipiche, rappresentando quindi un gruppo neoplastico eterogeneo. Il cor-retto inquadramento clinico-patologico è essenziale per la gestione clinica dei pazienti. Le classificazioni più recenti in medicinaumana tengono conto di caratteristiche epidemiologiche, cliniche, morfologiche, immunofenotipiche e genetiche, correlando tipomorfologico a terapia e prognosi. In veterinaria, la classificazione maggiormente utilizzata è quella di Kiel (modificata), che di-vide i linfomi secondo grado di malignità, immunofenotipo (IF) e morfologia.1 Tra i linfomi centroblastici ad alto grado è statorecentemente introdotto il linfoma a medie cellule macronucleolate (LMMC), segnalato solo nel cane.1 LMMC prende originedalla zona marginale perifollicolare, e nonostante il basso tasso mitotico, ha comportamento biologico aggressivo. Scopo di que-sto lavoro è di descrivere aspetti clinici, morfologici, comportamento biologico e risposta a chemioterapia di LMMC. Materiali e metodi. Si rivedevano le cartelle cliniche di cani con linfoma presentati alla Clinica Veterinaria Arca (2003-2009). La dia-gnosi di LMMC doveva essere confermata da valutazione morfologica ed IF. Di ogni caso si registravano: segnalamento; stadio clini-co (ottenuto da citologia di linfonodi periferici, ecografia addominale, citologia di fegato, milza e midollo osseo, CBC, ematochimica,radiografie del torace); sottostadio; IF eseguito su aspirato linfonodale o splenico, sangue periferico e midollare; eventuali patologieconcomitanti. Venivano inoltre annotati: tipo di chemioterapia e risposta, tossicità, sopravvivenza e causa di morte. Risultati. La revisione del database identificava 98 casi di linfoma, di cui 8 erano LMMC. Le razze rappresentate erano: meticci(n=3), rottweiler (n=2), yorkshire terrier (n=1), pastore tedesco (n=1), terranova (n=1). Cinque erano maschi e 3 femmine. L’etàmediana era di 9.5 anni (range, 6-13) ed il peso mediano di 35.5 kg (range, 5.2-48.1). Sei cani erano inclusi in IV stadio (3a e 3b),1 in stadio IIIa, e 1 in stadio Vb. In tutti i soggetti IF era B. In 3 casi la milza era il solo organo interessato; ecograficamente si os-servava un’unica lesione circoscritta. L’esame citologico mostrava in tutti i campioni una popolazione omogenea di cellule linfoi-di di medie dimensioni con nucleo centrale, nucleolo prominente circondato da membrana ispessita, citoplasma chiaro e basso in-dice mitotico. Tre cani presentavano patologie concomitanti (carcinoma mammario metastatico, leishmaniosi, IBD), 2 erano statitrattati con cortisone. Sette cani erano sottoposti a chemioterapia: 5 con VCAA, 1 con clorambucile ed 1 con metotrexate e ciclo-fosfamide in regime metronomico. Il cane in V stadio veniva sottoposto ad eutanasia subito dopo la diagnosi. I 5 cani trattati conVCAA ottenevano remissione completa (CR). Tre di questi recidivavano dopo >3 mesi e venivano trattati con diversi protocolli re-scue; al momento dell’analisi sono tutti vivi ed in CR dopo 159, 291 e 1532 giorni. Uno sviluppava carcinoide e veniva sottopostoad eutanasia, in CR per linfoma. L’ultimo è ancora in chemioterapia d’induzione. Il cane trattato con clorambucile non otteneva maiCR e moriva dopo 59 giorni. Il cane trattato con chemioterapia metronomica sviluppava carcinoma gastrico e veniva sottoposto adeutanasia dopo 302 giorni dalla diagnosi di LMMC. In generale, la chemioterapia era ben tollerata in tutti i soggetti. ConclusioniQuesto lavoro è il primo volto a descrivere caratteristiche clinico-patologiche e risposta a chemioterapia di LMMC nel cane. Ladiagnosi era sempre facilmente mediante citologia, considerate le caratteristiche morfologiche peculiari, e confermata da IF.LMMC era in stadio avanzato (IV-V) in 7 su 8 casi, e la milza era sempre interessata. Contrariamente alla tipica presentazioneecografica di linfoma, in cui la milza è massivamente infiltrata (aspetto “a nido d’ape”), in tutti i casi descritti era visibile unasingola lesione splenica, ed in 3 casi la milza era l’unico organo coinvolto. Secondo quanto riportato in letteratura, i linfomi adalto grado, se trattati con chemioterapia, danno tasso di CR nel 60-90% dei soggetti, con tempi di sopravvivenza di 6-12 mesi.2
I linfomi B, tipicamente chemiosensibili, si collocano tra quelli che danno risposte migliori e di più lunga durata.2
Seppur descritti come aggressivi, LMMC riportati in questo lavoro davano CR nel 71.4% dei cani trattati, con tempi di soprav-vivenza lunghi. Infatti, 4 cani erano vivi dopo +1532, +291, +159 e +23 giorni dalla diagnosi, mentre 2 erano sottoposti ad eu-tanasia dopo 175 e 302 giorni dalla diagnosi per altre cause (carcinoide e carcinoma gastrico). Uno solo dei cani sottoposti achemioterapia moriva spontaneamente dopo 59 giorni. Sono richiesti studi prospettici con elevato numero di animali per con-fermare riscontro splenico di massa singola e per uniformare chemioterapia.
Bibliografia
1. Ponce F, Magnol JP, Ledieu D, et al. Prognostic significance of morphological subtypes in canine malignant lymphomas during chemotherapy.Vet J.2004;167:158-66
2. Vail DM, Young KM. Canine lymphoma and lymphoid leukemia. In Withrow & MacEwen’s Small Animal Clinical Oncology pp 699-722, 2007
Indirizzo per corrispondenza:Dott.Ssa Laura Marconato - AOI Center, Rothusstrasse 2, CH-6331 Hünenberg, Svizzera Tel. +41 (0)41 783 07 77 - Cell. 335/6267202 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
574
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
RIABILITAZIONE FISIOTERAPICA DI UN PAZIENTE CON DISCOSPONDILITE ECONCOMITANTI LESIONI ORTOPEDICHE MULTIPLE CONSEGUENTI
AD UN RECENTE POLITRAUMA
C. Miola, Medico Veterinario1, L. Castellaneta, Medico Veterinario2, P. M. Piga, Medico Veterinario2,E. Revel Nutini, Laureando Medicina Veterinaria1
1 Centro Villa Beria, Mathi (To), Italia2 Clinica Veterinaria CVT, Torino, Italia
Area di interesse: Fisioterapia
Introduzione. La discospondilite è l’infezione del disco intervertebrale e dei corpi vertebrali ad esso adiacenti. Può verificarsi prima-riamente o in seguito a diffusione ematogena di germi da altri siti di infezione. In alcuni casi può associarsi a traumi e patologie dellospazio intersomatico.1;2 I cani di grossa taglia sono i più colpiti; il tratto interessato con maggiore frequenza è quello lombo-sacrale. Ilprimo sintomo è il dolore spinale; successivamente possono comparire i deficit neurologici che variano secondo la sede colpita, l’en-tità del processo infiammatorio, la presenza di altri siti d’infezione (discospondiliti multifocali). Il 30% dei pazienti presenta abbatti-mento, anoressia, piressia. L’indagine radiografica è solitamente diagnostica. Il trattamento medico comprende terapia antibiotica pro-tratta, analgesici, antinfiammatori e cage rest. Il trattamento fisioterapico, indicato per i pazienti più gravemente colpiti, può essere in-trapreso dopo una risposta positiva al trattamento medico.3 Si devono avere particolari cautele nell’esercizio riabilitativo perché la pa-tologia può causare fragilità ossea e significativa instabilità a livello delle vertebre colpite. Descrizione del caso. Un Golden Retriever femmina di 7 mesi in seguito ad investimento automobilistico ha riportato lussa-zione dell’anca e diastasi sacro-iliaca a sinistra, frattura del ramo craniale destro del pube, diastasi ischiatica. L’ecografia addo-minale evidenziava la presenza di un ematoma in sede retroperitoneale sinistra e di formazioni iperecogene endovescicali, com-patibili con ematuria post-traumatica. La lussazione d’anca, recidivata dopo riduzione incruenta, è stata trattata con tecnica diricostruzione capsulo-legamentosa utilizzando come ancoraggio al corpo dell’ileo una vite Imex 3,5. Si è optato per il tratta-mento conservativo delle altre lesioni. Nel postoperatorio si somministrava piperacillina 30 mg/kg tid IM e meloxicam (Meta-cam®) 0,1 mg/kg sid. 8 giorni dopo il trauma si iniziavano ad applicare crioterapia, magnetoterapia, chinesiterapia passiva e TE-CAR® terapia. Obiettivi principali in questa fase erano il controllo del dolore, la risoluzione dell’iniziale stato di contrattura delmuscolo quadricipite femorale sinistro e il trattamento dell’ematoma post-traumatico che occupava il piatto mediale della co-scia sinistra. 13 giorni dopo il trauma il paziente veniva dimesso con una zoppia di secondo grado sul posteriore sinistro e undecorso clinico in progressivo miglioramento. 35 giorni dopo il trauma il cane manifestava insorgenza acuta di paraparesi nondeambulatoria con plegia dell’arto posteriore sinistro. L’esame neurologico evidenziava dolore diffuso alla palpazione del ra-chide, marcata iporiflessia bilaterale del patellare e dell’ischiatico, riduzione del riflesso flessore posteriore destro, assenza delriflesso flessore posteriore sinistro. La radiografia latero-laterale del tratto lombare consentiva di diagnosticare una discospon-dilite nello spazio intersomatico L3-L4. Si prescriveva una terapia con cefalessina (Icf Vet®) 20 mg/Kg bid., un’associazione dimetronidazolo e spiramicina (Stomorgyl®) 12,5 mg/kg + 75000 UI/kg sid per 20 giorni e meloxicam 0,05 mg/kg sid per 30 gior-ni. Il protocollo riabilitativo ha previsto per i primi 15 giorni elettrostimolazione sul gruppo posteriore della coscia e sul qua-dricipite di entrambi gli arti e 2 sedute quotidiane per ogni arto di chinesiterapia passiva e stimolo del riflesso flessore.Sulla base dei miglioramenti clinici si decideva a partire dal 16° giorno di cessare l’applicazione dell’elettrostimolazione e in-tegrare il programma riabilitativo con esercizi attivi e deambulazione assistita in underwater treadmill. Dopo 35 giorni di riabi-litazione, nonostante la permanenza di deficit posturali e deambulatori (deviazione in cifosi e scoliosi del rachide, ipometria po-steriore sinistra), il paziente veniva dimesso con un ottimo grado di recupero. Si prescrivevano al proprietario massaggi, chine-siterapia passiva ed esercizi attivi mirati a migliorare la postura del cane ed implementare l’utilizzo degli arti posteriori. Con se-dute settimanali di agopuntura ci si prefiggeva l’obiettivo di ridurre le contratture muscolari dei mm. paravertebrali. Si conclu-deva il programma fisioterapico con 6 sedute (2/settimana) di idroterapia in underwater treadmill precedute dall’applicazione diultrasuonoterapia per preparare all’esercizio la muscolatura dell’arto posteriore sinistro. Il controllo radiografico al 75° giornorivelava la fusione dei corpi vertebrali di L3 e L4. La terapia antibiotica con cefalessina veniva sospesa al 100° giorno di som-ministrazione. Le visite cliniche ad 1, 3 e 6 mesi dopo la dimissione testimoniano un recupero funzionale completo. Conclusioni. I punti fondamentali per la riuscita della riabilitazione del paziente sono stati la capacità di identificare ogni defi-cit (sia di carattere ortopedico che neurologico) e la possibilità di risolvere con molteplici tecniche la condizione clinica nellasua interezza e complessità.
Bibliografia
1. Vandevelde M, Jaggy A, Lang J: Neurologia Veterinaria. Ed. Masson/EV, 2003.2. Schubert M, Schär G, Curt A, Dietz V. Aspergillus spondylodiscitis in an immunocompetent paraplegic patient. Spinal Cord. 1998, 36; Nov (11); 800-3.3. D. Levine, R.A. Taylor, D.L. Millis: Canine rehabilitation and physical therapy. Philadelphia, WB Saunders Co, 2004.
Indirizzo per corrispondenza:Dott. Carlo Miola - Via Lanzo 4/A - Fr. Monasterolo Torinese, 10070 Cafasse (TO), ITALIA Cell. 3384696670 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
575
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
UTILIZZO PRATICO NEL GATTO DI UN SUPPLEMENTO NUTRIZIONALE PER L’INVECCHIAMENTO CEREBRALE. STUDIO OSSERVAZIONALE
MULTICENTRICO RETROSPETTIVO
A. Miolo, Dr1
1 CeDIS Innovet, Saccolongo (Pd), Italia
Area di interesse: Medicina comportamentale
Scopo del lavoro. Oggi si stima che in Italia vivano circa 8 milioni di gatti. Assumendo che il nostro Paese si comporti come il restod’Europa, i cosiddetti “senior” rappresentano il 30% del totale1, cioè 2,5 milioni. Pur non essendo di per sé una malattia, l’invecchia-mento riduce le capacità omeostatiche dell’organismo, e può esitare in alterazioni cliniche e comportamentali, legate, queste ultime, aprocessi neurodegenerativi2. Come il cane, anche il gatto anziano può, infatti, manifestare disordini comportamentali, emozionali e/o co-gnitivi legati all’invecchiamento cerebrale3. In Italia, da qualche anno è disponibile un supplemento nutrizionale ad attività neuroprotet-tiva [*], contenente sostanze di origine naturale (fosfatidilserina, ginkgo biloba, resveratrolo), in grado di rallentare specifici processi neu-rodegenerativi, come lo stress ossidativo, la ridotta fluidità di membrana, la deposizione di beta-amiloide4-6. Studi sperimentali e cliniciconfermano l’effetto neuroprotettivo esercitato da queste sostanze nel cane anziano con deficit cognitivi età-correlati7,8. Scopo del pre-sente studio osservazionale è quello di ottenere indicazioni post-marketing sull’utilizzo pratico nel gatto del supplemento in studio e, inparticolare, di acquisire informazioni sulla sua sicurezza di impiego nell’anziano. Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto con disegno retrospettivo osservazionale ed ha coinvolto 8 ambulatori veterina-ri, distribuiti sul territorio nazionale. Il responsabile di ciascun centro ha compilato una scheda di raccolta dati per ogni gattotrattato con il prodotto in esame. La scheda di raccolta dati si componeva di 5 sezioni: (I) segnalamento, (II) tollerabilità gene-rica, (III) eventi avversi (EA), (IV) soddisfazione dei risultati, (V) difficoltà di somministrazione. Risultati. Sono state raccolte complessivamente 57 schede per altrettanti gatti trattati con il prodotto in esame (23 femmine e 34maschi). La distribuzione delle razze era la seguente: 30 Europeo; 8 Siamese; 14 Persiano; 5 Certosino. L’età media era 14,6 anni;solo 4 soggetti (7%) avevano meno di 8 anni; tutti gli altri avevano età compresa tra 8 e 20 anni. Nel 32% dei casi (18/57), il pro-dotto veniva prescritto per segni clinici di invecchiamento cerebrale. Nel 30% dei casi (17/57), il prodotto veniva utilizzato a sco-po preventivo, in corso di visita sanitaria di controllo. La dose utilizzata corrispondeva a quella consigliata dal produttore (1cps/die). La durata del trattamento variava da 3 settimane a 3 anni. In 2 casi il trattamento veniva somministrato continuativamen-te; in tutti gli altri casi, il protocollo prevedeva o cicli ripetuti (45,5%, 25/55) o singoli periodi di trattamento (54,5%, 30/55), ri-spettivamente della durata media di 37 e 70 giorni. Nel 98% dei casi, il trattamento veniva ben tollerato. Nel 94% dei casi, non siregistrava l’insorgenza di alcun evento avverso (EA). In tutti i casi tranne 1 (98,2%), il veterinario si diceva soddisfatto dei risulta-ti ottenuti. Inoltre, a detta del veterinario, il proprietario manifestava soddisfazione per l’effetto del trattamento nel 96,5% dei casi.In 24 casi, si riferiva che il proprietario non aveva incontrato difficoltà di somministrazione. Nei rimanenti 33 casi, si segnalavanodifficoltà inerenti il tipo di somministrazione o l’appetibilità della formulazione. Nel 73% di questi casi, la difficoltà veniva supe-rata coprendo il gusto del prodotto con alimenti particolarmente graditi al gatto, come pasta di acciughe o paté di tonno. Conclusioni. Il presente studio retrospettivo di tipo osservazionale ha consentito di ottenere indicazioni sull’attuale uso nella praticaclinica del prodotto in esame, specificatamente nel gatto. In accordo con le indicazioni, il supplemento nutrizionale risultava usato pre-valentemente nel gatto anziano, per prevenire e/o coadiuvare il trattamento di disturbi cognitivo-comportamentali legati all’invecchia-mento. La palatability è risultata facilmente migliorabile con l’aggiunta di alimenti gradevoli al gatto. Oltre il 95% dei veterinari e deiproprietari si è dimostrato soddisfatto dei risultati ottenuti. Infine, il prodotto è risultato sicuro e ben tollerato, come testimonia la bas-sa frequenza di EA rilevati, cioè di qualsivoglia evento clinico dannoso che si manifesta in un soggetto trattato e che non ha necessa-riamente un rapporto causale con il trattamento. L’elevato profilo di sicurezza d’impiego emerso dal presente studio rappresenta un da-to di notevole importanza, stante la fragilità insita nel gatto anziano9, per ridotte capacità adattative, modifiche metaboliche che inter-feriscono con la clearance dei farmaci e potenziale presenza di malattie croniche concomitanti.
Bibliografia1. Gunn-Moore D. J Small Anim Pract 47:430-1, 2006 2. Head E et al. Neurobiol Aging 26:749-63, 20053. Gunn-Moore D et al. J Small Anim Pract 48:546-53, 20074. Augustin S et al. Arch Biochem Biophys 481:177-82, 20095. de Almeida LM et al. Arch Biochem Biophys 480:27-32, 20086. Osella MC et al. J Vet Behav 3:41-51, 20087. Araujo JA et al. Can Vet J 49:379-85, 20088. Colangeli R et al. Veterinaria 19(4) Suppl:13-8, 20059. Richards JR et al. J Feline Med Surg. 7:3-32, 2005
Si ringraziano per la fattiva collaborazione i seguenti medici veterinari: Sorrentino E, Li Vecchi L, Piccoli G, Genghini G, Pa-gotto M, Valsassina B, De Leone V, Polese L.
[*] Senilife®, Innovet Italia. www.senilife.com
Indirizzo per corrispondenza: Alda Miolo - CeDIS Innovet (Centro di Documentazione e Informazione Scientifica)Via Einaudi 13, I-35030 Saccolongo (Pd), Italy - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
576
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
577
OMOTOSSICOLOGIA E FLORITERAPIA DI BACH IN UN CASO DI DISBIOSI INTESTINALE E SINDROME DA MALASSORBIMENTO AD EZIOLOGIA POLIFATTORIALE
S. Negrini, PhD, Med Vet, Dipl AIOT1
1 Ambulatorio Veterinario Marco Polo, Bologna, Italy
Area di interesse: Medicina non convenzionale
Introduzione. Viene proposto un protocollo di medicina non convenzionale per la gestione di un paziente affetto da disbiosi in-testinale e sindrome da malassorbimento ad eziologia polifattoriale. Descrizione del caso. Alex, cane meticcio maschio, di circa 2 anni d’età, regolarmente vaccinato, manifesta fin dalla nascitascarso appetito ed episodi recidivanti di anoressia con comparsa di vomito progressivamente emorragico, abbattimento del sen-sorio e talvolta diarrea. Viene portato alla visita clinica in occasione di una recidiva della sintomatologia: le condizioni clinicheappaiono buone pur osservando una costituzione gracile e un dimagrimento pari a circa 1 kg rispetto al peso forma. Alex, ulti-mo di una cucciolata abbandonata alla nascita, non ha ricevuto il colostro materno ed è stato nutrito con latte artificiale per pu-ledri e svezzato con crema di farina di riso ed omogeneizzati per bambini. Attualmente viene alimentato primariamente con car-ne d’agnello, riso soffiato e yogurt bianco intero. Vari i tentativi terapeutici già intrapresi: diete privative, antibiotici, antiemeti-ci, gastroprotettori, procinetici, antispastici, antiparassitari, antiprotozoari e complessi polivitaminici; scarsi e di breve durata ibenefici ottenuti. Si procede con la diagnostica collaterale: esame coprologico negativo, conteggio ematico nella norma, profilobiochimico con moderate alterazioni della funzionalità epatica. L’ecografia addominale evidenzia una modica gastro-enterite. Siemette diagnosi di sindrome da malassorbimento e disbiosi intestinale. Il proprietario autorizza un protocollo terapeutico nonconvenzionale. L’inquadramento omotossicologico del paziente indica un quadro patologico di tipo funzionale collocabile nel-le fasi matrice di impregnazione; la periodica recidiva di sintomi acuti, tipici delle fasi umorali di escrezione ed infiammazione,sono interpretate come il tentativo dell’organismo di riattivare la propria reattività al fine di promuovere la guarigione. Per mo-dulare l’iper-reattività delle fasi acute vengono somministrati composti a bassa diluizione a base di Arnica Montana, Apis mel-lifica, Nux vomica, Colocynthis, Cuprum sulfuricum e Veratrum album. Più complesso l’iter terapeutico per la regolazione del-la patologia funzionale: si procede con un drenaggio tossinico a spiccata azione linfagoga e connettivale inserendo, inoltre, com-posti a bassa diluizione a base di Solidago e Berberis per promuovere l’attivazione dell’emuntorio renale e alleggerire il lavorodell’apparato gastro-enterico. Per un’azione ristrutturante del pancreas e della mucosa gastro-enterica vengono somministraticomposti semplici a base di Leptandra, Momordica balsamica e Podophyllum ed organoterapici ad azione specifica. Le altera-zioni della respirazione cellulare, tipiche delle fasi matrice e cellulari, sono compensate con la somministrazione di catalizzato-ri intermedi del ciclo di Krebs. Cardo mariano in formulazione fitoterapica, probiotici e dieta iperdigeribile completano il pro-tocollo terapeutico. Le terapie iniettabili, a frequenza giornaliera nelle fasi acute, sono state ridotte ad una sola somministrazio-ne settimanale nei 3 mesi successivi. Rapido il miglioramento dell’appetito e l’incremento del peso, tuttavia residuano saltuariepisodi di anoressia a remissione spontanea in 2-3 giorni. Si richiede di annotarne la periodicità e l’eventuale concomitanza consituazioni particolari: l’evento scatenante risulta l’assenza ricorrente di uno dei proprietari a cui il cane è particolarmente lega-to. Durante le visite mediche Alex si è sempre mostrato schivo ma remissivo, non si allontana dai proprietari dai quali richiedeed ottiene attenzione. Nella vita quotidiana manifesta un atteggiamento dominante ma anche numerose paure, a volte addirittu-ra fobie, responsabili di alterazioni repentine ed incontrollabili dell’umore e delle abitudini. Si completa il protocollo terapeuti-co con una prescrizione di rimedi floreali di E. Bach: dopo alcuni giorni di trattamento con Rescue Remedy, si prosegue conChicory, Heather, Walnut, Star of Bethlem e Honeysuckle. Viene inoltre applicato ad Alex un collare a lento rilascio di feromo-ni appaganti materni, formulazione che consente di beneficiare degli effetti positivi durante tutta la giornata, anche in ambientiesterni. Già dopo un breve periodo di terapia i problemi gastro-enterici di Alex si limitano al rifiuto del cibo durante le primeore di distacco dal proprietario e si risolvono spontaneamente con la richiesta del pasto. Dopo circa un anno dalla prima visitaAlex ha raggiunto un equilibrio psico-fisico soddisfacente e un peso forma adeguato alla taglia. Conclusioni. Esiste una correlazione tra stato d’animo e patologia d’organo: nel caso descritto la preoccupazione per gli affet-ti familiari impediva ai rimedi omotossicologici di esprime a pieno l’attività di riequilibrio dell’apparato gastro-enterico, indub-biamente minato da disordini immunologici e carenziali. L’utilizzo dei Fiori di Bach ha permesso di rimuovere lo stato d’ani-mo negativo che trova nei disturbi dell’asse stomaco-intestino la naturale somatizzazione, consentendo il ripristino dello statodi salute del paziente.
Bibliografia
Borino L. Anima-li e Fiori di Bach. Nova Scripta Edizioni, Genova, 2002 - Reckeweg HH. Materia Medica Omeopatica. 2a ed. italiana. GUNA Editore, Mila-no, 2002.
Indirizzo per corrispondenza:Dott.Ssa Stefania Negrini - Ambulatorio Veterinario Marco Polo - Via Marco Polo, 11/13 - 40131 Bologna (BO), Italy Tel. 051/6347848 - E-mail: [email protected]
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
TARGET-CONTROLLED INFUSION OF PROPOFOL FOR MONITORED ANAESTHESIA CARE IN A DOG
INFUSIONE DI PROPOFOL AD OBIETTIVO DI CONCENTRAZIONE PER LA SEDAZIONE DI UN CANE
L. Novello, Med Vet, Dip ESRA, MRCVS1, B. Carobbi, Med Vet, MRCVS1
1 Referenza Carobbi Novello, Venezia, Italia
Area di interesse: Anestesia
Introduction. Objective – To first report the use of a propofol target-controlled infusion (TCI) during monitored anaesthesia ca-re (MAC) in a dog. Study design – Clinical case report. Animal – A 2-year-old, male, Flatcoated Retriever dog, weighing 25 kg,scheduled for radiographic recheck examination of and external fixator removal from the right femur, and scored ASA I at pre-anaesthetic evaluation. Introduction – Intravenous anaesthetic and analgesic drugs produce dose-dependent depression of theCentral Nervous System in a continuum from minimal sedation (i.e. consciousness, relaxation) to deep sedation (i.e. uncon-sciousness), or general anaesthesia (i.e. lack of movement in response to painful stimuli).1 MAC consists of anaesthetics/anal-gesics administration and adequate patient monitoring by an anaesthetist to provide sedation during diagnostic and minor sur-gical procedures. Although in humans MAC has become the technique of choice for a variety of invasive and non-invasive pro-cedures since early 1990s,2 propofol TCI during MAC has not been reported in dogs. Description of the case. Methods – Forty minutes after acepromazine (0.25 mg) and morphine (3.75 mg) intramuscular admini-stration sedation was induced with intravenous (IV) propofol using a TCI system (CCIP, Hong Kong) implemented with propofolpharmacokinetics3 and pharmacodynamics4 in the dog. A 3.1 mcg ml-1 predicted plasma target concentration (Cpt) was achieved andloss-of-righting-reflex (LORR) assessed. Predicted effect-site concentration (Ce) at LORR was then targeted, and Cpt further de-creased until dog’s minimum sedative threshold providing lateral recumbency, relaxation and unresponsiveness was achieved. Seda-tion was assessed at 5-minute intervals using a modified OAA/S scale. Electrocardiogram, pulse oximetry, heart (HR) and respira-tory (RR) rates, respiratory pattern and direct arterial pressure were monitored continuously, and non-invasive arterial pressure at 1-minute intervals. Data were recorded continuously via a serial interface. Total infusion time and time to LORR, recovery-of-righting-reflex (RORR), standing and walking unassisted were recorded, and Ce calculated. Results – Prior to induction the dog was alert,standing and walking (OAA/S 5). During induction LORR (OAA/S 1) occurred at 2.0 mcg ml-1 Ce, and Cpt was decreased to 2.1,then to 1.9 mcg ml-1. During sternal recumbency for caudo-cranial radiograph of the femur the dog showed mild discomfort, inclu-ding mild vocalisation, head movements and a sudden increase in RR and arterial pressure. Cpt was temporarily increased to 2.4 mcgml-1, and fentanyl (0.05 mg) was administered IV over 60 seconds. At the end of radiographic examination Cpt was decreased to 1.8mcg ml-1, and the external fixator removed. At the end of the procedure the infusion was discontinued, and the dog recovered une-ventfully. Total infusion time was 54 minutes, and the total amount of propofol administered 22.7 ml (227 mg). Cpt was maintainedat 3.1, 2.4, 2.1, 1.9 and 1.8 mcg ml-1 for 1, 4, 17, 13 and 23 minutes respectively. Ce was 1.8 mcg ml-1 at RORR (OAA/S 2), 1.3 atstanding and walking unassisted (OAA/S 5), and 1.2 when the owner scored the dog’s behaviour as normal. The dog recovered theability to stand and walk unassisted, and was ready to be discharged in owner’s care 5 and 6 minutes after propofol infusion had beendiscontinued, respectively. Apart from a 15-second apnoea following induction, no respiratory depression was detected during theprocedure with the dog breathing room air. Monitored parameters were within normal limits. Conclusions. Propofol TCI was used safely to provide MAC in a dog undergoing non-invasive procedures. Titration to effectwas facilitated by the use of a modified OAA/S scale and resulted in a consistent plane of sedation. Analgesic administrationwas required to treat transient discomfort. Recovery from sedation was calm and quick, and no side effects or complications tothe procedure were noticed. Although in humans respiratory depression due to overdose of sedatives-hypnotics-analgesics is themost common cause of claims related to MAC, it has been suggested that complications can be prevented by adequate monito-ring, improved vigilance and titration to effect.2 In humans sedative doses of propofol have minimal depressant effects on ven-tilation,5 however it has not been confirmed in dogs. Although additive or synergistic effects on respiratory depression have beendemonstrated for propofol-opioid and midazolam-opioid associations, the incidence of hypoxemia is lower for the propofol-fen-tanyl combination.6 In addition, the administration of sedative drugs by carefully titrated infusions can minimize their respira-tory depressant effects.1
Clinical Relevance – Compared to other techniques, propofol TCI for MAC in dogs may offer the advantage of easy titration toeffect, cardiopulmonary stability, and shorter recovery and discharge times.
References
1. Sa Rego M, Watcha MF, White PF (1997) Anesth Analg 85,1020-10362. Bhananker SM, Posner KL, Cheney FW, et al (2006) Anesthesiology 104,228-2343. Beths T, Glen JB, Reid J, et al (2001) Vet Rec 148,198-2034. Rabozzi R and Novello L (2007) (Abstract) Veterinary Anaesthesia and Analgesia 34,1-165. Rosa G, Conti G, Orsi P, et al (1992) Acta Aneasthesiol Scand 36,128-1316. Monk TG, Boure B, White PF, et al (1991) Anesth Analg 72,616-621
Indirizzo per corrispondenza:Dott. Lorenzo Novello - Referenza Carobbi Novello - Via Meucci, 13 - 30016 Jesolo Paese (VE), Italia - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
578
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
L’EROSIONE COME CAUSA DI FALLIMENTO NEL TRATTAMENTO DI FCP ED OCD:RICONOSCIMENTO ARTROSCOPICO E TRATTAMENTO
M. Olivieri, PhD1,2, E. Ciliberto, PhD3, B. Peirone, PhD3
1 Professore a contratto, Università di Medicina Veterinaria,Torino, Italia2 Libero frofessionista, Samarate - Varese, Italia
3 Dipartimento di patologia animale, Università di Torino, Italia
Area di interesse: Ortopedia
Scopo del lavoro. La displasia del gomito rappresenta, nelle razze a rischio, una delle cause più frequenti di zoppia dell’arto an-teriore sia nei cani in accrescimento che in quelli adulti. Le lesioni associate alla displasia del gomito comprendono la fram-mentazione del processo coronoideo mediale dell’ulna (FCP), l’osteocondrite dissecante del condilo omerale mediale (OCD),l’incongruenza omero-radio-ulnare (INC) e la mancata unione del processo anconeo (UAP). Accanto a queste forme di displa-sia ben conosciute per la loro frequenza, ne esiste un’altra meno nota, conosciuta come “erosione” (ER)1-2. Questo tipo di le-sione coinvolge la superficie articolare del condilo omerale mediale e la corrispettiva porzione ulnare. In queste aree la cartila-gine presenta la completa esposizione dell’osso subcondrale2. In vari casi all’erosione si associa la presenza di FCP od OCD2.Riguardo l’erosione le informazioni a disposizione sulla patogenesi e sul trattamento sono ad oggi insufficienti e non esaurien-ti. In questo articolo gli autori hanno preso in considerazione 22 casi riferiti per persistenza della zoppia anteriore in seguito adintervento chirurgico per il trattamento di FCP o OCD. In questi casi, l’esame artroscopico del gomito in oggetto metteva in evi-denza la presenza di una lesione erosiva del comparto mediale. Scopo del presente lavoro è quello di verificare l’efficacia in que-ste lesioni di una osteotomia ulnare prossimale dinamizzante obliqua (DUO). Materiali e metodi. Sono state selezionate tutte le artroscopie di gomito eseguite dagli autori tra il 2001 e il 2005. Sono stati in-clusi nel presente studio i casi che avevano subito un intervento per FCP (15 casi) o OCD (7 casi) tra 2 e 3 mesi prima ma che nonavevano conseguito miglioramenti clinici. L’età dei soggetti era compresa tra 7 e 21 mesi, con una media di 12,5 mesi. Questi ca-ni sono stati sottoposti ad una valutazione clinica, radiografica ed un’artroscopia diagnostica, nel corso della quale si evidenziavain tutti i soggetti la copresenza di erosione. Infine tutti i cani sono stati trattati esclusivamente mediante DUO prossimale3. Sonostati invece esclusi i pazienti affetti da problemi ortopedici concomitanti a carico dello stesso arto e soprattutto quelli con sofferen-za cartilaginea del capitello radiale di grado I – IV. I controlli clinici e radiografici sono stati effettuati dopo 7, 30, 45 e 60 giorni.I successivi controlli si eseguivano ogni 30 giorni fino a consolidamento dell’osteotomia. Raggiunto il consolidamento i soggettivenivano ulteriormente valutati dopo 30 giorni, mentre nei casi in cui persisteva zoppia, venivano effettuati ulteriori controlli allostesso intervallo di tempo. Tutti i soggetti sono stati riesaminati dopo 6 mesi ed un anno dal consolidamento osseo. Risultati. Tra i 22 casi selezionati tutti presentavano, a giudizio dei proprietari, un grado di zoppia solo di poco migliorata ri-spetto alle condizioni precedenti l’intervento di rimozione dell’FCP o dell’OCD, che non tendeva a diminuire nel tempo e mo-dicamente responsiva a trattamenti medici. L’esame radiografico evidenziava artrosi in tutti i soggetti esaminati.L’esame artroscopico dimostrava la presenza costante di ER a livello della superficie articolare mediale dell’omero e di quellacorrispettiva ulnare. L’osteotomia è consolidata in 30 giorni in 2 casi, 45 in 1, 60 in 3 casi, 90 in 14 e infine 120 giorni in 2 ca-si. Ai controlli clinici gli animali mostravano un completo recupero funzionale dell’arto a 90 gg dall’intervento in 4 casi, 120 ggin 14 e 150 gg in 2, mentre 2 casi manifestavano ancora zoppia di II grado dopo 180 gg. Dopo 6 mesi ed 1 anno dall’intervento, in 20 casi si evidenziava l’assenza di sintomatologia, mentre nei due soggetti che pre-sentavano ancora zoppia a 6 mesi essa persisteva, dopo altri 6 mesi, in un caso di primo grado, mentre l’altro soggetto manife-stava una zoppia persistente di 2° grado. Conclusioni. Sulla base della presente esperienza gli autori considerano che una delle possibilità che può determinare un in-successo terapeutico nella gestione di FCP ed OCD possa essere l’erosione2. Confermata la sua presenza in artroscopia la DUOprossimale, nel presente lavoro, ha permesso un recupero totale in 20 casi su 22. Poiché questa procedura implica per tutta lafase della guarigione dell’osteotomia un sovraccarico del capitello radiale, è molto importante escludere un coinvolgimento car-tilagineo dello stesso onde evitare complicanze potenzialmente irreversibili (esposizione dell’osso subcondrale sul capitello ra-diale). Inoltre, poiché l’osteotomia prossimale dell’ulna comporta una certa morbidità con peggioramento della zoppia fino alconsolidamento del callo osseo, i proprietari devono esserne informati e consapevoli.
Bibliografia
1. Voorhout G.et all: Radiographic evaluation of the canine elbow joint with special reference to the medial humeral condyle and the medial coronoid pro-cess. Vet Radiol 1987. 28(5): 158-165
2. Schulz KS, et all Cartilage erosions in “Canine elbow displasia” 1949 - 1950, Slatter vol. 2, 2003 Saunders3. Olivieri M. et all: preliminary results of arthroscopic diagnosis and treatment of elbow humero-ulnar conflict (cartilage erosion) through proximal ulnar
osteotomy. Atti ESVOT Monaco 2006
Indirizzo per corrispondenza:Dott. Massimo Olivieri - Via Gorizia 57 - 21010 Ferno (VA), ItaliaTel. 0331/228155 - Cell. 349/4006903 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
579
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
SYSTEMIC MYCOSIS DUE TO FUSARIOSIS IN A DOG
A. Pain, DVM1, A. Diquelou, DVM, PhD2
1 Dept. of Internal Medicine, Toulouse, France2 Dept. of Internal Medicine, Toulouse, France
Topic: Internal Medicine
Introduction. Fusariosis is an emerging problem with poor prognosis in the immunocompromised human patients. Fungal in-fection not uncommon in the German shepherd dog is believed to be due to the presence of an immunocompromised state. Theyare thought to have a primary defect in IgA metabolism. We describe here the second case of intracranial fusariosis in this breed. Description of the case. A 3 year old female intact German shepherd crossbreed dog was evaluated at the National VeterinarySchool of Toulouse for seizures and ataxia of 6 months duration. Meningoencephalitis was suspected by the referring veteri-narian, based on clinical signs and multifocal contrast enhancing lesions in the right cerebral hemisphere found on CT scan.Immunosuppressive corticosteroids had been administered for 3 weeks before presentation without significant clinical improve-ment. Clinical examination revealed hepatomegaly, splenomegaly and markedly enlarged peripheral lymph nodes. Fine needleaspiration of these organs revealed numerous septate hyphae, without further possible fungus identification. The dog was ad-ministered itraconazole (5 mg/kg PO BID) to treat systemic mycosis and corticosteroids were decreased. On reevaluation twomonths later, the dog’s condition had improved, but splenic fungal infiltrate was still present. Owing to poor prognosis and treat-ment cost, euthanasia was elicited. Necropsy revealed numerous pyogranulomatous and necrotizing foci containing fungal hy-phae distributed throughout the spleen, lymph nodes, cerebellum, cerebral hemisphere and meninges. Fusarium spp was furtheridentified by immunohistochemistry. Conclusions. To our knowledge, this is the second documented case of central nervous system infection by a member of theFusarium genera and the first one in Europe. Clinicians should consider Fusariosis in their differential diagnosis when neuro-logic clinical signs are observed. Culture and immunohistochemistry performed on biopsies can be used to identify the etiolog-ic agent and help to choose the appropriate treatment.
Bibliography
1. EVANS, J., LEVESQUE, D., DE LAHUNTA, A. & JENSEN, H. E. (2004) Intracranial fusariosis: a novel cause of fungal meningoencephalitis in a dog.Vet Pathol 41, 510-514
2. SCHULTZ, R. M., JOHNSON, E. G., WISNER, E. R., BROWN, N. A., BYRNE, B. A. & SYKES, J. E. (2008) Clinicopathologic and diagnostic ima-ging characteristics of systemic aspergillosis in 30 dogs. J Vet Intern Med 22, 851-859
3. STANZANI, M., TUMIETTO, F., VIANELLI, N. & BACCARANI, M. (2007) Update on the treatment of disseminated fusariosis: Focus on voricona-zole. Ther Clin Risk Manag 3, 1165-1173
Corresponding Address:Ms. Amélie Pain - Department of Clinical Sciences, National Veterinary School of Toulouse, 23 Chemin Des Capelles Bp 8761431076 Toulouse, Francia - Phone +33 (05) 61 19 32 99 - Mobile +33 (06) 12 57 26 23 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
580
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
UTILIZZO DELLO STUDIO ELETTROFISIOLOGICO PER LA DIAGNOSI DELLE TACHICARDIE AQRS STRETTI NEL CANE: STUDIO RETROSPETTIVO SU 47 CASI
R. Santilli, Dr Med. Vet. Dipl. ECVIM-CA (Cardiology)1, M. Perego, Dr Med. Vet.1, A. Perini, Dr Med. Vet. PhD1,S. Scarso, Dr Med. Vet.1, G. Spadacini, Dr Med.2, P. Moretti, Dr Med.2
1 Clinica Veterinaria Malpensa, Samarate (VA), Italia2 Istituto Clinico Mater Domini, Castellanza (VA), Italia
Area di interesse: Cardiologia
Scopo del lavoro. Lo scopo del lavoro è stato quello di descrivere il meccanismo elettrofisiologico ed il sito di origine delle ta-chicardie a complessi QRS stretti nel cane attraverso l’analisi degli elettrocardiogrammi endocavitari e la risposta alla stimola-zione programmata. Materiali e metodi. Nel presente studio retrospettivo sono stati inclusi 47 cani in cui è stato eseguito uno SEF nel periodo com-preso tra gennaio 2004 e dicembre 2008. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a visita clinica, elettrocardiogramma di superficiea dodici derivate, Rx torace ed ecocardiografia. In tutti i soggetti, sottoposti ad anestesia generale (propofol 4 mg/kg in bolo adeffetto seguito da isofluorano ed ossigeno 100%) sono stati inseriti, mediante la tecnica del Seldinger, tre introduttori (7F) di cuiuno a livello di vena giugulare esterna destra e due a livello di vena femorale destra. Un elettrocatetere decapolare è stato posi-zionato a livello di seno coronarico, un elettrocaterere quadripolare a livello di triangolo di Koch in corrispondenza dell’emer-genza del fascio di His ed un elettrocatetere ablatore in diverse sedi a seconda del disturbo del ritmo sospettato. Risultati. Il gruppo di studio era costituito da 47 soggetti di cui 39 maschi (83%) e 8 femmine (17%) appartenenti alle seguen-ti razze: Labrador (25,5%), Boxer (8,5%), meticcio (8,5%), Alano (6,4%), Dogue de Bordeaux (6,4%), altre razze (44,7%), conun’età media di 2,9±2,9 anni e con un peso medio di 34±2,8 kg. Lo SEF basale ha consentito di definire i punti di Wenckebachatrioventricolare anterogrado e retrogrado riferibili rispettivamente a valori di 195,5±34,86 ms e 296,25±74,82 ms, la durata delperiodo di refrattarietà effettivo del nodo atrioventricolare anterogrado e retrogrado riferibili rispettivamente a valori di175±33,62 ms e 269±71,4 ms ed i tempi di conduzione atrio nodale ed intranodale (AH) ed intraventricolare (HV) rispettiva-mente di 68,76±16,71 ms e 29,95±10,62 ms. I disturbi del ritmo diagnosticati nel campione preso in esame comprendevano: ta-chicardia atrioventricolare ortodromica reciprocante (34,4%), tachicardia atriale focale (21,4%), fibrillazione atriale (14,8%) ta-chicardia giunzionale focale (6,4%), tachicardia ventricolare di origine Hissiana (4,2%), flutter atriale (4,2%), tachicardia atria-le multifocale (2,0%), tachicardia nodale reciprocante (2,0%). Nel 10,6% dei soggetti non è stato possibile effettuare diagnosidel disturbo del ritmo. Durante SEF è stato inoltre possibile localizzare l’esatta sede di inserzione delle vie accessorie atrioven-tricolari causa delle tachicardie atrioventricolari ortodromiche reciprocanti e l’esatta posizione del focolaio ectopico atriale adesaltato automatismo anormale causa delle tachicardie atriali focali. In particolare, la sede delle vie accessorie atrioventricolariè stata definita postero-settale destra in 6/16 casi, posteriore destra in 3/16 casi, postero-laterale destra in 4/16 casi e medio-set-tale in 1/16 casi. In 2/16 casi è stata diagnosticata la presenza di vie accessorie atrioventricolari multiple. I focolai ad esaltatoautomatismo anormale erano invece situati in corrispondenza della cresta terminale in 7/10 casi, dell’emergenza delle vene pol-monari in 2/10 casi e dell’ostio del seno coronarico in 1/10 casi. In due soggetti è stato diagnosticato un flutter atriale dipen-dente dall’istmo di Cosio che in un caso presentava direzione antioraria (flutter atriale tipico) ed in un caso direzione antioraria(flutter atriale tipico inverso). Nel nostro studio le complicanze secondarie allo SEF sono state rappresentate da un decesso in-tra-operatorio in un soggetto affetto da tachicardia atriale focale complicata da un grave quadro ipocinetico-dilatativo tachicar-dia-indotto. Conclusioni. Lo SEF ha permesso la definizione del disturbo del ritmo nell’89,4% dei soggetti inclusi nel gruppo di studio. So-lamente nel 10,6% dei casi non è stato possibile effettuare la diagnosi del disturbo del ritmo a causa dell’impossibilità di indur-re la tachicardia durante SEF. Analizzando la sede di inserrzione delle vie accessorie causa della tachicardia atrioventricolare or-todromica reciprocante emerge che, al contrario rispetto ai dati riportati in medicina umana, nel cane la sede di inserzione è pre-valentemente localizzata a livello atrio-ventricolare destro. La sede dei focolai con esaltato automatismo anormale è invece pre-valentemente localizzata a livello del tetto dell’atrio destro in corrispondenza della cresta terminale. Le complicanze, similmenteai dati riportati in letteratura umana, sono intervenite in una minima percentuale di casi (1/47). In accordo con i dati emersi daquesto studio il mappaggio endocavitario rappresenta lo strumento diagnostico d’elezione per la diagnosi delle tachicardie acomplessi QRS stretti anche nel cane.
Bibliografia
Santilli RA, Spadacini G, Moretti P, et al Anatomic distribution and electrophysiologic properties of accessory atrioventricular pathways in dogs.J Am Vet MedAssoc. 2007 1;231(3):393-8
Chang SL, Tai CT, Lin YJ, et al. Electrophysiological characteristics and catheter ablation in patients with paroxysmal supraventricular tachycardia and pa-roxysmal atrial fibrillation. J Cardiovasc Electrophysiol. 2008 Apr;19(4):367-73.
Jacobson C. Narrow QRS complex tachycardias. AACN Adv Crit Care. 2007 Jul-Sep;18(3):264-74
Indirizzo per corrispondenza:Dott.Ssa Manuela Perego - Clinica Vetrinaria Malpensa - Via MArconi, 27 - 21017 Samarate (VA), Italia Tel. 0331/228155 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
581
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
GESTIONE ANESTESIOLOGICA PERIOPERATORIA IN CORSO DI CRANIOTOMIA PER ASPORTAZIONE DI UN MENINGIOMA DEL LOBO OLFATTORIO
A. Perini, med vet, dottore di ricerca1, F. Masera, med vet1, R. Lombardo, med vet, Dipl Acvim (neurology), dipl ecvm2
1 libero professionista, Samarate, Italia2 Università di veterinaria, dipartimento scienze clinche, sez chirurgia, Milano, Italia
Area di interesse: Anestesia
Introduzione. La chirurgia intracranica richiede un’attenta gestione anestesiologica, atta a mantenere nei limiti di riferimentola pressione arteriosa e l’ETCO2, per evitare un aumento della pressione intracranica. La maggior parte dei farmaci anesteticipuò determinare le suddette alterazioni e ridurre la normale risposta di autoregolazione del SNC. La scelta del protocollo ane-stesiologico deve essere effettuata cercando di evitare l’eventuale stimolazione di tosse in seguito all’intubazione ed all’estuba-zione orotracheale, mantenere la pressione arteriosa media tra 60-100 mmHg e la ETCO2 non superiore a 35 mmHg; dopo lafine dell’intervento può essere necessario ottenere un risveglio lento e dolce per evitare un incremento acuto della pressione ar-teriosa. Descrizione del caso. Cane, “India”, meticcio, femmina, 11 aa, 30 kg è stata sottoposta ad intervento di craniotomia, per aspor-tazione di un meningioma del lobo olfattorio. Prima dell’intervento chirurgico è stato eseguito EOG, profilo ematologico e bio-chimico. La premedicazione è stata eseguita con metadone 6 mg (0,2 mg/kg) IM, all’induzione è stato somministrato fentanil60 mcg (2 mcg/kg) EV in 3 minuti e propofol 160 mg EV (5,3 mg/kg); il paziente è stato ventilato manualmente. È stato posi-zionato un catetere nell’arteria metatarsale per la misurazione della pressione arteriosa invasiva. È stata somministrata per viaendovenosa una soluzione di ringer acetato a 2 ml/kg/h. L’anestesia è stata mantenuta con isofluorano a concentrazione di fineespirazione compresa tra 1,1% e 1,7% (questa ultima concentrazione è stata mantenuta solo per pochi minuti) e fentanil TCI(target controlled infusion, Tadashi VAA 2005 dogs) a concentrazione plasmatica tra 1,2-1,3 ng/ml; è stato utilizzato un circui-to circolare con O2 al 100% a 500 ml/min. Prima dell’inizio della chirurgia è stato somministrato atracurio 0,2 mg/kg EV ed ilpaziente è stato sottoposto a IPPV, impostando parametri di frequenza e profondità respiratorie tali da mantenere l’ETCO2 en-tro i limiti desiderati (32-33 mmHg). La SpO2 durante tutta la durata della chirurgia è stata tra 98% e 100%. La pressione arteriosa media è variata da un massimo di 94 mmHg ad un minimo di 63 mmHg. Al momento dell’incisione è sta-to somministrato mannitolo 1 gr/kg EV. L’intervento chirurgico è durato 4 ore, alla fine delle quali il piano di anestesia è stato re-so più superficiale diminuendo le concentrazioni di isofluorano e fentanil TCI. Dopo 1,5 h dal termine della chirurgia sono statesospese sia la ventilazione meccanica che la TCI di fentanil ed è stato somministrato metadone alla dose di 0,15 mg/kg IM; la ri-presa dell’attività respiratoria spontanea è stata rapida e non ha determinato un aumento dell’ETCO2. A distanza di 1 h e 45 mindalla fine dell’intervento l’isofluorano è stato sospeso e dopo ulteriori 15 minuti si è provveduto a estubare il paziente. Contem-poraneamente si è iniziata l’infusione di propofol TCI (Beths Vet Rec 2001) a concentrazione al sito effettore di 3 mcg/ml. Il pas-saggio dall’anestesia generale alla sedazione profonda è stato dolce e graduale; durante tutto il periodo di somministrazione dipropofol TCI sono stati mantenuti i monitoraggi di frequenza cardiaca tramite ECG, di pressione arteriosa invasiva e di SpO2 inmaniera continua, mentre ogni ora veniva eseguito un emogasanalisi arterioso come monitoraggio della PaCO2. Dopo 3 h di in-fusione a 3 mcg/ml la pressione arteriosa aveva iniziato ad aumentare in modo lieve ma costante fino a superare il limite deside-rato. È stato quindi somministrato, contestualmente al propofol TCI, fentanil 1 mcg/kg EV seguito da CRI a 2 mcg/kg/h, che hadeterminato un ritorno della pressione arteriosa entro i valori desiderati. Dopo 12 h dal termine dell’intervento chirurgico sonostate interrotte sia la somministrazione di propofol che quella di fentanil; dopo ulteriori 45 minuti c’è stato il risveglio. Si è deci-so di mantenere in sedazione il paziente per evitare la reattività a stimoli esterni, potenziale causa di aumento della pressione ar-teriosa e delle conseguenti complicanze. Nei giorni seguenti le condizioni cliniche erano stabili e le dimissioni sono avvenute aduna settimana dall’intervento. Al momento della stesura di questo lavoro il paziente è in buone condizioni generali. Conclusioni. Sebbene le indicazioni in letteratura propongano un protocollo anestesiologico in parte differente dal nostro, tuttigli obiettivi dettati dalle linee guida sono stati rispettati. La bibliografia attualmente disponibile indica nel propofol il farmacodi mantenimento d’elezione, in quanto preserva la reattività alla CO2 e l’autoregolazione cerebrale. Considerando la possibilitàdi un monitoraggio dei parametri sensibili continua ed accurata si è preferito impiegare quale farmaco di mantenimento l’iso-fluorano. I risultati da noi ottenuti sono coerenti con le indicazioni bibliografiche, relative ad una gestione ottimale dell’aneste-sia in corso di chirurgia intracranica
BibliografiaA.L.Raisi et Coll “evaluation of an anaesthetic technique used in dogs undergoing craniectomy for tumor resection”Veterinary Anaesthesia and Analgesia 2007,34,171-180F.Corletto “Anestesia in neurochirurgia” 48° congresso Nazionale Multisala SCIVACK.E.Joubert et Coll “ A retrospective case series of computer-controlled total intravenous anaesthesia in dogs presented for neurosurgery” S.Afr.vet.Ass 2004
75(2) 85-89
Indirizzo per corrispondenza:Dott. Alberto Perini - Clinica Veterinaria Malpensa - Via Marconi 27 - 21017 Samarate (VA), Italia Tel. 0331228155 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
582
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
RICERCA DI FHV-1 IN GATTI CON DERMATITI ULCERATIVE E MALATTIE CORRELABILI AL COMPLESSO DEL GRANULOMA EOSINOFILICO CON ISTOPATOLOGIA,
POLYMERASE CHAIN REACTION E IMMUNOISTOCHIMICA
P. Persico, DVM1, P. Roccabianca, DVM, PhD, Dip. ECVP2, A. Vercelli, DVM, Dip. CES3,L. Cornegliani, DVM, Dip. ECVD3
1 Libero professionista, Milano, Italia2 Istituto di Anatomia Patologica e Patologia Aviare, Dipartimento di Patologia Animale,
Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, Facoltà di Medicina Veterinaria, Milano, Italia3 Liberi professionisti, Torino, Italia
Area di interesse: Dermatologia
Scopo del lavoro. Paragonare sensibilità e specificità di istopatologia, immunoistochimica e polymerase chain reaction (PCR)nella diagnosi di dermatite herpetica da biopsie cutanee feline ottenute da dermatiti ulcerative e malattie correlabili al comples-so del granuloma eosinofilico in cui non si evidenzino corpi inclusi da herpes virus felino tipo-1 (FHV-1). Materiali e metodi. Sono state selezionate 64 biopsie cutanee, provenienti da 55 gatti comuni europei, 6 persiani, 1 certosino e 1bengala, tutti con età compresa tra 8 mesi e 17 anni. 39 gatti erano di sesso maschile (14 castrati) e 24 di sesso femminile (6 steri-lizzate). 40 campioni provenivano dalla regione testa/collo/cavo orale, 8 da arti/polpastrelli e 16 da aree non specificate. Non eranota la presenza di malattie sistemiche o sieropositività tranne che in 3 casi (FIV+, Felv+ e diabete). Le biopsie incluse nello stu-dio presentavano un quadro istopatologico compatibile con malattie correlabili al complesso del granuloma eosinofilico e dermati-ti ulcerative. Su tutte le sezioni, già allestite con ematosillina eosina, sono state eseguite le colorazioni Periodic Acid Schif, Ziehl-Neelsen e Gram. I campioni sono stati anche osservati al microscopio con luce polarizzata. Immunoistochimica: sono state utiliz-zate sezioni di 5 micron per valutare l’espressione antigenica virale con un anticorpo monoclonale anti-FHV-1 (Custom Monoclo-nals Int, diluizione 1:150). PCR: sono state utilizzate sezioni di 25 micron per estrarre ed amplificare il DNA tramite primer FHV-1-forward 5’ TGTCCGCATTTACATAGATGG 3’; FHV-1-reverse 3’ GGGGTGTTCCTCACATACAA 5’. Risultati. Delle 64 sezioni istologiche esaminate la PCR ha evidenziato 12 campioni positivi, 10 provenienti da gatti con ma-lattie correlabili al complesso del granuloma eosinofilico e 2 da gatti con dermatite ulcerativa. Tutti i campioni positivi prove-nivano dalla regione testa/cavo orale. I soggetti risultati positivi erano 3 maschi, 5 maschi castrati, 4 femmine intere e la loro etàera compresa tra i 9 mesi e i 9 anni. L’immunoistochimica è risultata debolmente positiva in 2 dei 12 campioni precedentemen-te positivi alla PCR mentre le altre 62 biopsie erano negative. Conclusioni. FHV-1 provoca lesioni erosivo-ulcerative e crostose con quadri clinici ed istologici sovrapponibili a forme di iper-sensibilità al morso d’insetti e a malattie allergiche del gruppo del granuloma eosinofilico. I reperti microscopici non sono dia-gnostici ad eccezione del riscontro di corpi inclusi intranucleari. Risulta importante formulare una diagnosi corretta per non ef-fettuare trattamenti farmacologici immunosopressivi. La PCR è considerata il metodo di elezione per valutare la presenza diFHV-1. Tuttavia l’uso della PCR in gatti che presentano dermatiti facciali in cui si sospetta un’eziologia virale ha diversi limi-ti. Spesso nel siero sono presenti anticorpi che non permettono di differenziare l’infezione virale vera dalla risposta al virus at-tenuato. L’integrazione del DNA virale con il DNA cellulare dell’ospite non permette di distinguere tra infezione attiva e statodi portatore. La sensibilità varia secondo il tipo di PCR impiegata e questo può essere uno dei motivi della discordanza nei ri-sultati ottenuti con i due metodi di analisi. L’immunoistochimica è considerata un metodo diagnostico molto sensibile, ma puòdare dei risultati falsi positivi in corso d’infezioni croniche. Dal nostro studio emerge che l’impiego di PCR e immunoistochi-mica, correlate alla clinica e all’anamnesi, possono essere d’aiuto nei casi in cui si sospetta la presenza di FHV-1 in campioniistologici caratterizzati da quadri sovrapponibili a forme d’ipersensibilità al morso d’insetti e a malattie allergiche del gruppodel granuloma eosinofilico.
Bibliografia
1. Gaskell R, Dawson S, Radford A, et all: Feline herpesvirus. Vet Res 38 (2): 337-54, 2007.2. Gross TL, Ihrke PJ, Walder EJ, Affolter VK: Ulcerative and crusting disease of the epidermis. In: Gross TL, Ihrke PJ, Walder EJ, Affolter VK eds. Skin
diseases of the dog and cat. Clinical and histopathologic diagnosis. Ed. Blackwell Science. 2005; pp. 116-135.3. Gross TL, Ihrke PJ, Walder EJ, Affolter VK: Feline herpesvirus ulcerative dermatitis. In: Gross TL, Ihrke PJ, Walder EJ, Affolter VK eds. Skin diseases
of the dog and cat. Clinical and histopathologic diagnosis. Ed. Blackwell Science. 2005; pp. 124-126.4. Hargis AM, Ginn PE, Mansell JE: Ulcerative facial and nasal dermatitis and stomatitis in cats associated with feline herpesvirus 1. Vet Derm 10: 267-274,
1999.5. Holland JL, Outerbridge CA, Affolter VK: Detection of feline herpesvirus 1 DNA in skin biopsy specimens from cats with or without dermatitis. JAV-
MA 9: 1442-1446, 2006.
Indirizzo per corrispondenza:Dott.ssa Paola Persico, - Via Roma, 101 - 21047 Saronno (VA), ITALIA
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
583
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
PERIOTEST EVALUATION OF METALOCERAMIC CROWNS FIXED ON DENTAL IMPLANTS IN DOGS
M. Sabau, DVM1, C. Igna, DVM, PhD1, R. Dascalu, DVM1, L. Schuszler, DVM, PhD1
1 Surgery Department, Faculty of Veterinary Medicine, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Banat, Timisoara, România
Topic: Dentistry
Purpose of the work. The purpose of this study was to evaluate the stability of metalo-ceramic crowns, immediate and twomonths after they have been fixed on several types of osteointegrated experimental dental implants in ten common breed dogs. Materials and used methods. The experimental group was represented by 10 common breed dogs with five types of experimen-tal dental implants made of titanium alloy - cylinder thread implants, self-tapping conical screw implants, acid etched self-tap-ping screw implants, hydroxyapatite plasma sprayed self-tapping screw implant, titanium plasma sprayed self-tapping screw im-plant - inserted in the upper and lower premolar region (Sabau and Igna, 2008).Under general anesthesia (Propofol Lipuro 1% - self dosage), two step impressions (putty-wash) were made using Spofa Den-tal products: Stomaflex Solid for preliminary impression - putty (condesation curing silicone impression material, very high vis-cosity) and Stomaflex Creme - wash (condensation curing silicone impression material, low viscosity, light bodied material).Based on these impressions, plaster models were obtained. After that, metallic caps were molded and coated with ceramic ma-terial (Vita Ceramics). The metalo-ceramic crowns were manufactured for the reconstruction of the upper premolars (107, 108,207, and 208) and lower premolars (307, 407). The crowns were fixed on the implants using a glass-ionomer luting cement (Kav-itan Cem). Each crown was fixed on one dental implant with the exception of those for the reconstruction of 108 and 208, thatwere fixed on two implants (representing the two main roots). The mobility was determined with Periotest® (Siemens) immedi-ate after fixing crowns on the implants and two months later. The reading values are between -8 and +50 and (Periotest, 2007)In this two months interval all the dogs were feded with dry food – Dog Chow (granulated) according to producer’s specifica-tions concerning quantity. Outcomes. Using Stomaflex Solid and Stomaflex Creme we have obtained very good details of the regions that needed recon-struction. Plaster models based on these silicone impressions represent precise copies of edentulous regions with dental implantsinserted. Periotest values obtained immediate after fixing the crowns on the implants were between -4 and +1, meaning a goodinitial stability (the accepted degree of mobility for dental implants is placed between -8 and +1 (Periotest, 2007, Stoian, 2005,Stratul, 2001). The Periotest values obtained after two months are similar to those found immediate after cementation (valuesplaced between -4 and -1). Concerning crowns for reconstruction of upper 4th premolars (108 and 208), most of the Periotestvalues were negative (between -4 and -2), which can be explained by the fact that each one of these were fixed on two implants. Conclusions. Metalo-ceramic crowns represent a good and stabile method for dental reconstruction in dogsAll the crowns are stable immediate and one month later in dogs with alimentary diet consisted in dry food.
Bibliography
1. Sabau, M., Igna, C. – One-stage experimental dental implants inserted on dogs, Proceedings of European Veterinary Conference Voorjaarsdagen, Am-sterdam, 261, 2008.
2. Stoian, A.C.D. –Researches concerning dental implants on dogs, University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Romania,2005.
3. Stratul, S.I. – Clinical and experimental results in dental restaurations with screw type dental implants. Thesis, University of Medicine and Pharmacy, Ti-misoara, Romania, 2001.
4. *** Periotest - http://www.innovalife.com/index/InnovaLife-Products-SurgicalMotors-Periotest, 2007.
Corresponding Address:Dr. Marius Sabau - Faculty Of Veterinary Medicine/University Of Agricultural Sciences And Veterinary Medicine Of Banat Surgery Department, 119 Calea Aradului, Timisoara/300645, Romania Phone 0040256277213 - Mobile 0040757059157 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
584
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
THE POSSIBILITY OF USE OF PROPOFOL IN BATH FOR ANESTHESIA IN BARBUS SHARPEYI
A. Salati, DVM1, N. Moezzi, DVM2, R. Peyghan, phD2
1 Department of physiology, Faculty of veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran2 Department of clinical science, faculty of veterinary medicine, shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
Topic: Anaesthesia
Purpose of the work. Fish are anesthetized for a variety of procedures such as examination, transportation, diagnostic samplingand surgery. Since many of these procedures are more easily performed out of the water, a condition objectionable to most fish,effective restraint is essential.A wide variety of anesthetic agents have been used in fish but MS222 is the choice drug for ane-sthesia in fish. In Iran MS222 is not reachable so other drugs such as ketamin and xylasine are used for anesthesia. Propofol isan anesthetic drug with rapid effect, short course and minimal side effects that is used in human and some animals. In this studywe evaluated the possibility of using Propofol in bath for anesthesia in Barbus sharpeyi, a species that confined to iran. Materials and used methods. 100 fishes (3.5+- 0.08) were sampled and kept for 2 weeks for accomodation. After this time di-vided into 10 groups (N=10 at each group). aqueous solution of propofol at a final concentrations of 0.5, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4,4.5 and 5 mg/l were used. Fish kept in anesthesia tank for 15 minutes and then transfered to the recovery tanks with anesthetic-free water and the recovery time was recorded. During the experiment water was oxygenated adequately and Temperature of allsolutions used were maintained at 20+_1.Total loss of response to stimuli was the criteria for anesthesia. Outcomes. In 5 mg/l concentration all fishes died.and 1 ppm concentration had no effect on fish cognition, so data of thesegroups were not recorded. In other concentrations, fishes anesthetized in 8, 5, 3.5, 3, 2.3, 1.2 and 1 minutes, consequently. Therecovery time of first fish in each concentration was 7, 11, 12, 14, 18, 27, 29 minutes, consequently. All fishes in above doses re-covered in 17, 30, 30, 32, 35, 35, 42 minute, consequently. In 4 mg/l two and in 4.5 mg/l four fishes were died. Conclusions. The result of this study showed that the Propofol can sedate Barbus sharpeyi to adequate depth. also induction ofanesthesia is fast enough and maintain for sufficient periods.
Bibliography
1. Harms CA: Anesthesia in fish. In Fowler ME and Miller RE: Zoo & Wild Animal Medicine Current Therapy 4. Philadelphia: W.B. Saunders Company,pp. 158-163, 1998.
2. Stoskopf MK. Anesthesia of pet fishes. In: Bonagura JD, Kirk RW, eds. Current veterinary therapy XII, small animal practice. Philadelphia: WB Saun-ders Co, 1365-1369, 1995.
3. Hikasa Y, Takase K, Ogawawara T, et al. Anesthesia and recovery with Tricaine methanesulfonate, eugenol, and thiopental sodium in the carp, Cyprinuscarpio. Japanese Journal of Veterinary Science, 48:341-351, 1986
Corresponding Address:Dott. Amir Salati - Azadi Street Department Of Physiology, Faculty Of Veterinary Medicine, University Of Tehran,Qareeb Street, Azadi Av.,P.O.Box: 14155-6453, Tehran - Ira, 1419963111, Iran - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
585
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
ANESTESIA SPINALE ELETTIVA CON BUPIVACAINA O L-BUPIVACAINA IN 82 CANISOTTOPOSTI A CHIRURGIA: UNO STUDIO RETROSPETTIVO (2005-2008)
D. Sarotti, DMV1,2, R. Rabozzi, DMV3
1 Centro Veterinario Fossanese, Fossano (CN), Italia2 Centro Veterinario Saluzzese, Saluzzo (CN), Italia
3 Ambulatorio Veterinario Adriatico, Vasto (CH), Italia
Area di interesse: Anestesia
Scopo del lavoro. L’anestesia spinale è una delle più vecchie tecniche di anestesia loco-regionale e al tempo stesso una dellepiù efficienti, in quanto contraddistinta da breve latenza ed alta potenza di azione. Fin dagli anni 50’ nell’uomo si sono prodot-te evidenze sulla bassa incidenza di effetti collaterali e dell’utilità clinica sia per la spinale1 che per l’epidurale. In letteratura ve-terinaria esiste solo un lavoro che comprova in corso anestesia epidurale la sicurezza della tecnica e ne descrive sia gli effetticlinici che gli effetti collaterali2. Nell’anestesia spinale del cane e del gatto non esiste al momento una descrizione retrospettivasu più casi, ma sono riportati in letteratura solo case reports. In questo studio retrospettivo di carattere descrittivo viene riporta-to nel cane per la prima volta su un numero significativo di casi l’incidenza di effetti collaterali perioperatori, e la presenza/as-senza di risposta cardiovascolare (RC/NRC) allo stimolo chirurgico durante anestesia spinale elettiva in cani sottoposti a chi-rurgie addominali craniali (CACR), caudali(CAC), tagli cesarei(TC), e ortopedie arti posteriori(CO). Materiali e metodi. Analisi retrospettiva condotta sulle cartelle cliniche consecutive nel periodo 2005-2008 di pazienti sotto-posti ad anestesia spinale elettiva con uso di l-bupivacaina o bupivacaina. L’iniezione spinale è stata elettivamente programma-ta nello spazio L5-6, in soggetti intubati e mantenuti in uno stadio superficiale di anestesia generale. La scelta della dose di ane-stetico locale e di oppioide è avvenuta in base al peso tenendo conto del morfotipo e della lunghezza del rachide. I soggetti conpressione arteriosa media (MAP) inferiore a 60 mmHg sono stati classificati come casi di ipotensione, mentre quelli a cui la fre-quenza cardiaca e la MAP aumentava post-stimolo in modo superiore al 20% come casi di RC. I pazienti nel postoperatorio so-no stati valutati con la scala del dolore ogni 2 ore fino alla dimissione e a tutti è stato somministrato un FANS; con oppioide so-lo in caso di necessità. Dopo l’analisi di distribuzione di normalità con istogramma delle frequenze e test di Shapiro-Wilk, le va-riabili parametriche sono state descritte come media (DS), mentre le variabili non parametriche come mediana (range). Risultati. Sono state eseguite 115 punture spinale, in 86 di queste(75%) la fuoriuscita di liquor era evidente ed è stato possibi-le iniettare l’AL. 82 cartelle cliniche su 86 hanno raggiunto i criteri di inclusione. Classificazione mediana ASA di II (I-III), etàmedia 73 mesi (46), peso mediano kg 12(2-75), lunghezza mediana della colonna L7-occipite cm 50(32-100), tempo dalla spi-nale al taglio cute 10(5-24) min, durata della anestesia a partire dalla spinale 50(30-150). Le CO sono state 33(41%), 22(25%)le CACR, 17(21%) TC, 10(12%) CAC. I soggetti premedicati sono stati 64(78%) quelli non premedicati 18(22%), 74(90%) in-dotti con propofol ad effetto (4-6 mg kg-1), 8(10%) con tiopentale ad effetto (6-10mg Kg-1), 72(88%) mantenuti con isofluo-rano espirato (0,7-1,3%), 10(12%) soggetti con infusione di propofol a scalare nel tempo tra 25 e 15 mg kg-1 h-1. In 47(58%)pazienti è stato usato un ago di Quincke 22G, in 31(37%) un ago di Quincke 25G e in 4(5%) un ago di Whitacre 25G. Il sito dipuntura spinale è stato L5-6 in 54(67%) casi; L4-5 in 15(18%); L6-7 in 7(8%), L7-S1 in 6(7%). L’AL scelto è stato in73/82(89%) soggetti bupivacaina 0,5% dose media 0,42 mg kg-1(0,20) e 0,1 mg cm-1(0,035) di colonna, ed in 9/82(11%) l-bu-pivacaina 0,5% dose media 0,5 mg kg-1(0,17) e 0,08mg/cm-1(0,03). In 55/82(67%) morfina (10 mg ml-1) 0,096 mg kg-1(0,07);in 22/82(27%) fentanil (50 mcg ml-1) 0,51 mcg kg-1(0,22), ed in 5/82 (6%) casi non è stato aggiunto alcun adiuvante. In 29/82casi (35%) è stata registrata RC post-stimolo, e di questi 11/29(40%) hanno necessitato di un aumento del piano di anestesia, e18/29(60%) di un oppiaceo intraoperatorio. Le complicazioni sono state: 7/82(9%) casi di bradicardia, 1/82(1%) blocchi A-V diII° grado, 4/82(5%) di ritenzione urinaria, 5/82(6%) scialorrea, 1/82(1%) vomito, nessun caso di mortalità intraoperatoria e a 30giorni, né danni neurologici transitori o permanenti. L’ipotensione è stata registrata in 24/82(30%) pazienti di questi 10/24(42%)hanno necessitato di un alleggerimento del piano di anestesia, mentre 14/24(58%) hanno necessitato l’utilizzo di un vasopres-sore. I pazienti con RC intraoperatoria hanno ricevuto oppioidi nel periodo postoperatorio, mentre nessuno dei pazienti NRC hanecessitato di oppioide postoperatorio. Conclusioni. Lanestesia spinale elettiva nel cane è una tecnica di semplice esecuzione ma contraddistinta nella nostra esperien-za da una non trascurabile incidenza di fallimenti procedurali, è risultata inoltre sicura e con limitata frequenza di complicanzeminori. L’incidenza di ipotensione è sovrapponibile a quella riportata nell’uomo3, mentre la percentuale di RC è risultata di granlunga superiore. Al fine di diminuire l’incidenza di risposte cardiovascolari sono probabilmente necessari ulteriori studi per va-lutare quali possano essere le variabili indipendenti che meglio delineino il dosaggio minimo efficace.
Bibliografia
1. Dripps RD, et al. JAMA 1954 18; 156:1486-91.2. Troncy E., et al. JAVMA 2002, 221; 5: 666-672.3. Carpenter A., et al. Anesthesiology:1992, 76; 6:873-1075.
Indirizzo per corrispondenza:Dott. Diego Sarotti - Cvf, Via Cuneo 29 E - 12045 Fossano (CN), Italia - Tel. 3397799642 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
586
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
UN CASO DI MUCOPOLISACCARIDOSI TIPO VI (SINDROME DI MAROTEAUX-LAMY) IN UN GATTO
Riccardo Finotello, DVM1, Silvia Sbrana, DVM1, Maurizio Mazzei, DVM2, Simonetta Citi, DVM1,Mirella Filocamo, BSc, PhD3, Giovanni Barsotti, DVM1, Carlo Cantile, DVM2
1 Dipartimento di Clinica Veterinaria, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Pisa, Pisa, Italia2 Dipartimento di Patologia Animale, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Pisa, Pisa, Italia
3 Laboratorio Diagnosi Pre-Postnatale Malattie Metaboliche, IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Genova, Italia
Area di interesse: Neurologia
Introduzione. La mucopolisaccaridosi (MPS) VI è una patologia autosomica recessiva causata da una deficienza dell’enzimaN-acetilgalattosamina 4-solfatasi (arilsolfatasi-B; ASB) che esita in un accumulo intracitoplasmatico di dermatan solfato (DS).Tale patologia è riportata sporadicamente in medicina veterinaria in alcune razze di cani e in gatti siamesi e loro incroci. La sin-tomatologia compare a 6-8 settimane di vita con deformità dello scheletro appendicolare e facciali, paresi o paralisi degli artiposteriori per compressione midollare soprattutto cervicale esercitata da lesioni ossee vertebrali e/o coinvolgimento diretto delsistema nervoso centrale e lesioni oculari.Descrizione del caso. Romeo, gatto maschio castrato di 8 mesi, incrocio di siamese, regolarmente vaccinato, era riferito per ri-luttanza al gioco e tendenza all’affaticamento precoce fin dalle prime settimane di vita. Il soggetto mostrava buono stato di nu-trizione e le grandi funzioni organiche erano mantenute. Si osservava depressione del sensorio, tetraparesi soprattutto posterio-re, dolore alla manipolazione del rachide, delle anche, delle ginocchia e dei gomiti con crepitii e aumento del grado di escur-sione articolare; le reazioni posturali e i riflessi erano nella norma. L’esame oftalmologico appariva normale bilateralmente adeccezione della presenza di aree multiple brunastre ad andamento lineare e talvolta serpiginoso nell’area tappetale. L’esame ra-diografico evidenziava displasia epifisaria delle ossa lunghe e delle fisi vertebrali, rotule bipartite e sublussazione bilaterale d’an-ca. Gli esami di laboratorio evidenziavano lieve ipocalcemia e lieve iperfosfatemia. I test ELISA per FIV e FeLV risultavano ne-gativi. Sulla base del segnalamento e dei rilievi clinici, si emetteva come primo sospetto diagnostico quello di MPS. Si racco-glieva quindi l’urina prodotta nelle 24h su cui veniva eseguito Berry Spot Test (BST), che mostrava marcata positività per la ri-cerca di GAG, Dimetil-Metilene Blu Test (DMB) che forniva un valore di 38,7 mg/24h di GAG escreti (valore di riferimento0,2 mg/24h) e cromatografia su strato sottile, che mostrava massivo accumulo di DS; veniva così confermato il sospetto clinicodi MPS. La patologia veniva tipizzata con test enzimatico eseguito su fibroblasti cutanei. Dall’esame risultava una notevole ri-duzione dell’attività di ASB (0,53 nmol/min/mg; valore di riferimento 19-27 nmol/min/mg) che permetteva di emettere diagno-si definitiva di MPS di tipo VI (sindrome di Maroteaux-Lamy). Dopo 7 mesi dalla diagnosi, per l’aggravarsi delle condizionicliniche, l’animale veniva sottoposto ad eutanasia. All’esame necroscopico e istologico, numerose radici dei nervi spinali appa-rivano aumentate di volume determinando compressione del midollo spinale. Le radici nervose e i gangli spinali erano infiltra-ti da cellule ampiamente vacuolizzate, con nucleo fortemente basofilo e irregolare, interpretate come fibroblasti. Il midollo spi-nale mostrava marcati fenomeni degenerativi con vacuolizzazione della mielina prevalentemente a carico delle porzioni perife-riche dei funicoli laterali e ventrali di tutti i segmenti midollari. Cellule vacuolizzate, analoghe a quelle precedentemente de-scritte, erano osservate a livello delle leptomeningi cerebrali, nello stroma dei plessi corioidei e intorno ai capillari subpiali. Fi-broblasti vacuolizzati erano presenti anche nel contesto delle valvole cardiache, e, a livello oculare, nell’iride, nel corpo ciliaree nella coroide. All’osservazione ultrastrutturale le vacuolizzazioni dei fibroblasti cutanei e in altre sedi risultavano circondateda membrana e, occasionalmente, a contenuto simil-lamellare.Conclusioni. MPS VI è una patologia ereditaria raramente descritta in medicina veterinaria, probabilmente sottostimata a cau-sa dell’aspecificità dei suoi sintomi e della complessità dell’iter diagnostico. La casistica presente in letteratura riguarda per lopiù colonie feline sperimentali utilizzate come modello per la malattia nell’uomo. Nel caso in esame MPS è stata messa al pri-mo posto nel diagnostico differenziale per età, razza e sintomatologia correlate ad un quadro radiografico altamente suggestivo.L’iter diagnostico effettuato ha permesso di passare dal sospetto alla diagnosi definitiva di MPS VI mediante la messa in evi-denza della notevole riduzione dell’attività dell’enzima ASB su colture cellulari. Il farmaco attualmente registrato per il tratta-mento di MPS VI, Galsulfase, è un farmaco ad uso ospedaliero che agisce mediante sostituzione enzimatica ed è testato nel gat-to solo a livello sperimentale. Nel caso descritto non è stato possibile attuare una terapia mirata a correggere il difetto di ASBcausa l’alto costo, la difficoltà a reperire Galsulfase e la diagnosi tardiva della patologia; il soggetto è stato quindi gestito con lasola terapia sintomatica fino al momento dell’eutanasia. Per il futuro si auspica di poter diagnosticare con maggiore tempesti-vità questo tipo di patologia in modo da aumentare una casistica ad oggi molto ristretta e poter applicare anche in medicina ve-terinaria una terapia farmacologica che consenta una migliore qualità di vita all’animale.
BibliografiaFillat C. et al. (1996) Arylsulfatase B activities and glycosaminoglycan levels in retrovirally transduced mucopolysaccharidosis type VI cells. Prospects for ge-
ne therapy J. Clin. Invest. 15; 98(2):497-502
Indirizzo per corrispondenza:Dott. Riccardo Finotello - Dipartimento di Clinica Veterinaria - Via Livornese lato monte - 56100 Pisa (PI), ItaliaTel. 050/2210158 - Cell. 333/9090654 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
587
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
STUDIO DELLA PARETE GASTRICA NEL CANE MEDIANTE HELICAL HYDRO-CT (HHCT):TECNICA NORMALE E PRIME ESPERIENZE CLINICHE
R. Terragni, DMV, MS, SPCAA1, M. Vignoli, DMV, SRV, Dipl. ECVDI1, P. Laganga, DMV1,V. F. Leone, DMV, Sanità e qualità dei prodotti di origine animale1, F. Rossi, DMV, SRV, Dipl. ECVDI1
1 Libero professionista, Sasso Marconi (Bo), Italia
Area di interesse: Gastroenterologia
Scopo del lavoro. In Medicina Umana, nello studio della parete gastrica, TC ed RM affiancano la radiologia contrastografica,l’endoscopia e l’endosonografia. L’HHCT è una tomografia computerizzata dinamica che utilizza l’acqua come mezzo di con-trasto neutrale: è una tecnica utile soprattutto per la stadiazione e la valutazione preoperatoria delle neoplasie gastriche nell’uo-mo. L’obiettivo del lavoro è di descrivere la tecnica dell’HHCT nel cane e valutarne le applicazioni cliniche. Materiali e metodi. Sono stati valutati 9 soggetti mediante HHCT: 6 cani adulti di 3 categorie di peso corporeo (2 al di sottodei 10 kg, 2 compresi tra 10 e 25 kg e 2 al di sopra dei 25 kg) che sono stati sottoposti ad esame TC per patologie non ga-stroenteriche e 3 cani (1 Dalmata, 1 Pastore Belga ed 1 cane Corso) affetti da carcinoma gastrico della piccola curvatura già pre-cedentemente diagnosticato, inviati per la stadiazione della neoplasia mediante TC total body. Tutti i cani hanno osservato 15ore di digiuno prima della procedura. I pazienti sono stati anestetizzati con Diazepam 0,2 mg/Kg e Propofol 4 mg/Kg i.v e man-tenuti con miscela gassosa di Ossigeno ed Isofluorano. È stata eseguita una TC spirale diretta con i cani in decubito sternale, ac-quisita con doppio algoritmo (tessuti molli e ossa), fette di 3 mm e 6 mm di incremento del tavolo (pitch 2:1). A questo punto èstata collocata una sonda gastrica: nei 6 cani senza patologie gastroenteriche sono stati introdotti 3 differenti quantità di acquatiepida (10, 20 e 30 ml/kg). Dopo ciascuna somministrazione sono stati eseguiti 3 studi sequenziali per evidenziare la disten-sione della parete gastrica. Una volta raggiunto il riempimento gastrico con 30 ml/kg lo studio CT è stato ripetuto dopo la som-ministrazione endovenosa di 800 mg/kg di mezzo di contrasto non-ionico. Gi studi acquisiti sono stati ricostruiti con fette dispessore 1 e 3 mm ed algoritmi da tessuti molli ed ossa. Ultimato lo studio, la sonda gastrica è stata tolta e l’esofago aspiratoper rimuovere eventuale liquido presente nel lume; l’acqua introdotta precedentemente è stata lasciata nello stomaco. Nei cani affetti da carcinoma gastrico è stata eseguita la HHCT con lo stesso protocollo utilizzando il riempimento gastrico con30 ml/kg di acqua tiepida. Risultati. Nella prima scansione (senza riempimento gastrico) la parete gastrica mostrava sempre un falso ispessimento in cor-rispondenza della grande curvatura causata dall’obliquità della fetta in relazione alla posizione dello stomaco. Dopo la sommi-nistrazione di acqua e la distensione della parete gastrica, la grande curvatura, il fondo e l’antro pilorico erano distesi e visibilicome una parete regolare e sottile. La somministrazione di 30 ml/kg di acqua è stata considerata ottimale per la distensione del-la parete, mentre = 20 ml/kg è stato considerato insufficiente allo scopo. Nei 3 cani con neoplasia gastrica la piccola curvatura mostra un ispessimento focale con moderato enhancement del contrastonella lesione. La stadiazione della lesione (TMN) è stata determinata in tutti e 3 i casi. Conclusioni. L’HHCT è una tecnica relativamente semplice che ottimizza la visualizzazione della parete gastrica nel cane;non presenta inoltre costi aggiuntivi rispetto ad un esame TC convenzionale. Secondo queste nostre prime esperienze, un’a-deguato riempimento gastrico è alla base del successo della metodica. Questo è il primo studio che porta l’utilizzo dellaHHCT in Medicina Veterinaria e ne evidenzia la sua utilità nella stadiazione delle neoplasie gastriche e nel planning chirur-gico. Sarà necessario un ampliamento della casistica per una definitiva valutazione della sua applicabilità nel cane ed even-tualmente anche nel gatto.
Bibliografia
M. Rossi, L Broglia, F. Maccioni et al: “Hydro-CT in patient with gastric cancer: preoperative radiologic staging”, European Radiology, 1997, 7, 659-664.Wen-Zhou Wei, Jie-Ping Yu, Jun Li et al: ”Evaluation of contrast-enhanced helical hydro- CT in staging gastric cancer”, World Journal of Gastroenterology,
2005, 11(29); 4592-4595.C.-Y. Chen, D.-C. Wu, W.-Y. Kang, J.-S. Hsu: “Staging of gastric cancer with 16-channel MDCT”, Abdominal Imaging, 2006, 31: 514-520.
Indirizzo per corrispondenza:Dott.ssa Rossella Terragni - Clinica Veterinaria dell’Orologio, Via Gramsci 1/4 - 40037 Sasso Marconi (BO), Italia Tel. 051/6751232 - Cell. 335/1310117 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
588
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
UN CASO DI DEFICIENZA DI TIAMINA IN UN GATTO CONFERMATO MEDIANTE RISONANZA MAGNETICA
A. Tomba, DVM1, M. Sacco, DVM2, G. Abbiati, DVM3
1 Private Practitioner, Milano, Italy2 Private Practitioner, Milano, Italy3 Private Practitioner, Milano, Italy
Area di interesse: Neurologia
Introduzione. La tiamina, o vitamina B1, svolge, nella sua forma attiva la Tiamina piro-fosfato (TPP), un importante ruolo nelmetabolismo energetico, partecipando come coenzima alla decarbossilazione ossidativa del piruvato e dell’alfa-chetoglutaratonel ciclo di Krebs. La carente assunzione attraverso gli alimenti di questa vitamina è responsabile, nell’uomo e negli animali, diuna diminuita gliconeogenesi, la quale si traduce in una poliencefalomalacia simmetrica e bilaterale progressiva, interessante so-prattutto la sostanza grigia sottocorticale. Le lesioni nei carnivori consistono in emorragie petecchiali bilaterali e simmetriche incorrispondenza dei collicoli caudali, dei corpi genicolati laterali, dei nuclei vestibolari e di altri nuclei del tronco cerebrale. Gliaspetti negli studi di risonanza magnetica effettuati sull’uomo sono risultati essere strettamente correlati ai rilievi neuropatolo-gici e mostrano aree bilaterali e simmetriche di franca e focale iperintensità di segnale nelle immagini T2-pesate in corrispon-denza dei nuclei di sostanza grigia interessati. In letteratura sono riportati gli aspetti in RM in un cane (Garosi et al.) e in un gat-to (Penderis et al). Nel primo caso la risonanza aveva messo in evidenza lesioni in corrispondenza di nuclei rossi, collicoli cau-dali, nuclei vestibolari e noduli cerebellari. Nel secondo caso erano evidenti alterazioni di segnale anche a carico dei corpi ge-nicolati laterali, della sostanza grigia periacqueduttale e dei nuclei del facciale. Questa comunicazione mostra come la risonan-za magnetica nel paziente in esame mostri aspetti del tutto sovrapponibili a quella riportata in letteratura. Descrizione del caso. una gatta femmina sterilizzata adulta, veniva valutata in seguito all’insorgenza acuta di perdita di equili-brio, disorientamento e anoressia.All’anamnesi remota venivano segnalati episodi ricorrenti di ematuria causati dalla presenza di cristalli di struvite e infezione;a fronte di ciò il gatto era stato sottoposto a terapia antibiotica (enrofloxacina 5 mg/kg SID) e al passaggio da un’alimentazionesecca a umida commerciale.All’esame obiettivo generale le uniche alterazioni consistevano in modica ipotermia e lieve disidratazione; all’esame neurolo-gico la gatta presentava disorientamento ed eccitazione. La deambulazione era caratterizzata da atassia vestibolare e da perditadi equilibrio verso destra; l’esame dei nervi cranici evidenziava assenza bilaterale della reazione al gesto di minaccia e midria-si accompagnata da diminuzione del riflesso fotomotore diretto e consensuale. L’esame del fundus appariva nella norma. Le rea-zioni posturali erano deficitarie sul lato sinistro e mancava il riflesso di raddrizzamento della testa. Tono e trofismo muscolareapparivano normali. Gli esami ematochimici evidenziavano come unica alterazione iperglicemia; gli esami sierologici per infe-zioni da FIV e FeLV erano risultati negativi. Si consigliava pertanto di sottoporre il paziente ad un esame di risonanza magne-tica del neurocranio e ad un eventuale prelievo di liquido cefalorachidiano.La RM metteva in evidenza la presenza di aree focali simmetriche e bilaterali caratterizzate da franca iperintensità di segnalenelle immagini T2-pesate in corrispondenza dei corpi genicolati laterali, dei collicoli caudali, dei nuclei vestibolari e del faccialee del nodulo cerebellare. Non vi erano alterazioni di segnale evidenti nelle sequenze T1-pesate prima e dopo somministrazioneendovenosa del mezzo di contrasto paramagnetico. Il LCS, prelevato mediante puntura lombare, presentava dissociazione albu-mino-citologica. Il quadro descritto risultava compatibile con una polioencefalomalacia da carenza di Tiamina. Il gatto venivasuccessivamente sottoposto a terapia mediante integrazione di vitamine del gruppo B, con rapido miglioramento della sintoma-tologia; a distanza di un mese l’esame neurologico è rientrato nei limiti di normalità benché il proprietario riferisca una certadifficoltà nel saltare sui piani rialzati. Conclusioni. il presente caso conferma la validità della risonanza magnetica nella diagnosi rapida di encefalopatia da carenzadi Tiamina e la corrispondenza con le lesioni descritte in neuropatologia veterinaria.
Bibliografia
Veterinary Record 2007, Penderis et Al.; J Vet Intern Med 2003, Garosi et al.
Indirizzo per corrispondenza:Dott. Anna Tomba - Residenza Fontanile 502 - 20090 Milano 2 (MI), Italy Phone 02/26924035 - Mobile 3470126445 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
589
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
TREATMENT OF HANSEN TYPE I DISC DISEASE WITH ACUPUNCTURE - A CASE REPORT
Z. Vrbanac, DVM2,1, D. Stanin, Associate Professor, PhD, DVM2,1, N. Brkljaca Bottegaro, DVM3,1, B. Skrlin, DVM2,1
1 Faculty of Veterinary Medicine, Zagreb, Croatia2 Department of Radiology, Diagnostic Ultrasound and Physical Therapy, Zagreb, Croatia
3 Department for Surgery, Orthopaedics and Ophtalmology, Zagreb, Croatia
Topic: Physiotherapy
Introduction. Hansen type I disc disease is commonly described in small, typically chondrodystrophoid breeds of dogs, with 85% occurrence in the thoracolumbar segment between T9-L7. Discs are usually herniated or extruded dorsally. The mass of nuclear material is forcibly ejected into the vertebral canal andcauses concussion and compression of the spinal cord.Clinical signs following described pathological changes are neurological dysfunction with sign of paresis or paralyses of oneor both hind limbs. Depending on the severity of disease, therapy ranges from surgical treatment, conservative treatment by useof medicament’s or physical therapy. Combined therapy is also a possibility. Our case report describes the non surgical physi-cal therapy approach, with only the effect of acupuncture as a therapeutic modality. Description of the case. A 4 year old female Pekingese dog was referred with sign of acute onset of thoracolumbar paraspinalpain and paraparesis that lasted for 5 days. No trauma was reported. Since the time of arrival it hasn’t been medically treated.Dog was reluctant to move and showing signs of paraparesis of the pelvic limb with linging to the right side. Urinary bladderfunction and anal tone were not altered, although there was no defecation since the incident occurred.Further neurological examination revealed absence of the proprioceptive response on both hind limbs. Hypertonicity of musclesand exaggerated pelvic limb reflexes were also present with slightly increased signs on the right limb. There was absence of sen-sory function (deep pain perception) in both hind limbs. Survey radiography showed a narrowed intervertebral space between vertebral bodies of T11-T12, and a calcified interverte-bral disc. For definitive diagnosis myelography was performed. After the lumbar injection, lateral and ventrodorsal myelogramconfirmed extradural lesion and compression of spinal cord between thoracic vertebrae T11-T12. Conventional acupoints were chosen, steel needles (0.25x0,25), as well as laser acupuncture (13 mW, 633 nm).Acupoints: Ji Zhong (laser), Xuan Shu, Ming Men, Bai Hui, Wei Gen, Xi Xia, Hou San Li, Liu Feng Treatments were done 3 times per week, each treatment lasted for 25 minutesOwner was encouraged to do passive range of motion (PROM) and a gentle massage of the muscles of hind limbs on daily base.Posture was improved after the 1st treatment, and normal defecation was restored after 2nd. Neurological assessment followed the 4th treatment, proprioceptive response was still absent, but deep pain perception was nor-mal in the left limb and reduced in the right.After the 6th treatment the dog was able to stand by itself and walk for a few steps. The evaluation on the 9th treatment showedproprioception was delayed, and there were no more signs of hipereflexion. Deep pain perception was normal in both hind limb,and the animal was able to walk for a short period. Conclusions. Conservative management of thoracolumbar disc dissease (TLDD) is often limited to restricted movement andcarefully selected methods of physiotherapy. In order to remove pain and restore the function of hind limbs, our aim was to useacupuncture as a non-invasive method of rehabilitation. As throughout the treatment no medications were administered, the ob-tained results are due to biopositive effect of acupuncture treatment. Within 3 weeks of therapy we managed to achieve signifi-cant alternation of neurological symptoms, as well as restoration of motor function. Rehabilitation period of dogs suffering fromTLDD can last for several weeks, even months, and in our case this period was shortened. Results in our case open a new pos-sibility of using acupuncture as a method of rehabilitation in cases of conservative managment of TLDD in dogs.
Bibliography
Janssens LA., Acupuncture for the treatment of thoracolumbar and cervical disc disease in the dog., Probl Vet Med. 1992 Mar;4(1):107-16.Sharp N., Wheeler S., Small Animal Spinal Disorders, Elsevier Ltd, 2005.Schoen A., Veterinary Acupuncture, Mosby 1994.
Corresponding Address:Dott. Zoran Vrbanac - University of Zagreb; Faculty of Veterinary Medicine; Department of Radiology,Diagnostic Ultrasound and Physical Therapy, Heinzelova 55, 10000 Zagreb, Croazia Phone +385 1 2390 401 - Mobile +385 98738381 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
590
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009
PIASTRINOSI E NEOPLASIE
A. Zanella, DMV1, T. Furlanello, DMV, DECVCP1, M. Caldin, DMV, DECVCP1
1 Libero professionista, Padova, Italia
Area di interesse: Oncologia
Scopo del lavoro. La relazione tra neoplasie e trombocitosi è cosa ormai assodata nella specie umana. Questo fenomeno, lega-to al rilascio da parte delle cellule tumorali di numerose citochine e fattori di crescita, genera una piastrinosi talvolta correlatacon la stadiazione stessa di alcune neoplasie (carcinoma ovarico). Obiettivo di questo lavoro è indagare l’esistenza di un’eventuale associazione tra trombocitosi e neoplasie nella specie canina. Materiali e metodi. Nel periodo compreso tra il 20-02-2007 ed 20-02-2009 sono stati diagnosticati, presso la sede degli auto-ri, 588 casi di tumore, mediante esami cito/istopatologici: carcinomi (165), sarcomi (112), linfomi (60), mastocitomi (39) e va-ri (212). I primi quattro tumori sono oggetto del presente studio. Carcinomi, sarcomi, mastocitomi, sono stati diagnosticati me-diante esame istopatologico mediante ematossilina eosina e quando necessario mediante esami immunoistochimici. I linfomi so-no stati diagnosticati mediante esame citologico colorato con May Grunwald-Giemsa ed eventualmente con esame istopatolo-gico ed immunoistochimico quando necessario. Sono stati esclusi dallo studio i soggetti che presentavano più di una neoplasiamaligna contemporaneamente ed i pazienti che avevano già subito precedentemente un qualsiasi trattamento antineoplastico(chirurgia, radioterapia, chemioterapia). Lo studio è stato realizzato retrospettivamente comparando i soggetti neoplastici con un gruppo controllo (soggetti non neopla-stici) presentante le stesse caratteristiche epidemiologiche (cross-match per razza, sesso ed età). I casi ed i controlli dovevanodisporre di una approfondita scheda clinica corredata di un work-up diagnostico comprendente: emogramma, profilo biochimi-co, elettroforesi, esame urine e profilo coagulativo. I pazienti oncologici ed i controlli sono stati divisi in sottogruppi per istoti-po (carcinomi, sarcomi, linfomi e mastocitomi) e per complicazioni coagulative (DIC-SI’, DIC-NO). Sono state prodotte stati-stiche descrittive per le variabili: conta piastrinica, coagulazione intravasale disseminata e proteina c-reattiva. La correlazionetra proteina c-reattiva, conta piastrinica e coagulazione intravasale disseminata è stata verificata tramite coefficiente di correla-zione Rho di Spearman. La frequenza della DIC nei differenti gruppi è stata testata mediante il test del chi quadro. Il test ANO-VA e di Mann-Whitney sono stati usati per valutare le differenze della conta piastrinica nei vari gruppi. Si è considerato signi-ficativo un valore di p < 0.05. Risultati. Accanto alla valutazione della conta piastrinica nel gruppo oncologico e nei controlli, si sono valutate alcune varia-bili di confondimento quali la coagulazione intravasale disseminata (DIC) e l’infiammazione (crp) per i possibili effetti che es-se possono avere nella conta piastrinica stessa. La comparazione della conta piastrinica tra tutti i soggetti oncologici (casi) ed ilgruppo di controllo (controlli) non ha evidenziato differenze statisticamente significative. La DIC presentava una maggiore fre-quenza nei casi oncologici rispetto ai controlli ed un effetto rilevante nei riguardi dell’abbassamento della conta piastrinica. Alcontrario la flogosi (crp), in particolar modo nei controlli non si è correlata in modo significativo alla conta piastrinica. La divi-sione in sottogruppi ha consentito di trarre alcune rilevanti osservazioni. I soggetti affetti da sarcoma, con o senza complicazio-ni coagulative presentavano una conta piastrinica significativamente aumentata rispetto ai controlli con o senza complicazionicoagulative. I carcinomi con DIC presentavano una conta piastrinica significativamente più elevata rispetto ai controllli con DIC.Il mastocitoma non si associava a DIC, ed il gruppo dei linfomi non ha evidenziato differenze rispetto ai suoi controlli. Conclusioni. Questo studio preliminare indica che almeno in alcune condizioni neoplastiche come i sarcomi ed i carcinomi conDIC la piastrinosi può essere associata a neoplasia. Ulteriori valutazioni che comprendano altre variabili di confondimento, co-me ad esempio la somministrazione di corticosteroidi, si renderanno necessarie al fine di valutare un possibile rapporto causaeffetto tra queste neoplasie e la conta piastrinica.
Bibliografia
Nash GF, Tumer LF, Scully MF, Kakkar AK. Platelets and cancer. Lancet Oncol 2002; 3:425-30. Rickles FR, Levine MN. Epidemiology of thrombosis in can-cer. Acta Haematol 2001;106:6–12.
Maruyama H., Miura S., Sakai M., et all. The incidence of disseminated intravascular coagulation in dog with malignant tumor. J. Vet. Med. Sci. 2004; 66 (5):573-575.
Alexandrakis M. G., Passam F. H., Persinakis K., et all. Serum proinflammatory cytokines and its relationship to clinical parameters in lung cancer patients withreactive thrombocytosis. Respiratory Medicine 2002; 96: 553-558.
Sierko E., Wojtukiewicz M. Platelets and Angiogenesis in Malignancy Semin Thromb Hemost 2004; 30: 95-108.
Indirizzo per corrispondenza:Dott.ssa Anna Zanella - Clinica Veterinaria Privata S. Marco - Via Sorio 114/c - 35141 Padova (PD), ITALYTel. 049 8561098 - E-mail: [email protected]
62° Congresso Internazionale Multisala SCIVAC
591
Reprinted in IVIS with the permission of SCIVAC Close window to return to IVIS www.ivis.org
Proceedings of the International SCIVAC Congress 2009