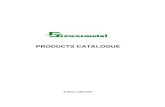CGIA MESTRE1 Borderline Pag. 03Metaphors and Politics. An inquiry into the Political Discourse of...
Transcript of CGIA MESTRE1 Borderline Pag. 03Metaphors and Politics. An inquiry into the Political Discourse of...

1
Borderline
Pag. 03 Metaphors and Politics. An inquiry into the Political Discourse of the Italian Second Republicdi Giuseppe Gangemi e Francesca Gelli
Il Faro
Pag. 52 L’analisi delle politiche pubbliche di Giovanni Tonella
Viaggiando tra le costellazioni del sapere
Pag. 73 Verso una teoria della creatività di Santa de Siena
Il Sestante
Pag. 110 Sivlio Trentin e la nascita dell’Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Veneziedi Elio Franzin
Pag. 120 Stampa intransigente e nascita di un modello identitario. L’esempio del giornale “La Fede” a Chioggia di Gina Duse
SOM
MAR
IO Culture Economie e Territori
Rivista QuadrimestraleNumero Ventidue, 2008

2

1. Metaphors, images and ideal-types
In quantitative content analysis, and in other statistical analyses, metaphors maybe defined as images or figures of speech. In fact, these quantitative techniquescount empirical single- or multi-item indicators organised in a data matrix andinferred to more abstract and general concepts. In quantitative analyses, it isimportant to insert in a model as much standardised information as possible oneach indicator in every case and it is necessary to have as many images as possi-ble. In order to find so many figures of speech, it is necessary to reduce ametaphor to its simplest meaning. This reduction is obtained by giving to anymetaphor the minimum common meaning, i.e. the least meaning possessed bythe meaningless image, among all the figures of speech. In this way, indicatorsare produced by constructing typologies of images and by counting how manykinds or categories of images are present in or absent from the text. Complexmetaphors are reduced to figures of speech in order to be analysed throughwhat Clifford Geertz (1973) called Thin Description. On the contrary, in qualitative analyses, a metaphor can be defined giving to theconcept a thicker meaning. The discourse, which is going to be introduced, is aqualitative one and it is possible to study only a few important metaphors. Thus,it is possible to give the maximum possible meaning, i.e. the meaning possessedonly by a few meaningful metaphors. In this essay, which tries to present a the-oretical level of qualitative analysis, a metaphor is defined as the first presenta-tion of a theory or of a political discourse, when the domain where the metaphoris used is not yet well depicted. According to this definition, metaphors are val-ued through a Thick Description, a kind of analysis derived by anthropology anddescribed by Clifford Geertz (1973).Both the terms, metaphor and figure, for the moment, are being used to indicatea not yet defined concept which is capable of crossing (because it ignores them)the linguistic and political or scientific pre-existing barriers. Because of the factthat metaphors and images cross many barriers, they assume different meaningsin different contexts, often a new meaning over a new barrier. As a consequence,it is not possible to acquire a thick comprehension of a metaphor without acquir-ing a thick comprehension of the context which is tied or embedded to it; on thecontrary, it is not possible to use the minimum common meaning of images, i.e.to use their thinnest meaning, without reducing, to the minimum possessed by
3
Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli
Metaphors and Politics. An inquiry into thePolitical Discourse of the Italian Second Republic
Borderline
* Paragraphs 1-2-6-8 werewritten by G. Gangemi.Paragraphs 3-4-5-7 werewritten by F. Gelli

n.22 / 2009
the meaningless image, the meaning possessed by all the figures of speech. Inthe first case, metaphors are meant to be a linguistic instrument which recog-nises differences in the context and tries to weaken or annihilate them. In thissense, a metaphor is a dynamic symbol with a long run or strategic aim: to weak-en pre-existing barriers and to substitute to the many audiences inside a society,a new larger audience with external barriers and no internal ones. A metaphor isa linguistic instrument which, dynamically, reduce the number of linguistic bar-riers in a society. The first political consequence of this strategic aim is thatmetaphors do not contribute to maintaining bodies of knowledge whichstrengthen the traditional subjugating effects on non-privileged groups.In the second case, images are meant to be a linguistic instrument which ignoresdifferences in the context and operates inside these differences without trying tochange anything. Sometimes, in front of an opponent metaphoric meaning tend-ing to reduce the control of traditional elite on events, this elite elaborates newdiscourses and images in order to prevent the loss of control on events, when indifficulties. This is the well known tactic to change everything (in the formal dis-course) in order to change nothing (in the substantial discourse or in practice).An image is a static symbol with a short run or tactic aim: to obtain a larger con-sent without changing anything. It is a linguistic instrument which, statically,leaves unchanged the number of linguistic barriers in a society.From an analytical point of view, Thin Description is performed through statisti-cal methods; Thick Description is performed through the case-study approach-es; when we try, as Clifford Geertz suggests, an intermediate approach betweenThin and Thick Description, the best methods are comparative ones. BetweenThick and Thin Description, among the comparative methods, the thicker theadopted description, the more the analysis is near to case-studies; the weakerthe argumentative strength of the method (the best method to be adopted is theconcordance method or most dissimilar systems design) and the thinner theadopted description, the more the analysis is near to statistical methods. Thecomparative approach nearer to statistical methods is the difference method ormost similar systems design. This latter method produces ideal-types particular-ly when the systems design is used in diachronic models. An ideal-type is a notcompletely structured concept: its definition maintains a high level of metaphor-ical meaning and, to lose this, it must be more structured and adopted by quan-titative analysis through a synchronic comparative model. The last step is totransform ideal-types in well defined concepts when these concepts are empiri-cally collected through single- or multi-item indicators. It should be well known that Weber introduced the concept of ideal-type inorder to obtain two different, even if combined, results:1) to perform a surely non-dogmatic scientific analysis, being well defined con-cepts dogmatic in that they avoid new hypotheses and they are useful only whennew discoveries are not possible or predictable;2) to introduce a new social actor different from the individuals with an empiri-cal rationality and an empirical will and different from holistic actors (like class-es or States or nations) with a not at all empirical rationality and will. Ideal-typesare not completely empirical (and the point is not shared by many students ofWeber's methodology, but it is important) in that they are empirical in single
4

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
parts and metaphorical in the entire representation. In this sense, ideal-types area way to represent metaphorical and ex post rationality of empirical actors whoconcretely operate - the difference between ex ante and ex post rationality isconnected to the law of "hetero-genesis of ends" - with an ex ante and partialrationality and will. Hetero-genesis of ends is a philosophical concept introducedby Aristoteles, elaborated, among others, by Saint Augustine and Vico, andassumed as the focal point of sociological theoretical analysis, because it is con-nected to the problem of social prediction, by Auguste Comte, Herbert Spencer,Max Weber and others. In the XX° century, it has been assumed as the crucialpoint of their own philosophy by Hannah Arendt and Augusto Del Noce.Being not completely empirical, ideal-types cannot be obtained by indicators inthe neopositivistic sense, while they can be explored and described asmetaphors. Until the Seventies and Eighties, the ideal-type was expected to be the concep-tual instrument which should permit open and flexible knowledge, i.e. a knowl-edge considered not universal and not dogmatic. From the Nineties, ideal-typi-cal form of knowledge is going to be perceived as a synonym of stereo-typical(thus, dogmatic) knowledge. The most relevant reason for this new perceptionabout flexibility of ideal-typical knowledge (flexible enough in the Seventies, notat all flexible in the Nineties) is connected to the paradigm shift occurringbetween the two decades. The most relevant consequences of this new evalua-tion of conceptual analysis is that most researchers and political actors are notinterested in using well defined concepts and they prefer to use only metaphorswithout trying to translate these conceptual instruments in ideal-types, in theweberian sense, or in well defined concepts in the sartorian sense, i.e. using theTen Rules to define concepts able to travel, without any change, from a contextto another (Sartori 1984). The need for this paradigm shift is perfectly described by Foucault (1981): onceideas are structured in well defined and precise concepts (in the sense of Sartori,but according to many researchers of the Nineties, even in the sense of MaxWeber), they become an instrument to maintain non-privileged groups in a sub-jugating status. As a consequence, until the Seventies, only technical concepts(i.e. concepts structured according to Sartori's rules) were considered dogmaticand able to strengthen hierarchical order; nowadays, even flexible ideal-types areconsidered capable of producing the same result.
2. From the metaphor to the concept
Every time a term acquires a sudden central position in the political or scientificdebate, it loses its homogeneity and univocal meaning. This term has maintainedhomogeneity and univocal meaning while it has been used at the edges of thepolitical or scientific debate by drop out groups, while, entering a central posi-tion in the debate, the term has acquired a plurality of meanings, each differentinside a group or another. A few of these new meanings are so different as tobecome tendentiously incompatible. In this case, the term becomes stronglysymbolic, i.e. suitable to receive strong loads of emotionality and of meaningsconnected to values.
5

n.22 / 2009
The plurality of meanings and the strong symbolisation are the most convincingevidence about the fact that the term has become a metaphor or an image. The simplest metaphor or image used in political and scientific discourse is theterm "new" which is, often, used to produce titles or slogans. From the begin-ning of the modern era, it has been observed that many scientific discourses(and from the Great French Revolution the same has been seen in politics) arequickly abbreviated in a few words. These words are what we call a scientific (orpolitical) slogan. When it is not possible to synthesise a complex change in a slo-gan, the metaphorical meaning which assumes the significance of a bigger theo-ry or discourse is introduced with a term like "new". This is well known in manysciences. For instance, in philosophy, Francis Bacon used the term "new" twice: to differ-entiate his philosophy from the traditional one tied to the name of Aristoteles(Novum Organum) and to differentiate his utopia from the classic mythic world(New Atlantis). Galileo and Copernico, even if they introduced important novel-ties in philosophy and science, they never used the term "new" because theywere aware that this term should have a strong emotive impact on the powerfulreligious elite. Nevertheless, Copernico used a term (in his main work De revo-litionibus orbium coelestium) implying a movement in a circle (revolution as agoing on and a coming back) which assumed, from then, a strong emotive mean-ing and implied the same significance of new with a difference: new can be usedto intend a change even through a return to the past (new is not necessarily aprogress); revolution can be used to intend only a definitive and non-returningchange over the past. In this sense, Vico uses the term new (La scienza nuova)in order to present a change over Hobbes' idea that "man is a wolf to man"through a return to a revisited older philosophy.Since the great French Revolution, even in economics the term new has beenused and there have been questions between economists who used titles with-out new in order to say they were developing previous theories and economistswho used titles with new in order to say they were developing contrasting theo-ries over the affirmed ones. In 1817, Ricardo wrote Principles of Economy, whileSimsondi, in 1819, wrote Nouveaux Principes de Economie Politique. In 1820,Malthus titled Principles of Political Economy. In Italy, in 1815, Melchiorre Giojawrote a Nuovo prospetto delle scienze economiche. In political discourse, the slogan is defined as a short sentence associated with apolitical strategy or a political tactic. Even in this case, the term "new" indicatesa change and it can be used by leftists or rightists, by reformers or conservatives.What is important is that it is used in order to lower the power of a real elite orof an elite which is supposed to have got too much power. This is the reason whyAmerican electors listened to Wilson's slogan "the new freedom", Franklin D.Roosevelt "the new deal", John F. Kennedy "the new frontier", Nixon "the newfederalism", Reagan "the new American revolution", George Bush senior "thenew world order", Clinton "the new covenant", and so on.The term new is a word designating strong emotions and it is used in any strat-egy of lowering the control of power elite and, in any case, in the beginning ofany new political or scientific change. In fact, in any political or scientific begin-ning (of a new strategy or of a new theory), new is used as a metaphor or an
6

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
image and acquires an antithetic connotation towards the terms previously used.The metaphor or the image comes to be absorbed as the "new" against the "old"."New" and "old", in this case being referred to not well defined contexts, are themost convincing evidence of the fact we are in presence of a strong symbolisa-tion, in that we use new terms to introduce a new phenomenon or an old onerevisited. New, used in a strategic sense, to introduce new situations we are still unable todescribe, while we are sure they will be clearly understood in the future, is sure-ly a metaphor. When this strategy is going to be successful, the adversaries, whoare going to be weakened, to prevent this result, may introduce a slogan or animage with the term new. In this case, they try to strengthen their position bypromising to change everything (in a formal sense), without liking to changenothing (in a substantive sense). How Fichte observed once, the opposition between two strong symbolic terms(metaphors or images) is a reformulation of the opposition, between "I" and"not I", what every man and every emerging social group experienced at thebeginning of their life. Later, and only if the process has gone on and on, is it pos-sible to arrive at a subsequent phase of conceptual "maturity", where the initialopposition becomes a differentiation in the form of the distinction between "I"and "other than I". Groups needing to be influential (to maintain or to obtain more power) tend touse well defined concepts in that these strengthen the presentation of an objec-tive society and the differences positioned on a right/wrong scale (which is a dif-ferent form of the opposition between "I"/"not I"). Groups needing to defend their power, when in difficulties, tend to use imagesin that these manage to change, for a short run, the presentation of an objectivesociety and differences positioned on a right/wrong scale, while they are usefulin maintaining unchanged power relationships. In this sense, images are presentbetween the "I"/"not I" and "I"/"other than I" plans.Groups tending towards affiliation to other groups prefer to use metaphors inthat these weaken the presentation of an objective society and go towards theidea of a multicultural society where any difference is positioned on an "I"/"otherthan I" plan.When it happens, when the political communication passes to an "I"/"other thanI" plan, surely, a new phase has been opened and a new elite has lowered thepower of an old elite. This second plan represents a new phase of the cyclical lifeof concepts. In political and in scientific discourse, this is the phase commonlycalled “expert knowledge” and it is consequent to a definitive solution of politi-cal or scientific struggle to acquire or maintain consent. According to AlasdairMacIntyre, the expert social science knowledge is necessary to the leaders to jus-tify their capability of ruling an industrial Country and to the elites to justify theirneed of power and money (MacIntyre 1981). Nevertheless, expert knowledge starts with metaphors or images, while the sci-entific domain is described through a theory without the support of empiricalevidence; political knowledge starts with metaphors or images too, while thepolitical conflict is conducted by a collective movement not yet institutionalised.Expert knowledge operates the transformation of cognitive structure of knowl-
7

n.22 / 2009
edge (in the sense given by Robert K. Merton) in a social structure of knowledge(in the sense of Merton, again) through an empirical operative definition of con-cepts. In my opinion, the qualitative and the quantitative analyses are compati-ble, in the sense that the qualitative analysis of metaphors is a thicker descrip-tion, while a thinner one is the quantitative based on images or on well definedconcepts relieved through single- or multi-item indicators. Moreover, any quali-tative conceptual definition is as precise as the empirical evidence is convincingand as the argumentative forms are decisive. The problem is, if a problem exists, that, until the Eighties, it was supposed that,in comparative methods, definitions used in the most similar systems designwere nearer to metaphors than to well defined concepts, while terms used in themost dissimilar systems design were more precisely defined. Once, the most similar systems design was preferred to the most dissimilar sys-tems design (and the latter was less used) in that the former concurred in pro-ducing ideal-types with a moderate metaphorical meaning. Nowadays, on thecontrary, the most similar systems design is preferred in that this design dealswith examples with a high level of metaphorical meaning. In this case, the termexample is used in the sense of Vico who referred this term to the study of a sin-gle object or more single identical objects. An example may be described as alow-structured ideal-type with a high level of metaphorical meaning. In weberianterms, it can be described as an ideal-type produced by the concordancemethod, the comparative method with the less argumentative strength. Referring this problem to Foucault's argument quoted above, it can be said thatmetaphors are the preferred communicative forms used in bottom-up process-es in that weak argumentative forms (as the concordance comparative method)are preferred by social groups with a low social status and not so much power.This preference has been argued, first, by logicians of Franciscan medieval move-ment and reaffirmed by Vico in a complete form. Vico stated that social groupswithout or with a low power, in bottom-up communicative processes, start usingmetaphors and improving their argumentative forms through examples. On thecontrary, images and well defined concepts are preferred, in top-down commu-nicative processes, by elite or social groups with a real power. Well defined con-cepts are used by institutions (administrative, political or scientific) in bureau-cratic communicative processes. According to Foucault's previous statement, it can be said that those who con-trol words have the power to control politics, but in three different senses in thatwe have three different kinds of words. To control words means to controlmetaphors and images or to control well defined concepts or to control ritualconcepts in that it can be seen that the most important words have plenty ofmetaphorical meaning, or they are well defined concepts with a current relevantmeaning or well defined concepts without any residual meaning (i.e. ritual con-cepts). Those who control metaphorical meanings, (maybe) will control thefuture of politics; those who control well defined concepts control the present;those who control ritual concepts have controlled the past, but they are not yetcontrolling the present.According to the metaphorical theory of meaning, we can say that metaphors areentirely connected to pragmatics; images and well defined concepts are entirely
8

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
connected to semantics; well defined concepts without any residual meaning(i.e. ritual concepts) are connected to linguistics or syntax. Being metaphoricalmeaning entirely connected to pragmatics, it can be said that every metaphori-cal knowledge passes through no filter of logic or reflection and goes straight onto the head. Thus, thought is not connected to concepts, but, bypassing con-cepts, it is connected directly to the world. Well defined concepts pass, throughthe filter of logic or reflection, and through the power of those who controlwords (i.e. through the power of a presumed efficient class of scientific and polit-ical groups), to the world. Ritual concepts pass, through the filter of an illogic orunreflective phase, and through the power of those who controlled words in thepast (i.e. through the power of presumed no longer efficient classes), to a worldwhich existed in the past, but doesn't exist any longer.
3. Metaphors as effects
To continuously create concepts, concepts that are always new, should be theprerogative of philosophers (Deleuze 1990). Philosophy is the art of forming,inventing, and constructing concepts in the strictest sense of the word, even ifthe social sciences and the arts may also have the same creative power. Duringthe last century, however, philosophy failed in its particular vocation of intro-ducing new concepts, suffering first in competition with sociology, then withepistemology, linguistics, psychoanalysis, and logic, until it finally demeaneditself by matching the ability of the information sciences, advertising, design, andthe market, all clever enough to make their creative power known (Deleuze1990). Here, however, Deleuze introduces an important distinction: where phi-losophy differs is that it is no longer interested in creating concepts but ratherconsensus, the prevailing application being that of communicating and, thus, thefocus of attention has shifted to opinion. Deleuze thinks the concept occurs inthe discourse as a ‘kind of situation’ (an event) that establishes a meaningfulenvironment until then unintelligible (Villani 1997, 282)1. Thus, the concept isconstructed like ‘a new territory’ in the ‘level of discourse’, shifting the frontierof the meaning it contains.This article focuses not only on metaphors in and of themselves, but on dis-course as a form of action, in its possibility as a catalyst toward change, consid-ering, alongside H. Arendt, that putting forth the problem of action, also putsforth a political problem (Arendt 1989). The previous section2 explained how,when faced with introducing the content of something new, language takes ona certain symbolic force, through images and metaphoric quality, so as to expressthe new concept in the pre-existing “web” of human relationships . Arendt usesand explains the word ‘web’ as metaphor, (Arendt 1989, 183).In keeping with this definition of ‘concept’, metaphors, as meaningful events,can be intended simply as effects. “(…) Le ‘premier’ langage, ou plutôt la pre-mière determination qui remplit le langage, ce n’est pas le trope ou la métapho-re, c’est le discours indirect. L’importance qu’on a voulu donner à la métapho-re , à la métonymie, se révèle ruineuse pour l’étude du langage. Métaphores etmetonymies sont seulement des effets, qui n’appartienment au langage que dansle cas où ils supposent déjà le discours indirect(…)” (Deleuze and Guattari
9
1 See for details: “Qu’est-cequ’un concept ?” (Deleuzeand Guattari 1991, 21-37)
2 See this text: “From themetaphor to the concept”

n.22 / 2009
1980, 97). But what does it mean to think of metaphors as effects and what con-sequences does this definition imply? The key to this question lies in the factthat, by giving ideas fuller meaning, metaphors also intensify the meaning of thediscourse and, for Deleuze, meaning is always an “effect”, an effect–product forwhich the rules of production must be discovered (Vuarnet and Deleuze 1968)Meaning is not directly (and literally) represented but, instead, comes to be as aby-product. Metaphors invest the discourse with new significance. They arealways ‘custom-designed’ because there is always a wilfulness in their construc-tion and in how they are placed in a phrase; there is always an individual who isresponsible for their very beginning. As such, they are seeped in calculation, butone to which they can not be entirely led. The potentiality of the meaning opensin the processes of social interaction. Thus, if they are truly effects of theseprocesses, these strategies for producing meaning, and in as much as they arethe product of discursive actions, it cannot be forgotten that they have thenature of an event, in that they are really meaningful events, and the subject isprecisely what is missing in the event (Deleuze 1990). And thus, in as much asthey are meaningful events, they create effects. A metaphor can introduce, it canset off but not determine all of its effects. Moreover, it creates a space ‘outside’the phrase itself or, rather, brings into the phrase meanings that would not haveotherwise been expressed there. Operating in a manner Deleuze would defineas rather alchemic, metaphors, in expressing concept, modify the environmentof the meaning into which they are inserted. This is how metaphors have cre-ative power and make conjunctions, as devices that set off this relationship with‘what is outside’. A metaphor functions as a kind of frame: a frame that makes a‘concrete bridge’ with the outside .In this sense it can be understood why a cre-ative thought, which aims at introducing new concepts, is necessarily charac-terised by a metaphoric style of expression.“(…) Le nouveaux, l’intéressant, c’est l’actuel. L’actuel n’est pas ce que noussommes, mais plutôt ce que nous devenons, ce que nous sommes en train dedevenir, c’est-à-dire l’Autre, notre devenir-autre. Le présent, au contraire, c’est ceque nous sommes et, par la même, ce que nous cessons déjà d’être. Nous devonsdìstinguer non seulement la part du passé et celle du présent, mais, plus profon-dément, celle du présent et celle de l’actuel” (Deleuze and Guattari 1991, 107)3.Metaphors function in discourse to produce a transfer of meaning, generatingmeaningful effects that, to a certain extent, can also be controlled, in the con-nections they establish, from the very beginning. There is, however, ambiguity inmeaning as well, in the manifestation of the many possible meanings and thelack of a precisely defined concept. A frontier opens between the sense-makingthe metaphor emits and the interpretations we can understand by experiencingthe existing reality. The very term I have used, ‘frontier’, has a metaphorical qual-ity, and thus its use can produce effects with different meanings, according tothe context in which it is placed4. Or rather, the use one can make of a metaphoris always individually limited, in particular when it is used to support a conceptof change. The discourse can be taken even further, by observing that the termswhich make up a metaphor are generally heterogeneous both among them-selves and in the connections the metaphor makes between them. A develop-ment – a multiplication – of the meaning of the single terms is activated, which
10
3 More precisely, Deleuzequotes Archéologie du savoirof Foucault
4 Frontiers are physicalspaces and mental con-structs, and their meaning isnot univocally defined. i.e.,quoting John Friedmann(1996), the concept of fron-tier to an American reader

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
is characterised by non-parallel evolutions among them. An example will helpmake this clear. In Mille Plateaux Deleuze and Guattari metaphorically affirmthat “un livre étant lui-meme une petite machine”(1980, 10); in virtue of thismetaphorical connection, they can then ‘coherently’ affirm that ‘Kleist et unefolle machine de guerre, Kafka et une machine bureaucratique” (Deleuze andGuattari 1980, 10).
4. Metaphors as a frame for action
Images can often carry symbolic and metaphoric contents, even if images andmetaphors are not exactly the same thing. Metaphors intended as ‘figures ofspeech’5 can be understood as images even if they introduce a symbolic con-tent, they lose in part their own important character as sense-making events andtheir function of transferring meaning. Rather, the operation that take place hereis that of precisely defining and limiting the meaning to whatever extent possi-ble, trying to reduce the sense-making effects that can be set off, with the goal ofmaximising control and interrupting any concatenation that refers to meaningsnot entirely expressed within the phrase itself. This way of proceeding is characteristic of quantitative content analysis, the aimand usefulness of which lies in achieving, through a series of operations, a ‘nor-malisation’ or standardisation of the discourse that has to reach as widely acces-sible a form as possible and thus an effective communicative power. Metaphors,like meaningful events that enlighten the statement and like all the elements thattend to introduce a degree of indeterminateness in communication, are also nor-malised through various techniques. Reduced in their potential autonomy ofmeaning, they are ‘resolved’ so as to give a sort of necessary ‘repetition’ of mean-ing6. Hannah Arendt’s reasoning in The Human Condition (1989, 38-44) is par-ticularly enlightening on this issue: at a certain point in history, identifiable in themodern era, there is a passage from the political sphere, which is tightly boundto action – the presupposition of which is plurality –, to the social sphere whichreplaces action with behaviour, as the primary modality of relationshipsbetween human beings. “…Men behave and do not act with respect to eachother”(Arendt 1989, 42) and society’s intrinsic demand for conformity levels outthe exceptions (beginning with those of meaning), throwing them out as irrele-vant, rather than considering them well-founded. According to Arendt “this ten-sion lies at the root of the modern science of economics”(Arendt 1989, 42), thebirth of which coincides with the rise of society and which, with its major tech-nical tool, statistics, becomes the social science par excellence. “(…) The laws ofstatistics are valid only where large numbers or long periods are involved, andacts or events can statistically appear only as deviations or fluctuations(…)”(Arendt 1989, 42). We spoke previously of the essentiality of the metaphor-ical level of the meaning in expressing new contents and of the fact thatmetaphors are also meaningful events, fruit of discursive actions begun by some-one who wants to find common expression. Many acts are undertaken in theform of discourse. In particular, “(…) The new always happens against the over-whelming odds of statistical laws and their probability, which for all practical,everyday purposes amounts to certainty; the new therefore always appears in the
11
may evoke processes ofsocial transformation, as ithas a dynamic meaning,being strictly connected tothe American history ofpractices and experiences offrontier developmentsthroughout time. To aEuropean reader it can sug-gest the idea of static bound-aries, the experience of lim-its, the border that cannotchange through processes ofsocial transformation.5 According to the definitiongiven in previous section ofthis text: “Metaphors, Imagesand Ideal-types”.
6 See this text: “Metaphors,Images and Ideal-types”.

n.22 / 2009
guise of a miracle (…)” (Arendt 1989, 178). A ‘new’ content cannot therefore doanything but, metaphorically, ‘ri-velare’ in the twofold meaning of the word: toreveal and, at the same time, to re-veil. In the previous section7 an explanationwas given as to why this is of particular interest to certain administrative, politi-cal or scientific groups and institutions that, if they want to bring about changeand control the future of politics and practices, have to pose themselves theproblem of how to obtain control of the discourse that ‘dictates’ change, whenthe latter itself does not as yet exist but is presented as a goal or a project. Inshort, a more subtle relationship between power and consciousness. WithFoucault, we can say that words, in connecting themselves one to the other, ininvolving or promoting themselves, find their foundations and their conditionselsewhere. They are expressed there, but they are not entirely there... as poweris not an institution, nor a structure, nor a certain potency to which some areendowed: it is the name that is given to a complex strategic situation in a givensociety (Foucault 1976). And, in this sense, power comes from below.Thus, one now understands well how the conceptual space and that of analysisin which we are interested in focusing is that of recognising the strategic char-acter of discourse. It constructs itself initially around an objective, or activatesitself like a device around an urgency, often in the need to represent contentsthat are in conflict with dominant paradigms. Thus one can speak of the exis-tence of a particular form of action that is discursive and of a group of ‘discursivepractices’ (Foucault 1976; Arendt 1989). One considers, therefore, the problemof a kind of knowledge meaningful for action, in the conviction that the way inwhich political, social, power, etc. relationships are structured and representedin a given context – often relying precisely on the use and invention of imagesand metaphors in expression – strongly conditions the type of action towardwhich things will move. “...Every analysis is informed by some metaphors –clockwork, waves, currents, building – through which its relationships becomeimaginative, graspable. The metaphor implies the kind of actions which are pos-sible or impossible by that analogy; and so, irrespective of its ability to representreality, one metaphor may inhibit or encourage action more than another”(Marris 1987, 141). In this sense, images and metaphors have a concrete influ-ence on the choices of policies and strategies of intervention that raise the issueof producing action toward social change.This leads to fundamental consequences or, rather, makes it possible to influ-ence the decisions that will determine transformations, not necessarily actingdirectly within the decision-making process. One can, however, try to influencedecisions in another way, beginning from how knowledge is structured and, inparticular, from the perception of the issues involved, or, rather, the way inwhich ‘reality’ is framed, acting upon the way in which people in a given situa-tion define problems and, as a consequence, make choices. (Crosta 1998, 16-21). The problem can therefore be expressed in terms of “which knowledge forthe action”, and the primacy among forms of knowledge is precisely that, if con-sidered “from the point of view of the usefulness for the action”. (Crosta 1998,15). If one follows this path, one discovers that the knowledge used in the actioncomes out of the combination of many forms of knowledge and, in this sense,the usable knowledge corresponds only in part to analytical and expert knowl-
12
7 See this text:“From theMetaphor to the Concept”

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
edge, and is constituted above all by ordinary and interactive knowledge. “Theprofessional social inquiry (PSI) is only one among several analytical methods,because other forms of information and analysis – ordinary knowledge and casu-al analysis foremost among them – are often sufficient or better than PSI forsocial problem solving8” (Lindblom and Cohen 1979, 10). Social problem solvinghas come to be largely identified with a rationalistic, scientific, intellectual inves-tigative process, and ordinary knowledge9, casual empiricism, and other non-sci-entific or non-professional methods of knowing and analysing are excluded(Lindblom and Cohen 1979, 11). Lindblom and Cohen make the example ofmany social scientists, like J.Schumpeter, T.Parsons, R.Merton, A.Hirschman,etc., who have worked almost entirely with the ordinary methods “...despite theprofessional development of specialised investigative techniques, especiallyquantitative” (Lindblom and Cohen 1979, 16). And with regard to interactiveknowledge as an alternative to PSI, and interaction as a method of problem-attacking, they basically affirm that “a given problem can be attacked by under-standing, thought, or analysis ... of that very problem, or by various forms ofinteraction among people, in which what they do, rather than what they or any-one else thinks (or understands or analyses) about that problem moves towardthe solution or preferred situation” (Lindblom and Cohen 1989, 20). It is as if tosay that one cannot take away from the definition of a concept the commonpractices in processes of social interaction, nor from sense-making those of thesocial learning processes.
5. The changing in the mythical political apparatus
It is necessary, therefore, to focus our attention not only on the analysis of con-cepts but also on the means of their production and, in general, on the process-es of sense-making and the types of action their use implies (the problem ofeffects). This brings us back to metaphors, to focusing on the strategic use ofimages and metaphors in producing contexts of meaning in which to obtainthough effect the encouragement of a determinate kind of action and to dis-suade another, something quite frequent in political discourse. Up until now I have continued to refer to both metaphors and images. Thiscomes out of what can be obtained from previous analysis, yet is not without acertain discomfort. In the political discourse traditionally constructed by relying on an entirely myth-ical apparatus, we can discover the frequent use of images for communicatingcontexts of complete meaning and for obtaining the greatest simplification use-ful in constructing consensus. The appearance of metaphors is rarer, more iso-lated and necessarily introduces a greater complexity into the interpretativeframework and the contents of meaning. But in the today’s mythical construc-tion of the political discourse – as we will observe further on by analysing someexamples within the current Italian political debate – the distinction betweenimages and metaphors is no longer so clear-cut as it might have been inapproaching a traditional analysis of discourse. What we discover now is a morewidespread metaphorical dimension of content, produced by a varied group offigures and images, by the symbolic weight of certain expression; yet it is more
13
8 Lindbom and Cohen (1979,4) indicate “problem-attack-ing” as a more accurateterm then “problem-solving”9 “By ‘ordinary knowledge’,we mean knowledge thatdoes not owe its origin, test-ing, degree of verification,truth status, or currency todistinctive PSI professionaltechniques but rather tocommon sense, casualempiricism, or thoughtfulspeculation and analysis. Itis highly fallible, but we shallcall it knowledge even if it isfalse. As in the case of scien-tific knowledge, whether it istrue or false, knowledge isknowledge to anyone whotakes it as a basis for somecommitment or action. Forsocial problem solving, wesuggest, people will alwaysdepend heavily on ordinaryknowledge” (Lindblom &Cohen 1979, 12)

n.22 / 2009
difficult to isolate a single meaning, one often encounters ‘weak’ metaphors.Considered in terms of communicative efficiency, relying on images and figuresis often rather pregnant and opportune so as to signify with clarity and expressthe orientation toward a type of action which in that context of meaning is pos-sible (realisable). Thus, more frequent use is made of strong images capable ofhaving an influence, rather than ‘strong’ metaphors. This may also have some-thing to do with an important change that has increasingly characterised the lastdecades; that is, the opening of decision-making processes to include the par-ticipation of an ever more numerous and varied group of players, with the resultof crowding and complicating the decision-making arena, as well as spreadingthe use of bottom-up processes and participatory procedures. The previous sec-tion has demonstrated how in top-down processes involving institutions well-defined concepts and strong argumentative forms are preferred over commu-nicative and weaker argumentative forms typical in bottom-up processes andpreferred by social groups etc.It is also necessary to consider that metaphors, in as much as they are linguisticdevices, do not elude the transformations of discursive practices and commu-nicative trends, which have been required to become increasing simple andbanal, reducing of the meaning evident on the surface. Moreover, it is difficult toquestion the level of communication by leading everything back to language,which would be just one issue, while we are instead witnessing ever greatercrowding of codes, their multiplication and pluralisation. “(…) Il n’y a pas delangue en soi, ni d’universalité du langage, mais un concours de dialects, depatois, d’argots, de langues spéciales…Il n’y a pas de langue-mère, mais prise depouvoir par une langue dominante dans une multiplicité politique (…)”(Deleuze-Guattari 1980, 14). This heterogeneity of ways of speaking and givingmeaning, of passing on meaning, often has the problem of coexisting in thesame context of relations (whether it be debate, actions, practices, etc.). And itcan also be said, quoting Marc Augè (1993), that the figure of excess (“excess oftime ”, “excess of space ”, “excess of the self”), the essential modality of the sur-modernity’, that is, the anthropological situation in which we are living; and thecondition of the sur-modernity is characterized by an over abundance of events,to which one must continuously give significance, something that has the effectof an over-investment in meaning. The operation of transferring meaning that is released with the use of metaphorshould be seen more generally in the system of relations in which it functions.An attempt has thus been made to isolate metaphors and images, ‘figures ofspeech’ in analysing political discourse; yet, more generally, there is greaterinterest in the symbolic dimension of meaning (of the discourses), in the capac-ity to establish and try out relationships, to produce in a chain-like fashion; tokeep together the multiplicity of meanings, the plurality of the possible defini-tions of one and the same concept; and to compose diversity.In short, the following ‘properties’ of metaphors have emerged:-to be tools of linguistic expression (intentionally sought after; used, in particu-lar, by kind of analytical knowledge)-to influence action (strategic expressions in the construction of a political or cul-tural project)
14

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
-to be effects-products, meaningful events (not entirely intentionally soughtafter, which can also originate in processes of social interaction or from signifi-cant experiences)-to keep together a plurality of meanings and definitions for one and the sameconcept, with varied degrees of incompatibility amongst them as well -to frame the significance, produce the meaning and, in general, communicate incontexts of innovation or change (expressions of becoming)-to read the (new) differences (analysis of the other) – figures of transformation-to make the (new) differences (pragmatics of the other) – frontier regions ofthe significance
6. About political images and political communication
Crises and emergencies are discursive political constructs which are presentedas urgent and call for out-of-the-ordinary intervening. Both are selections of dif-ficult situations suggesting the willingness to suspend normal and routineprocesses for immediate and decisive intervening. Crisis is, in Italian politicaldebate, a difficult situation originated by a loss of control over factors whichmust or should be in control by political elite. Emergency is a difficult situationoriginated by factors which are not and cannot be in control by political elite.The prevailing of a metaphor or of an image of crisis is the proof of a lack of effi-cacy and efficiency, while a metaphor or an image of emergency is frequent withan efficacious and efficient political elite.This distinction between crisis and emergency is not relevant in the standardview of empirical paradigm, i.e. in a theory which rests on the neopositivisticbasis which, in Italy, has not been assumed in a conventionalist way, but it hasbeen assumed in a realistic one. Realism recognises only the value of logic andfacts and it does not recognise the value of rhetoric. Realism considers rhetoricas a set of justifications coming "from above", in the sense they are external tothe critical situation. In this essay, rhetoric is intended as an integral part of thepolitical process and it is hypothesised that different uses of rhetoric may comefrom contrary and even incommensurable discourses. In other words, rhetoric isemphasised as an important part of any political process in that it concurs to theconstruction and re-construction of the process, prepares a re-reading of factsand events and a re-formulation of metaphors, images and practices, sometimesa re-definition of well defined concepts. Different languages construct different realities, different facts (in the sense theyassumes different meanings) and different processes (in the sense they searchdifferent ends). Thus, politics can be seen as a strategy which is or is not able tounderstand, learn from and act in accord with different practices or policies.Rhetoric is a narrative important means of persuasion in order to incorporatepolitics inside policies. Politicians maintain their consent when, using rhetoric narration of the situation,they appear to be in control of the difficult situations. In Italy, politicians seemto be in control of difficult situations when they are able to rename difficultiesavoiding the term crisis and adopting the term emergency. To be in control ofdifficult situations means, first of all, to be able to avoid the metaphor or image
15

n.22 / 2009
of "crisis". Italian politicians controlled emergencies, in the last decades, impos-ing new taxes on contributors and saying there is the need of a period of aus-terity. Italian politicians tend to construct emergencies as political tools usedmanipulatively as the means for other ends. In fact, the metaphors or images ofemergencies and austerity have been used in order to obtain consent to moretaxes. These rhetoric plans have collapsed with "Mani Pulite" (a strong interven-tion of judges on political corruption). On the contrary, crisis is the metaphor orimage prevailing over politicians when they are unable to react to difficult situa-tions constructed by others (such as opposition, the media, the public, etc.) orby they themselves. Emergencies and austerities have been used by Italian politicians for almosttwenty years in order to realise, without an a priori project, an expensive welfarestate which has taken this country to the conclusion of having one of the high-est level of taxation in Europe. Political Italian actors used, in the past, themetaphor or image of emergency to maintain and invert a diminishing supportby electors, to re-construct and re-articulate the beliefs of supporters, to convertopponents to collaboration (particularly left politicians of PCI, ItalianCommunist Party). As long as their rhetoric discursive tactic was successful,Italian mass media spoke of emergencies and of unity of parliamentary majorityand parliamentary opposition during emergencies as a positive result for thenation. When this presentation became a rite and it lost its previous consent,mass media presented the new image of "consociativismo", "practice of associ-ating the opposition in government decisions", in order to say that majority andopposition agreed, through emergencies, to realise policies of great expendi-tures, public deficit and taxes."Consociativismo" has been made possible by the metaphors or images of emer-gency in that the metaphorical meaning connected to emergencies, suddenlyaccepted by political actors in the majority and at the opposition, unified prac-tices and actions in the past (while the metaphor or images of crisis, obviously,should have divided them). "Consociativismo" has been made possible even bythe fact that, in the Seventies and Eighties, the majority (the ChristianDemocratic party - DC - and their allied) and the opposition (the CommunistItalian Party - PCI) agreed on the fact that policies of peripheral institutions(Regions and Communes) should be encouraged. From 1970 to 1974, a tributaryreform produced a strong growth of State expenditures; from 1974 to 1976Regions ruled by leftist (PCI and allied) and Regions of the South of Italy paidmore than they received from the State for education and social services; theirdebts became an emergency and they were completely assumed by the State inthe subsequent period; and so on, with a strong growth of the debt of the Stateuntil 1992. A second problem is connected to the fact that the politicians through the mediaaccomplished, before "mani pulite", this communicative tactic by: 1) framing the long run process and promoting particular aspects of politicalreality in order to present many emergencies and austerities and no strategy toproduce a higher level of taxation (the ex ante logic and willingness should bedescribed as many different solutions to many different emergencies, while theex post logic and willingness should be described as a unique strategic plan to
16

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
introduce an expensive welfare state);2) reducing reasons of crises or emergencies to a few political slogans whichhave no overlapped value and representing the reality as a conflict betweenopponents without anything in common (even while they agreed, being associ-ated in government decisions, they were presented through slogans whichdescribed any common decision as two completely different actions aiming atdifferent ends); 3) presenting the idea of different ends in equal decisions as an objective repre-sentation having a truth status, thus normalising their existence constituted overthis opposition (as a consequence, in Italy, the political communicative tactic ofmass media - which were so close to political elite - produced ritual narration offinancial experience which was not intended to be transformed in metaphors,thus in new forms of ideal-typical knowledge or in new well defined concepts).The XII Parliament’s majority, during 1996-2001 legislature, the first majorityelected after "mani pulite", is constituted by a great part of the political majorityand by almost the totality of the leftist political opposition before "mani pulite".Thus, they are arguing according to images, thus framing the long run processgoverned by consociativismo. They see too many emergencies and too manyshort run decisions where a long run vision could easily see a unique strategicpolitics in order to construct an expensive welfare. The present majority hasgiven to the country - with the exception of seven months during which SilvioBerlusconi, the leader of the present opposition, ruled the government - all theprime ministers from 1992 to 2001 (Amato and Ciampi from 1992 to 1994, Dini,Prodi, D'Alema and Amato, again, from 1995 to 2001). However, the leaders ofthe XII Parliament’s majority were repeating, in the first years (1996-97) of thepast legislature, they had not yet governed; they intended they had not yetobtained the possibility to realise their political project. Thus, electors shouldwait until 2001 before judging the majority's action in ruling the Country.Nevertheless, they never tried to present a strategy to govern and to formulateany metaphor to communicate this strategy to the electors. From 1992 to 2001,they expected to communicate to electors through the short run images elabo-rated in the past, at the time of "conscociativismo".The most relevant difference between an image and a metaphor in politicaldebate is that political actions which have only temporary consequences areoriginated by an image, i.e. they may have heavy consequences in the short run,but not so heavy consequences (the effects are described as, and actually are,quite completely absorbable in time) in the long run; and political actions whichhave relevant consequences in the long run are originated by a metaphor (theeffects are not described as, and actually are not, absorbable in time).The leaders of the XII Parliament’s majority, saying that they had not yet ruledthis Country, are conscious that a Country may be ruled only if a political coali-tion is capable of presenting a strategy, of communicating it through metaphorsand of realising it. In this sense, they were right: they never ruled the Countryfrom 1992 to 2001; and the evidence was in that they proposed only short runimages, realised only tactical interventions and revealed no strategy. The prob-lem has been that, having not produced any new metaphor, they have not beenseen by electors as politicians ruling the Country with a strategy. This has been
17

n.22 / 2009
the evidence of the XII Parliament even it realised an important adhesion to theEuro money.The XII Parliament’s opposition, on the contrary, has given to the electors theidea of a strategy using, since 1994, the metaphor of a quite complete changeover the passed "consociativismo". Their slogan has been: "less State, moreMarket". This slogan is surely an image with a strong metaphorical meaning, inItaly. Silvio Berlusconi explained that the emergencies of the past have beenfaced, by the exponents of "consociativismo", with a growth of the presence ofState over Society. Then, he assured that, with the strategy he was proposing, itshould be possible to obtain one million new jobs in a short time. Now, in the 2001 elections, Italian electors are not sure that the Centre-Rightistslogan is a true metaphor. It is presented as a metaphor, in that the Centre-Rightist leaders are saying they intend to realise a deep change in the govern-ment of the Country. During the 1994 electoral campaign, to assure that theywere going to change everything, they were saying that the winners shouldrefuse any compromise with the losers. "No prisoners!" has been one among themost lucky slogan of the new political party, founded by Berlusconi, Forza Italia.The new leader, Berlusconi, won those elections with a unique image ormetaphor capable to translate the many short run solutions adopted and called,from 1970 to 1994, crises and emergencies, into a unique long run policy: heexplained his adversaries had ruled the Country, in the past, with an expensivestrategy of public expenditures in order to transfer resources from productivecategories to unproductive ones; he assured he would avoid errors of the pastand of the "consociativismo" and realise a less expensive policy of public expen-ditures in order to obtain a reduction of the Italian deficit of the State which hasbecome one of the most relevant public deficits in the Western Countries. This metaphor convinced the electors, even if used by a heterogeneous coalition(a Centre-Right alliance structured as “Pole of Liberty”, its name in the North,where the alliance was between Forza Italia (a Party founded by SilvioBerlusconi, an Italian tycoon of mass media) and Lega Nord (almost a secession-ist or ethnic Italian party), and “Pole of GoodGovernment”, its name in theCentre and in the South, where the alliance was between Forza Italia andAlleanza Nazionale (a Party founded in the past by nostalgic men of ItalianFascism). The heterogeneity of the winners has been the reason for the shortduration of the coalition: they broke the alliance after seven months and theminority (those who began the Parliament as the opposition), with a fewdeputies and senators who passed from the Pole to the Centre-Left Alliance,ruled the government until new elections in 1996. The problem is that the image used by the winners in 1994 had (and has in the2001 re-edition of the 1994 coalition) a double meaning which should producetwo different strategies, in that, it was too ambiguous to be considered ametaphor. Sometimes, two metaphors, i.e. two political strategies each capableof changing a Country, when too strongly related each to the other, became aunique image with no strength to change almost anything. In 1994, while ForzaItalia considered taxes as a transfer of resources from the most productive cate-gories to the least productive ones, its Northern allied in “Polo of Liberty”, theLega Nord, considered taxes as a transfer of resources from the most productive
18

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
Regions to the most unproductive ones. This heterogeneity was evident fromthe beginning in that Forza Italia was presenting to electors the Centre-Rightpolitical program determining that productive categories (entrepreneurs, arti-sans, traders, professional men, etc.) were bled by unproductive categories(those guaranteed by Trade Unions or living of public expenditures), while LegaNord was presenting the Centre-Right political program determining that pro-ductive Regions (those in the Centre-North) were bled by unproductive Regions(those in the Centre-South). When the Centre-Right Coalition collapsed, in 1995, after a short period of elec-toral difficulties, Lega Nord presented, in 1996, a political program to realise “fis-cal federalism” (a reduction of the transferring of resources from the North tothe South Regions) and communicated it in form of a metaphor: that ofNorthern Regions bled by Southern Regions. This communicative strategy hasobtained a lot of votes in the NorthEastern Regions; enough votes to weakenparties which formed, in 1994, “Pole of GoodGovernment” and, in 1996, pre-senting their coalition as “Pole of Liberties”. The consequence has been that theCentre-Left coalition obtained the majority of elected members at the Parliamentand it is, now, ruling the Country. Nevertheless, the 1996 elections showed thatit is the political communication, through metaphors, which make the victory. Infact, in 1999, at the European elections, when “Pole of Liberties” appeared to theelectors as a weak supporter of the metaphor that productive categories are bledby unproductive ones, the Lista Bonino (the Italian Radical Party presented itslist under the name of the European Commissary Emma Bonino) used, in a moreconvincing way, the same metaphor and the list obtained a lot of votes (morethan 10%) in many Regions in the North and in the Centre. Thus, Forza Italia, inthe 2000 regional elections reconstructed the 1994 coalition (Forza Italia, LegaNord and Alleanza Nazionale) and represented the 1994 strategy and metaphor.This produced the result that the coalition won the 2000 elections, while theLista Bonino lost all the votes obtained in 1999 and obtained the votes, more orless, received in the past by the Italian Radical Party. Now, with the same strate-gy and the same metaphor, the Centre-Right coalition won the 2001 politicalnational elections.As in 1994, we are not sure if the two strategies will become a unique strategy andthe two metaphors will be practised as a unique metaphor capable of changingthe Country or as a unique image unable to change anything. As in 1999, whenEmma Bonino was able to suggest to electors that Forza Italia was unable tochange the Country because its leader, Berlusconi, had become rich and power-ful under "consociativismo" because important politicians had helped and sup-ported him, many political adversaries are stating that Berlusconi has no intentionof changing anything. Being interested only in defending his fortune and in pro-tecting himself by judges, according to these critics, his communicative strategyis only an image and it cannot assume the important role of a metaphor. Speaking about the use of metaphors and images in Italian politics, last but notleast, the problem is connected to the difference that can be perceived betweenpopulist and democratic leaders. Before "mani pulite", populist leaders werewith a low, and even without, consent. Nowadays they receive more consentthan democratic leaders. The problem is that populist leaders speak to the gen-
19

n.22 / 2009
eral population using more images than partisan rulers and saying that what theyclaim is obvious and evident to the whole electorate. Partisan or democraticrulers speak to those who support the politicians candidacy using a technical dis-course and saying that what they claim is true or that the opponent is passive,immobile, or paralysed. Populist leaders seek to stimulate participation by thewhole electorate. Partisan or democratic rulers seek to stimulate participation bythose voters likely to be convinced. Images of passivity, immobilisation andparalysis are used in this strategy.Political adversaries of a populist leader are presumed as a few politicians whoare wrong or dishonest or, in the case of the populist leader of Lega Nord, tiedto the contrary interests of the South. Political adversaries of a partisan leader arepoliticians and their electorate referred to contrasting interests (they are pre-sented as the interests of a minority, never of the majority).The first electoral image of a populist leader is the idea that he speaks to thewhole electorate, while the first electoral image of a partisan leader is the ideathat he speaks to the majority (with extreme partisanship, this majority is pre-sented as a virtual one, i.e. the avant-garde of the majority).Partisan leaders are aware that there are legitimate alternative ways of looking atan issue, while populist leaders think in terms of right-or-wrong issues and theyscarcely tolerate ambiguity in the array and don't tolerate at all what they claimto be wrong.
7. Making sense of some cases of metaphors used in the political dis-course to launch projects of institutional reform.
The following examples are introduced with the goal of clarifying the role ofideas in policy change, considering the very different effects (with the exclusionof certain contradictions) that can come out the use of certain metaphors onbehalf of certain groups and political movements who act in an establishedorder, promoting reforms or radical acts.
7.1 Structural metaphors in inner-city problem solving. Reflecting on someBritish programmes.In Marris’ analysis of the influence the Left exercised on the British governmen-tal politics and public policies for inner city problem-solving and actions of socialchange (at the time of the “Community Development Project Teams”, and the“Docklands Action Groups”), the dominant metaphor that emerges is ‘struc-ture’, thought of in reference to the structure of contemporary capitalism. Theinterest was “to represent the interconnections between the (impoverished)neighbourhood, city, nation and the international economy as an indivisible setof relationships” (Marris 1987, 141). The reason for this was bound to a strategythat in and of itself was rather simple: demonstrating that neighbourhood prob-lems were structural problems, strictly linked to all levels of the political andsocial system, they (the reformers) claimed the need for structural planning;attacking the problems of a part belonging to the system involved rebuilding thestructure of the society. When “the government’s White Paper on inner cityproblems adopted the language of structure, it also necessarily accepted a larg-
20

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
er and more direct responsibility for what was happening” (Marris 1987, 141).Let’s follow the reasoning of Marris’ essential affirmations. The definition of sys-tem suggested by the structural metaphor represents all relationships of societyand interactions amongst them as part of the structure; they form a whole inwhich all the relationships are thought to be predetermined. Thus the alliancesas well as the decisions are constructed in strategies based on a shared theoret-ical understanding, which is conceived apart from and before the action itself. Itdominates an ex-ante rationality pattern, the connections are static and theyhave a hierarchical character. “Principles of behaviour are established at a levelof abstraction high enough to inform very different kind of relationships” (Marris1987, 146). In such a context it is very difficult to produce social change by act-ing from within the system. Every behaviour that does not reproduce the exist-ing dynamics is bound to be considered as an anomaly in the structure andthought of as something to be corrected. One hypothesis is that change, then,can come from the outside; but it will, in any event, conflict with the establishedorder that is widely recognised and internalised. On the contrary the new polit-ical movement proposes to undo the existing order presenting perspectives ofconsiderable uncertainly for the future, up to the point that it does not manageto establish an effective alternative structure. Whether it be reform efforts ormore radical actions, the major problem is to produce a significant change in theexpectations that govern relationships. This according to Marris, in a structuralmetaphor, is the key to achieving social change.It is not however a question of striking directly or of undermining the pre-sup-positions on which the established order is based, rather than that of overturn-ing the very structural analysis and metaphor, and the terms of its reasoning. Inother words, to break the frames. Indeed a major limit of the structuralmetaphor laid in the fact that it gave a representation of power as absolutely dis-tant, inaccessible to ordinary people. From here it followed that, in the longterm, this kind of understanding of inner city problems evolved in a way thatbegan to inhibit action, such that any reform initiative, even at a local level, wassubject to attempts of co-optation or suppression, or embedded into the systemthrough incremental gains, while more radical acts appeared as an abstract goaland with a disruptive character. It worked as long the daily actions of the peoplereproduced the logic within the system, its own set of assumptions, rules, etc..According to Marris, changing things and influencing policies and institutionalpractices in a situation like this meant acting on the knowledge itself the peoplehad of the issues at stake, beginning from the very perception of what makes theproblem and from the ways of organising consensus around this perception.Thus, the thing to do was to introduce new persuasive metaphors, a new senseof the relationships to be created, alternative to the structural metaphor that waskeeping any strategy of social transformation from becoming effective. This with-out forgetting, as Marris warns, that “the coherence of a paradigm does notdepend on ideological conformity. Different ideologies may converge on corre-sponding principles of social relationships out of which a new paradigmemerges. As different kinds of movements – social, political, environmental,artistic – recognise this correspondence and support each other, the experienceof working together begins to define pragmatically what the paradigm is” (Marris
21

n.22 / 2009
1987, 154). This affirmation is particularly interesting because it recognises thevalue of interaction as a method of knowing and thus the centrality of knowledgethat is developed during the action, which through shared experience, takes oncommon meaning.
7.2. ‘Proofs’ of federalism. Local political leaders and national party politicsface-to-face.The federalist metaphor has worked as a frame for political action and hasinspired different ideas and interpretations of local autonomy and (more or lessresponsible) territorial self-governing in the last twenty years of history of theItalian Republic.In particular, in northern regions in Italy, the federalist argument has assumedvarious slants, significance and political uses. Though Italy has inherited, from itspast history, macro-regional traditions of federalism, composing a complex geog-raphy of identities and territorial cultural patterns, the federalist debate in thoseyears was monopolised by the northern centralisation of federalist issues, withthe creation of a “Questione Settentrionale” (i.e. Northern Question) as opposedto the well-known “Questione Meridionale” (i.e. Southern Question). Northernterritorialisation of federalist issues had grounds in the formation of new politi-cal subjects (parties, movements or groups) and has found its laboratories atregional and local levels of government. However, movements, protests and political parties have embraced the cause offederalism to give voice to different pleas and demands. The federalist agendalooked like a laundry list, a miscellanea of intents and projects, therefore, far wasit from constituting a credible way of building a federalist democratic politicalsystem. Nevertheless, political leaders endorsing the cause obtained public pop-ularity and mass media prominence.Under the federalist umbrella we found, for instance, the need for structuraladministrative and political reforms for the efficiency of the State and of publicexpenditure (a matter of commitment, especially for reformers of centre-left par-ties during the ‘90s); the revival of old racism and North-South discrimination,and the emerging of new discrimination, towards immigrants from outside Italy;the emphasis on the territorial identity of local communities, by tracing bordersand reinventing images of a mythic foundation of the community and of peoplebelonging to a place; the proposal and/or the scarecrow of the scission of north-ern regions, with the consequent frightened perspective of the ending of theRepublic’s unity (supported by the Lega Nord party, above all in its first lifeorganisation); the claim of fiscal autonomy at regional and local levels of gov-ernment, to change the redistribution of financial resources radically, maintain-ing the constitutional and political unity of the Republic (a leitmotif of the LegaNord party and of the politicians’ expression of northern electorates); the listmight proceed.Indeed, not necessarily were these ideas new or did they lead to concrete inno-vations in pre-existing logics and practices. From a national perspective, federalist ideas were often eyed warily, as a dis-turbing force and a factor of political instability, even an aggression to Stateorder. The request for autonomy from below was generally mistrusted, colliding
22

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
with traditional, hierarchical and centralizing logics of national political parties.It was clear enough, in most cases, that politicians who governed the transition,surviving the end of an epoch (i.e., the dissolution of the political system, char-acterised by DC, PSI, PCI as dominant political forces and pillars of citizens’ polit-ical participation; the so called Mani Pulite inquiry and the moralisation wave ofpolitics), did not have a federalist culture in their DNA. At the national level, the federalist argument often caused wide dissent anddivided, more than associating or aggregating, social and political groups andtheir leaders. As a consequence, it is very difficult to identify, in the Italian political scenario ofthe time, a compact national “federalist coalition”. In specific areas of theCountry, federalist requests were, in some periods, a reservoir of votes for politi-cians who interpreted the discontent spread among the Northern people; but,when those politicians were voted for at the national elections, and becamenational representatives, they had to negotiate and to moderate their federalistprojects, with a progressive loss of any revolutionary or even reforming mission.And, they found their job difficult independently of their belonging to majoritycoalitions. A good example may be the Lega Nord party, which gave centrality, inits communication and political discourse, to federalist arguments. The Legabecame ineffective as regards its federalist plans whether it was part of the gov-ernment coalition or sided with the opposition10 – the Lega itself was internal-ly divided into diverse streams and expressed different ideas about federalistsolutions. Federalism remained a façade of rhetoric to fuel the NorthernQuestion and to increase people’s consensus. Those politicians, who rode sepa-ratist tendencies, found easy approval on behalf of wide sectors of population,who believed to be damaged by the systematic State taxation on their revenuesand related mechanisms of redistribution – to balance disparity, in the name ofnational solidarity – to deprived, low income areas of Italy (mostly concentratedin southern regions). Above all, they were charged with the inefficiencies of thepublic expenditures and the lack of transparency in the public administration inthe southern regions, suspecting corruption and patronage originating from theCentral administration in Rome (the popular slogan was “Roma Ladrona”, i.e.Rome the Robber). Social justice was really an ambiguous notion, which referredto the need for guaranteed welfare State measures for all the people who need-ed them, and to the need for granting the productive and very developed areasthe collective benefits deriving from their higher incomes.As regards the centre-left parties, they were deeply involved in federalist reformsoriented towards vertical and horizontal principles of subsidiarity, and weretranslated, in concrete terms, into measures of political devolution and of admin-istrative decentralisation. They had the experience of City Mayors, dealing with local government and pub-lic policies, networking at the national level to form a kind of coordination, theso called “Cento Città” City Mayors’ Movement, which became popular and hadprominence on mass media in the mid ‘90s. The centre-left took up a stand infavour of a reforming process of the Italian Constitution, devolving new author-ities and responsibilities to sub national levels of government in important areasof policy-making, recognizing the Mayors’ pressures and the strategic role they
23
10 In the majority and in thegovernment during 1994,from 2001 to 2006 and from2008 to present. At the oppo-sition, from 1995 to 2001and from 2006 to 2008.

n.22 / 2009
played in linking local politics and party organisation to territorial demands andto every day administration – also in the attempt to contrast the Lega’s growingpopularity, whose commitment to politics was mainly characterized by attentionto the people’s every day life needs. The centre-left opened to de facto forms of federalism and started the institu-tionalisation of such political and administrative practices by State reforms.Again, at the end of ‘90s, new problems arose at the national level, whichbrought to the failure of the “Bicameral Commission for institutional reforms” –a unique occasion for federalism, as it had obtained consensus from both centre-left and centre-right parties. Most of the problems were due to division insidethe majority coalition, involving the top of Democratic Party leadership (PDS),complicated by the intemperance of the Lega Nord party – its exit – re-entry11.The Prime Minister and Leader of PDS, Massimo D’Alema, who had responsibil-ity in the reforming process, being President of the Bicameral Commission,turned over a new leaf and dissolved the Commission in a very bureaucratic man-ner, grasping the opportunity of a new important commitment, as the war inKosovo required urgent political attention and the Italian State was internation-ally exposed.In summary, although we can distinguish, at the basis of the various federalistissues and local interpretations, different ideals, beliefs, scopes, interests, moreor less popular or intellectual orientations, or a different degree of knowledgeand awareness of Italian past history; nevertheless the evidence was the prevail-ing instrumental attitude of politicians and parties advocating federalism, aboveall at the national level (i.e., to obtain votes, media attention or, locally, to obtainthe favour of specific sectors of population and economic groups). Federalist claims were like an intermittent fever. Federalism was typically sub-jected to being urgently invested with big expectations of changes, and then sud-denly dropped, with never serious, in depth, studied solutions – a good exam-ple is the fiscal (autonomy) question, many times displayed in political discours-es as a priority or ‘the solution’, only recently a matter of thorough analysis bythose interested and supporting it inside and outside political institutions.When, for instance, federalism gave origin to social and political movements, likethe Northeast political movement, unluckily, it was a short-term experiment. Themovement failed, probably without shifting or affecting the local political andadministrative culture. It is at the local level, anyway, that federalism found its more interesting inter-pretations, in the attempt to build a laboratory innovating politics from the bot-tom and mobilising social energies. In the following pages we mention three occasions in which the federalistmetaphor was strategically meant by political local and regional leaders to con-trast, symbolically, the re-centralising logics of both the national government andthe national parties’ apparatus; the former logic reducing the innovative poten-tial of State reforms for political devolution and administrative decentralisation,the latter manifesting the resilience of traditional political national parties toabandon pyramidal conceptions of inside organisation, and hierarchical modesof coordination at the territorial level.
24
11 After the ’96 Nationalelection won by the Centre-left Coalition, the issue ofreforming the Constitutionin a federalist sense wasentrusted to the BicameralCommission which reflectedthe party’s balance. Aboutseventy among deputies andsenators participated to theworks of the Commission.Some of the contents intro-duced represented decisiveinnovation – i.e., the propos-al of a “Second Camera”,meant to substitute theSenato, which would beformed by Representativeelected by the Regions overall matters that were notclearly reserved to the State.The Regions were also toobtain fiscal autonomy, andmoreover, for the first timein Italian Laws, there wasreference made to a ‘hori-zontal’ subsidiarity(Vandelli 1999, 46-50). TheCommission, which wascommitted also to draft pro-posals for reforming the elec-toral system, was dissolvedin 1998.

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
7.3 First example: “The idea of Venice as a Bipolar City”A first interesting example of the use of federalist metaphors concerns the posi-tions that were expressed in the “The Idea of Venice” (1989-1999), a politicalproject and complex urban action, elaborated by a cultural and political localelite, which aspired to taking on the responsibility of leading the city Venice.Their leader was the philosopher Massimo Cacciari, who became mayor of Venicein 1993, being elected by direct popular vote, according to new electoral nationalrules. The reference to the fact that Cacciari is not only a political leader, but alsoa philosopher, is not at all casual. Indeed, it is interesting to interpret the connec-tions between his thought and political action in the direction of federalism andcertain ideas elaborated in his philosophical work, where one finds the founda-tions of this federalist culture and the elaboration of a particular vision of federal-ism. If, as previously affirmed, Deleuze considers the invention of new conceptsthe prerogative of philosophy, we can affirm that the philosopher Cacciari hasinvented some new concepts, beginning with that of Arcipelago, where passingthrough ancient Greece, with the aid of the metaphor of the sea in various its dec-linations, he affronts the difficult question of the composition of differences, andthe via of ‘federalising together’, in a pact, as a possible solution.Cacciari analyses the complex and multi-folding imagination of the sea, and dis-tinguishes the different ways of thinking of it that emerge from the etymologicalcharacter. “Thalassa” means “mare nostrum”, the idea of the maternal and of theMediterranean, and on a symbolic level expresses the concept of membership toa territory as well as to a community without reducing those to an objective prop-erty; “Pèlagos” is the sea that embraces us and dominates as it is infinite; “Pòntos”indicates the possibility of crossing “Pèlagos” building bridges to connect the mul-tiplicity of the existing islands; but the ‘true’ character of the sea, the image of thesea ‘par excellence’ is “The Archi-pèlagos”, which means a concrete condition ofdialogue and interaction between the different islands, so that islands appear tobe at once all distinguished and all interwoven with the sea itself.The example of the “Bipolar City” well clarifies the underlying federalist paradigm.This paradigm can be understood with regards to two concepts that take on acentral role in the federalist debate, that of integrity (which means the whole inits entirety and at the same time the autonomy of the parts themselves); that ofautonomy (as the capacity for self-government and at the same time the ability towork with the other levels that make up the system). Both the concepts explainthe relationships that exist between the part and the whole, and their specificconstruction in the form of a system, which is always intended as a tension toward‘making system’, toward ‘federalising’. The last aspect recalls, more generally, aparticular declination of the concept of participation and the concrete definitionof processes and participatory forms. In the federalist model this consists in reg-ulating and foreseeing forms of participation between the different levels of gov-ernment and government institutions; between citizens and governmental insti-tutions; and between citizens themselves. But the very concept of participationitself is always defined in a rather ambiguous way. Whereas current institutionalpractices and procedures tend to relegate it to information and consulting, thefederalist model tends to see the possibility for a wide range of subjects and actorsto participate in decision-making or in the drafting and implementation of policy.
25

n.22 / 2009
The pre-supposition is that of constructing a pact between the parts, which is notintended to be static but rather as a continual process of re-negotiation in rela-tionship to the changes and the new needs of the society itself. A metaphor thatis central to this debate is that of integration; that is, of a particular way of com-posing differences, which often appear to be explained by relying on a few preg-nant images of political communication. An image that has been highly used toexpress certain characteristics ‘of the Idea of Venice’ is that of the ‘bipolar city’,the destiny of which has been that of undergoing various interpretations andinstrumentalisation in the debate between the opposing political forces. Theambiguity of the very notion of autonomy comes to light in the debate on thisidea of the bipolar city, which is interpreted in the direction of separatism(prompted by localism) as opposed to federalism (‘making a system’).It expresses an idea of reforming and at the same time radical transformation; itis the breakdown of the conservative paradigm which defines “Venice as formaurbis”, that is the idea of a “Venice-centred system” that was a misleading inter-pretation of the concept of integrity, giving way to nostalgia for the existence ofa centre to attempt re-creating wholeness or completeness. The image of the‘bipolar city’ indicates the breakdown of the centre and the structural imagina-tion of a territory with a centre (Venice) and peripheries (Mestre, Marghera,etc.), suggesting the way of a ‘multiple-centred metropolitan area’ that includesall different territorial realities and loosely connects them with one another. Thisis an idea of urban governance, where the centres are viewed as governmentalnodes in which fragmentation is a key factor, and where the various rules andregulations tend to be more loosely structured.In this way the “Idea of Venice”, even if at some extent it can be defined as aheuristic device, being strongly structured on the basis of an analytical and sci-entific knowledge, functions as a device to activate participation.With respect to the structural metaphor, the federalist vision articulated by the Leftchanges the way of intending the relationships between the various parts as wellas the existing interconnections between the different institutional and govern-mental levels, in a delicate co-existence of the principles of self- and shared-rule. The federal metaphor is therefore clear and persuasive in claiming local autono-my, in the possibility of making choices independent from the central govern-ment. Therein, it raises the issue granting responsibility to the local autonomies,of building up their effective ability for self-regulation, while still interacting withthe other parts of the system. There is therefore a release from the system’soperation, in comparison to the type of relationship expressed between theparts and whole in the structural metaphor. Thus, in the federalist metaphor, action toward reform or change can belaunched by the individual parts and not necessarily by national policies of inter-vention. With federalism, the territory is no longer viewed as the place for rela-tions between the centre and the periphery, or as a hierarchical system of socie-ty, politics and economies; “the local” and “the global” are to be thought of asinterwoven (that is the metaphor of the local and the global). The federalist par-adigm in thinking of the integrity is capable of rendering the “diverse” as a prag-matic resource, giving it meaning, in practice sharing viewed, and producing acommon vision of the problems at hand through interaction.
26

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
7.4 Second example. Re-writing Veneto’s Regional Constitution.The reform cycle that started in the ‘90s introduced new principles, rules andinstruments of administrative and constitutional federalism. On the one hand,the local government system was redesigned. Laws 142/1990 and 81/1993brought to the institutional reorganisation of local public administration andlocal government, with drastic changes as regards the electoral procedures, therelationship between the legislative body and the executive, and the mayor’spowers. Other Laws in the following years impacted models of provision of pub-lic services, instruments of accountability, and allowed new procedures and tollsfor management and programming, for bureaucratic simplification, recruitmentand personnel careers. On the other hand, some reforms promoted the decen-tralisation of important governmental functions and the devolution of politicalpowers from the State to Regional and Local governments, according to princi-ples of vertical and horizontal subsidiarity, culminating in 2001 with the approvalof a constitutional reform, that is, the amendment of Title V of the Constitution.Nevertheless, the reforms still occurred without granting concrete fiscal autono-my to the Regions12. From the Northern Regions’ point of view, the omission offiscal federalism measures was perceived as the potential strengthening of Stategovernment effectiveness at the local level, and of State ability to control periph-eries, throughout decentralisation, so that less convincing appeared the reform-ers’ intentions of establishing conditions of real political and administrativeautonomy at the local level. Without fiscal autonomy, the Regions and conse-quently the Municipalities were very limited in the effective implementation oftheir policies. In some cases this tension was a reissue of ancient (historical) city-state conflicting relationships, in other cases – as a consequence of the devolu-tion of new powers to the Regions – it brought to the configuration of a strongerregional political and administrative apparatus, diminishing cities’ autonomy.Moreover, the centre-left coalition, which in 2001 was the majority coalition atthe national government, licensed the constitutional reform during the lastmonths of its mandate, without implementing it or approving the relateddecrees of execution (the following elected government was the expression ofcentre-right political forces, having a different position on this matter). Of coursethis situation weakened and undermined the reforming process.This autonomist tension, in particular, crossed the North-East federalist move-ment, led by Cacciari when he was still Mayor of City of Venice and a very activeexponent of the “Cento Città” City Mayors’ movement – as mentioned before.The North-East federalist movement went down in history as the concentratedeffort, made by a federalist local elite, to build a new political subject that couldagree to the participation and the interests of city mayors, local politicians, entre-preneurs and sectors of the civil society. It was, in the founders’ aims, a laboratory of federalist ideas, bound to have influ-ence on national reforms. The elaboration of a new charter for the RegionVeneto, which started in 1998, on the occasion of the first convention of themovement, was considered a strategic task. At its core was the idea of the Venetocommunity as a multi-centred, plural system of social and political localautonomies. The vision of the Region as a compounded plural system, wherelocal autonomies stay like individual islands, grounded in the experience of self-
27
12 Regions obtained compe-tencies and decisional pow-ers in matter of social-healthcare and services, educa-tion, police, remaining in asubstantial financialdependency from the State.

n.22 / 2009
ruling, and sharing rules, evidently reminds us of the before mentionedmetaphor of “The Archi-pèlagos”, which emphasizes well the conceptual tensiontoward integrity and toward autonomy.Cacciari ran for the regional elections in 2000, guiding the centre-left coalition andlaunching a new regional political movement, named “Together for Veneto”. Hewas than defeated. As leader of the opposition his priority was to carry out the cen-tre-left proposal for a new Regional Charter. A first draft was provided by a group,formed by elected Regional Councillors, belonging to “Together for Veneto” andsharing federalist ideas, with the participation of experts, representatives of enter-prises and industries of the productive sectors and members of associations. Publicmeetings were also organised, to permit citizens’ participation.In the attempt to extend political consensus on the new constitutional policy tothe whole coalition, a second proposal was elaborated, involving electedRegional Councillors who belonged to other parties of the centre-left coalition;some of them were locally well known politicians or mayors of important citiesof the Veneto. This created some problems in the leadership, giving way to anegotiation phase, so that the process was subjected to weariness and prolon-gation; Cacciari had to deal with many different requests, finding resistance onbehalf of party exponents belonging to centre-left major parties. This situationwas strategically used by the centre-right political majority and by his leader, thePresident of the Region Galan; in a very short time a draft proposal for the newRegion Charter was provided by the centre-right – the elaboration was basicallythe product of a few experts and consultants, responding to a precise politicalorientation and reflecting ideas shared among centre-right national politicalforces and electorates.The potential for change of this constitutional policy was contrasted by theemerging of traditional centralizing logics and resistances, giving life to both theregional government and the political parties’ apparatus, with some exceptions. An important difference between the centre-right and the centre-left proposalswas that the first emphasized the local autonomy exclusively as a problem of ‘ver-tical’ subsidiarity: the Region was presented as the strongest political subject inthe negotiation of powers with the Central State government. The goal was tohide a real claim of independence in the name of a request for autonomy. Fromthis perspective, the Region built itself up as a State towards its Municipalities byre-establishing a hierarchical system. Local autonomy was emphasized as the“freedom from” higher authorities. On the contrary, the second proposal by thecentre-left coalition emphasized local autonomy as the reinforcement of localMunicipalities, de facto overcoming hierarchical approaches in establishing pow-ers and in defining functions and roles among the Region, Provinces andCommunes. The proposal was intent on the institution of the “Council ofAutonomies”, a new body that could be provocatively extended to certain leg-islative matters13. The Council of Autonomies could become the effective insti-tutional forum for the participation of Local Entities at the regional level, build-ing the premises under which the various government institutions took part,conditions being equal, in the decision making processes. In the first proposaldrafted by the group of centre-left (Together for the Veneto) the Council ofAutonomies was extended to the participation of representatives of political
28
13 Anyway, the Council ofAutonomy was intended tobe a consultative body,although some participantspretended to involve it in thepolicy making.

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
local entities and economic, social autonomies (including the Chamber ofCommerce, the universities, organisations of the service sector, etc.), to givethem effective democratic political participation. Thus, it can be said to consti-tute a solution for the problem of a democratic representation, not only of localentities, but also of the local civic societies, being the local autonomy empha-sized in terms of “freedom to”. In the final draft (dated 19.01.2001) a distinctionwas made between the Council of Autonomies (formed exclusively by local enti-ties), with precise competence, and a new organ called The Regional Council forEconomics and Social Planning (formed by the other entities), with limited con-sultative functions. This last solution was preferred to the former model, so as tomake decision-making and participatory processes more effective. In any case, inboth centre-left proposals, an interesting interpretation of both the principle of‘vertical’ and ‘horizontal’ subsidiarity can be found.There are other important matters of distinction. The centre-right proposal wasbased on Law primacy. It can be argued that the underlying paradigm was the lib-eralist paradigm. Conversely, in the centre-left proposal, the predominant framewas that of the “differentiated citizenship”, which referred to the existence of a plu-rality of “local public”, having meaningful capacities in the construction of self-organised local arenas for policy-making, and in parallel to the electoral arena.From the centre-left perspective, the task of re-writing Veneto’s RegionalConstitution was a device to involve local public and private, governmental andnon-governmental actors, mobilising them on relevant issues, pertaining to thegeneral interest. For those participating in the process, it was an experience ofinteraction that allowed them to overcome individualistic positions and toassume more awareness of Veneto’s strengths and weaknesses. As a by-product,the constitutional policy functioned as a frame for action towards a broader polit-ical and social decision-making arena; negotiation processes among the variousstakeholders involved activated collective sense making. Local autonomy wasconceptualised as “a bottom-up phenomenon”, constructing a sense of place.
7.5 Third example. The proposal for a Northern Party vs the coordination ofNorthern Regions. The proposal of a Northern Democratic Party was suggested in 2008 by someItalian City Mayors (like the Mayor of Turin, Sergio Chiamparino, The Mayor ofVenice, Massimo Cacciari, the Mayor of Genoa, Marta Vincenti), with the aim tocreate a new political subject, more capable of representing Northern Regions’interests at the national level, under a federalist pact. The new party wasdesigned to give local political leaders sufficient negotiation powers and moredecisional autonomy from the Democratic Party National Secretariat, which wasperceived as too centralised and hierarchical.14 Political leaders dealing withRegional and City governments and having the experience of every day adminis-tration and policy implementation pushed for fiscal federalism and for moreeffective decisional powers in matters of regional and local policies. They con-sidered that increasing in their ability to be responsive and accountable to socialand economic demands was necessary for the competitiveness of theDemocratic Party (DP) in the Northern Regions, above all considering the sur-prisingly big electoral success that the Lega North Party had obtained at the last
29
14 The formation of the newDemocratic Party was a tur-bulent process of negotia-tions, full of compromises,implicating the fusion ofexisting centre-left partieslike the Democrats of the Leftand the Margherita party,with all their apparatus. Theprocess was characterized

n.22 / 2009
national political elections, attracting segments of the electorate which tradi-tionally voted for centre-left parties (like workmen and people belonging to themiddle classes, and small and average enterprises). Besides, they wanted to have recognised conditions of autonomy in recruitmentprocesses and in decisions about local candidatures at the administrative and polit-ical elections. Tendencies towards centralisation, in fact, had became too inflexibleand constrictive, also because of the effects of the last national electoral reform,which had re-introduced a proportional system, thus attributing to national partySecretariats extensive power in the selection of candidates at all levels. Contrarily to top party hierarchies, local leaders were aware of the need to clingto territorial interests and demands, programmes and candidates, to gain peopleconsensus and to contrast the ascent of Lega North. The reaction of the Democratic Party Secretariat to proponents of the idea,launched by City Mayors and local political leaders, of a Northern DemocraticParty was the institution of a formal coordination of the Northern Regions, hav-ing regional party secretaries as reference point. The regions that were expectedto take part in the coordination initiative were eight, and precisely: Veneto,Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Lombardy,Piedmont, Valle d’Aosta, Liguria. The term “coordination” as a frame for theaction was meant to respond to Northern peoples’ demands, recognizing theexistence of an unsolved Northern Question, without losing central control overlocal and regional decisions but rather strengthening the decision chain in acoordination exercised by party officials. While on the one hand, in particular theMayor of Venice and federalist thinker Cacciari, strongly opposed to the propos-al of a coordination, on the other, the idea of a North Regions Democratic Partywas considered by the party apparatus too outdated, or a provocation, in anycase something claiming further autonomy against the attempt to build a strongnational political subject and a centre-left nationally identifiable project,although based on the increase in value of territorial specificity and competenceto solve social problems. As regards the functional aspects, the coordination wasassigned to a regional secretary, lasting six months, and the chair was to goround among the eight regions, thus affirming a principle of alternation. The firstcoordinator to be designed was the secretary of the Region Lombardy. Some of the Mayors who were initially sceptical about the idea of a coordinationof North Regions inside the DP, like the Mayor of Turin and the Mayor of Genoa,changed their minds. City Mayors were in fact involved in the formal assembly ofthe coordination initiative and, as a consequence, thought that the coordinationwas a practical way to play an effective role within the Democratic Party organisa-tion and to give national visibility to the Northern cause. From their point of view,the coordination table could be a new pragmatic arena for negotiation andexchange involving local and regional politicians belonging to the DemocraticParty; it could also be the occasion to share proposals representing, at the nation-al table, the common interests of a large political and social area. Gradually, andon the surface, terms like “federalised, decentralised party” became dominant inthe communication as the most eloquent slogan in explaining the shift in theDemocratic Party’s organisation, from below and launched by Northern local andregional exponents of the Party. In the end, only the philosopher and Mayor of
30
by the emergence of manyconflicts among the politicalleaders guiding the differentparties and currents com-posing the centre-left bloc,both at the level of nationalsecretariats and at the levelof regional and local secre-tariats. Political strugglesended with the non adhesionof Communist parties (“RC”and “Comunisti Italiani”)and of the “Italy of Values”party (with Antonio DiPietro as the leader), willingto maintain their own iden-tities and to run their owncandidates to the elections.Anyway, to the eyes of peoplethis solution represented asort of simplification of cen-tre-left political order, reduc-ing the too fragmented andnumerous currents andidentities, which generallycomplicated electoral strate-gies and weakened govern-mental actions. Primarieselection sealed the top ofparty organisation, stabilis-ing a leadership consideredcapable to identify competi-tive candidates to runnational elections, neverthe-less to the existence of differ-ent streams and regionalconstituencies agitating themovement inside and at itsbasis. Despite of its highexpectation and premises,the foundation of the partyhad not been truly participa-tory in character and the DPas a political subject did notrepresent really a new orien-tation and a shift from thepast. More realistically itwas the sum up of diverseparts and not the conver-gence of the different centre-left political forces sharing acommon project and aimingat the creation of a newpolitical subject.

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
Venice Cacciari seemed to maintain his critical distance from this solution, as itdid not create the conditions for broader party innovation or the birth of a newpolitical subject, representing and aggregating Northern interests.Anyway, the two opposite proposals (the party of the North, the coordination ofNorth regions) cannot be understood without problematizing the many trouble-some consequences of the “moral question” involving, in those months, theDemocratic Party, and seriously stressing party national leadership and politicallegitimacy. As a result of judiciary inquiries, it emerged that many leftwing munic-ipal administrations in different areas of Italy were interwoven with private eco-nomic groups of interest, with numerous cases of elected local and regionalcouncillors, public officers, local and regional party functionaries, advisors ofpoliticians, even mayors accused of or convicted for corruption, involved in illic-it affairs, colluding, favouring with crime organisations, having improperexchanges with their clients. The bad surprise was that many of those politiciansand public administration officers, party functionaries and elected councillors,who were involved in judiciary inquiries, were members of the Democratic Party,contrasting a tradition which excluded important phenomena of patronage andcorruption inside the centre-left party. The long-standing suspicion that the city and the local make up the bulk of thedegeneration of politics and society, of the concentration of powers in the handsof local unmoral bosses, controlling politics and economic affairs, re-emergedvivid15. This aspect was used in an ambivalent manner. On the one hand, the DPSecretariat and national leaders wanted to legitimise the strategies that attempt-ed to restore the political control of “peripheries”, under the clamour of a moral-isation wave involving the whole party organisation. In this perspective, lesspower to the Mayors and local politicians on local matters and on issues ofnational importance met the PD secretariat’s will to re-establish control overlocal politics. From this perspective, the constitution of a formal coordination ofNorthern Regions, despite the guarantee of conditions of regional and localautonomy over political decisions, was in concrete terms the conjuring up, again,of phantoms of hierarchical and top-down logics at the basis of coordinationstructures. In any case, this solution was far from the bottom-up mobilisation ofterritorial political resources. On the other hand, local and regional political lead-ers of the North – partially as a by-product of the process itself – used the “moralquestion” to highlight the many responsibilities of the top party levels and in par-ticular of the Leader Veltroni, stating his inability to control local candidates,above all in the Centre and South of Italy, as the case of Naples and of RegionCampania clearly showed.16
8. The history of Italy’s Second Republic through political metaphorsand images
In the long run, through four electoral campaigns (1994, 1996, 2001 and 2006),Berlusconi elaborated an innovative form of propaganda based on a strategy ofcriticism, and even insults, never expressed too seriously, but with a smile, andeven with a joke, addressed to a collective category (the Communists, theStatists, The Consociationists, the Left, and so on). Throughout twelve years, we
31
15 Inquiries regardedNaples, Rome, Florence,Pescara, Reggio Calabria,Potenza, Bari, and othercities, involving entire localpublic administrations,politicians of the left, entre-preneurs . Even TheEconomist gave evidence tothis inquiries as a very criti-cal phase of the Italian Leftand in particular of theDemocratic Party under theleadership of Veltroni.
16 Conflicts between thePresident of the Region,Bassolino, the Mayor of Naples,Iervolino, and the DemocraticParty secretariat increasedenormously in occasion of thejudicial inquiries whichrevealed the penetration ofcorruption, mafia, illicit traf-fics at all levels of the publicexpenditure and of the Regionand City political system.

n.22 / 2009
often heard Berlusconi say about the adversaries: “They are liars!” “They havewon with intrigues!” “They are going to cheat!” etc.; or saying to other powers ofthe State as the judges: “They are red gowns!” “Their inquiries are politically ori-ented!” “They need a psychiatric test!” and so on.But criticism, insults and defects are rarely directed to an individual. Beforeinsulting a personal adversary, for a while, Berlusconi laments that he has beenpersecuted by that person (so he said about Antonio Di Pietro before statingabout him, “He is a killer in that his judicial inquiries have driven honest politi-cians to suicide!”) or that the person in question is using his public role to obtaina partisan aim (so he said about Enzo Biagi, Elio Luttazzi and Michele Santoro,before criticizing them directly and asking, and managing, for he was the incum-bent prime minister, to exclude them and to remove their programs from thepublic television’s programme schedule).Berlusconi elaborated a personal style composed of a mix of megalomania, sex-ual boasts, jokes and extravagant statements to soften his abuse. This strategy ismotivated by the fact that Italians are not accustomed to negative publicity andto negative campaign. Being softened by many other previous extravagant state-ments or jokes, people listening to Berlusconi accept his abuse as a characteris-tic of the man, while they don’t accept identical abuse coming from more seri-ous politicians. This gives Berlusconi odds or, if you prefer, gives handicap to hispolitical adversaries.Berlusconi has been able, in time, to appear as a witty teller of jokes, an old unclewho we forgive, if smiling, for the insult directed to adversaries or, if ironic, eventhe use of coarse gestures or language. For instance, once Berlusconi decided – soas to obtain the maximum mass media importance for what he was saying - to usethe “gesture of the umbrella”, which is an Italian coarse gesture, but he was care-ful, like an old joking and smiling uncle, to smile and to limit the gesture to a hint.That gesture – commonly in use as a coarse gesture which means Vaff******, inmore polite terms “go to hell” – if hinted, sometimes becomes ironic.The complete gesture of the umbrella consists in putting the left hand on theinterior part of the right elbow bringing the right hand up. In the complete form,it is a coarse gesture, and this is the form that was used by Umberto Bossi (theleader of Lega Nord who, because of the gesture, was strongly disapproved of).But, if the left hand is stopped before touching the right arm and this arm is keptas low as possible, the gesture is not considered coarse, in that it is consideredonly a hint, not really a gesture. Half the gesture is not coarse and an innovationin the gesture (as the great comic, Totò, used to do by putting his left hand direct-ly on the elbow and turning the other one around by moving the wrist) is a wayof making fun of people. Of course, what is permitted to a comedian (Totò) is notpermitted to a serious politician and even what is permitted to an “old uncle”(Berlusconi) is not permitted to a serious politician (for instance, Bossi).Berlusconi’s masterpiece was a statement in the 2006 campaign through witchhe associated leftist electors to the vulgar term used to indicate “testicles”. Ofcourse he didn’t say, “Those who vote leftwing are morons!” but he expressedthe same concept in an indirect and less coarse way: “I don’t believe electors areso ‘moron’ as to vote Leftwing”. The problem is that the Italian term “moron” ispublicly unpronounceable and, normally, censored with a beep or, if written,
32

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
with asterisks “Co******”. That time, the term was written on all the newspapersand was spoken in all the television news. The day after, Berlusconi said that heused the term as a “warm-hearted word” and he was believed or pardoned as weusually pardon an old uncle. Berlusconi’s witty strategy has been constructed in time (from 1994 to 2006) andit is not by chance if Berlusconi, in 2008, defined Barak Obama “suntanned” or ifhe played bo-peep while waiting for German Prime Minister Angela Merkel.Before doing it, he made the coarse gesture of putting on his fist with his fore-finger and little finger upright on the head of the Spanish Foreign Secretary (away to suggest in Italy, and in Spain, that the Secretary’s wife was cheating on thehusband), he called a European German deputy “Kapò” – a watchman, normal-ly selected among the prisoners, in the Nazi’s lagers –and he stated that heobtained the signature of the austere lady who was, in 2006, Finland’s PrimeMinister, in important commercial agreement by courting her.All these eccentric statements or actions have been a way to construct his imageof “old uncle” to be able to use the negative campaign against his adversarieswithout becoming disagreeable. Thus, he is allowed to provoke adversaries inorder to receive a serious and disagreeable reaction from them. As we explainedbefore, what is permitted to an old uncle is not permitted to a serious politician.While he was presenting himself as an old reassuring uncle (from 1998 to 2006,and even in 2008), his TV networks were conducting a campaign tending to cre-ate a general sensation of fear, insecurity and aloneness because of crime. Thejudges’ decisions on law enforcement with regard to house arrest and suspend-ed sentence or to convicts receiving light sentences were strongly disapprovedby public opinion. The strategy of criticizing judges was an indirect way of criti-cizing the Centre-Left coalition, traditionally more favourable to policies of re-education and recovery of the guilty (just with house arrest and light sentences).This indirect criticism was made even after five years of Centre-Right governmentand this coalition had had all the time that was needed to change the laws (seefor instance the 2006 campaign). Even the pardon, approved by a bipartisanmajority (in that it had been invoked by John Paul II) when Romano Prodi wasprime minister, was declared as a leftist decision and as a factor in insecurity andin increasing crime and it had great influence on the decreasing of consent in theincumbent government. After any victory, the mass media’s insistence on thesethemes would definitively stop. This happened in 2001 and in 2008, but not at allin 2006 and for two years and a half these themes took up a large part of Italiannewspapers and TV news. Berlusconi’s consent was constructed from 1998 to2008 on two pillars: insecurity or fear constructed by the mass media and theimage of an old reassuring uncle.Of course, after Berlusconi’s electoral victories (in 2001 and 2008), the massmedia began to pay less attention to crime while Berlusconi directed his atten-tion to the second pillar (the image of an old uncle) to support his popularity. Inthis sense, in the aim to maintain this reassuring image, must one interpretBerlusconi’s statement in 2008, in which he maintained that he was governingand carrying out leftist policies, and the care with which he avoided unpopulardecisions (the first of which was an evident increase in taxes). During his 2001-2006 government, with a few artifices (the cheap remission of illegal or irregular
33

n.22 / 2009
buildings; the turning of public companies having huge debts into private onesin order to stay within the parameters of Maastricht; and so on), he tried hard tostay popular but was unsuccessful because of a smiling and laughing movementnamed “Girotondi”, the Italian name to indicate dances in a ring, or named “giro-tondini”, a name invented to indicate people dancing in a ring.When Berlusconi went back to governing, in 2001, as an old uncle, after morethan six years (from 1995 to 2001) of lamentations about the fact that he hadbeen deceptively deprived of his right to govern (by what he considered anunfair judicial inquiry), he won the elections because the centre-leftist coalition,during the 1996-2001 legislature, had made a lot of mistakes. First of all the sub-stitution, as prime minister, of the winning leader, Romano Prodi, with the sec-retary of the most important party of the winning coalition, the Secretary of DS,Massimo D’Alema. A change that was not understood, in that many centre-leftistelectors would have preferred a new government led by Prodi or new elections.This mistake exposed the coalition to Berlusoni’s harsh negative campaign(which persisted from 1998 to 2001, half the legislature).After this long negative campaign, which Berlusconi conducted alternating a smileor a laugh with criticism or an insult, the left remained without strength: eightmonths after the electoral defeat, which had driven them out of the government,leaders of the Centre-Left were still unable to get more than a few thousand peo-ple together, in Rome, in the enormous (for so few people) Piazza Navona. But something suddenly changed completely and, in a few years, a smiling andlaughing movement, the “Girotondi” nearly pensioned off the old uncle(Berlusconi). This movement eroded Berlusconi’s consensus and helped theCentre-Left to obtain, from 2004 to 2005, a lot of victories, particularly one con-sidered by all the political experts, the first of which Giovanni Sartori, an impos-sible mission: the victory of a candidate of the extreme left, Nichi Vendola, a gayand a regional leader of Rifondazione Comunista, who became President of theApulia Region, defeating the incumbent President, Raffaele Fitto, one of the mostimportant rightist politicians of the new generation. After these victories, leftist leaders thought the victory was going to be easy andthey devoted little attention to the Girotondi movement and to the new lan-guage elaborated by it. As a consequence, they made, in 2005, a lot of new mis-takes. First of all, they chose their eldest and most serious candidate, RomanoProdi, to lead a serious electoral campaign that was more or less similar to thatof ten years before. The electorate influenced by the Girotondi movement con-sidered this campaign dull. Moreover, Prodi and the allied parties’ too seriouscampaign exposed the leader and the coalition to Berlusconi’s negative cam-paign, which he conducted alternating a smile with criticism, a laugh with aninsult and, when adversaries reacted with serious language, even alternating awithdrawal with an accusation of being unfair with their critics. It took Berlusconi two years and a half of negative campaign to win the 2001 andthe 2008 campaigns: from December 1998, when D’Alema, the most importantleader of the coalition, but not the winner, became prime minister substitutingthe winner Prodi, to April 2001, and from November 2005, when Prodi won theprimaries, to April 2008, when Veltroni lost the elections. In the 2005-2008 cam-paign it took him a long time to regain the consensus acquired by the Centre-
34

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
Left coalition because of the activity of the “Girotondi movement”. With a smil-ing and laughing elaboration of a number of metaphors, Berlusconi was held atbay and he began to regain consensus only in October 2005 when he understoodthat Prodi would not be able to marshal the Girotondi style of campaign againsthim. Thus, he started with his negative campaign against Prodi and his coalition,hoping that Prodi would be too serious to win.Berlusconi nearly won in 2006 and, however, was able to allow Prodi only themajority of a few senators, not enough to avoid a crisis after less than two years.In 2008, at the new elections, Berlusconi was the winner in that Veltroni’s quietcampaign without insults was enough to force Berlusconi to avoid the style ofthe negative campaign, but it was not enough to win. The extreme Left, whichused the style of a violent campaign, was unsuccessful in that they didn’t elect adeputy or senator.After this premise on the importance of their action between 2002 and 2005, weare going to describe the girotondini movement (the unique collective actor suc-cessful in removing Berlusconi from the Centre of the political debate) throughits luckier set of metaphors. But before narrating it, we need a brief method-ological introduction on the metaphorical theme.
8.1 A methodological premiseAccording to the classical (or Aristotle’s) definition of the concept of metaphor,a metaphor is produced when one concept is used for another and we have fourtypes of metaphors. Only one, the fourth, has a heuristic value (i.e. only thefourth type adds something new to the knowledge we already have). In the definition adopted in the first a previous essay (Gangemi and Gelli, 2002)only the fourth type of metaphors as classified in the Aristotle’s definition is ametaphor. The first and the second types of metaphors, in Aristotle’s sense, and,sometimes, even the third, are only images. A metaphor, in the sense hereadopted, is an image which assumes a heuristic value (and, as we are going toexplain, surely, the first and the second types of metaphors cannot add informa-tion to what is already well known).The first type of metaphors (in the classical sense, images in the definition adoptedin this essay) is used when we introduce a genus to indicate a species. This first typeimplies a deduction from a genus to a species. As it is well known, a deductionnever implies the production of new information. An example is when we say thata ship has stopped to intend that the ship has been anchored. In the sense hereadopted, this first type is an image, a figure of speech. We have an image when weuse one concept for another without adding anything to what is already known.The second type of metaphors (in the classical sense, images in our sense) isused when we introduce a species to indicate a genus. This second type ofmetaphors implies an induction from a species to a genus. As it is well known,an induction does not imply the production of new information if we operate ina well known ladder of abstraction. In other words, when we do not operate anabduction, but an induction (in the sense of a habit), the passing from a speciesto a genus doesn’t produce any new invention. An example is the case in whichwe say thousands and thousands to intend many. In the terms here adopted, thissecond type is an image.
35

n.22 / 2009
The third type of metaphors (in the classical sense and sometimes in our sense)is used when we introduce a species to indicate an other species. This secondtype implies an induction and a deduction to start from the first species and toarrive at the second one. As it is well known, the deduction never implies newinformation and we have just said that the induction too does not imply newinformation if the ladder of abstraction is well known and unique. This third typeimplies an analogy and a proportion. An example will explain where the analogyis and where the proportion is. The first species can be indicated by the term top(of a mountain); the second species by the term tooth (of a mouth). By analogy,we intend a logic process according to which the affinity between two things istransferred from the first to the second. By proportion, we intend the relation-ship of one thing to another which is appropriate in comparison, or size oramount. The analogy is between mountain and mouth and the proportion is: thetop of the mountain is, comparatively, as the tooth in the mouth.According to many students, the third type implies a passage from a species (topof a mountain) to another species (tooth in the mouth) with no letting in of newinformation only if a unique ladder of abstraction is capable of offering one andunique genus to pass from the first species to the second one. In this case,according to the dictionary I adopted, this third type is an image. On the con-trary, if only one student presents a new ladder of abstraction or a differentgenus to operate this passage, there is a sure production of new information. Inthis case, the example of third type of metaphors becomes an example of thefourth type and it is, in the terms of the dictionary I adopted, a real metaphor, inthe sense that it implies the production of new information. As a consequence,we can say that a metaphor (of the fourth type, in that it is not only an image) isa concept which adds something to a process before being defined.The fourth type of metaphors (which is a metaphor both in the classical defini-tion and in the one here adopted) is used when we introduce an object or aseries of objects to indicate another object or another series of objects withouthaving a unique ladder of abstraction to pass from the first object to the other.In particular, the fourth type is a metaphor of the third type which has changedinto something else when one or more students or people disagree on the lad-der of abstraction lying below the two objects. We say that this fourth type ofmetaphors occurs when we have a “metaphorical stretching”. The expression “metaphorical stretching” is derived by an old essay of GiovanniSartori. Speaking about Concept Formation in Comparative Politics, Sartori(1970) theorized the “conceptual stretching” as a really common practice incomparative analysis in order to have a world-wide applicability. The conceptualstretching has been and is most commonly used in many contexts. In the present essay I’ll try to show that we have a “metaphorical stretching” too andthat this practice is commonly used by many politicians. An example of thismetaphorical stretching which produces a fourth type of metaphors can be derivedby a recent political controversy among attorneys, judges, politicians and policemen.
8.2 A historical joyful set of metaphors during a “challenging phase”The 12th of January, during the inauguration of the judicial year in the seats ofCourt of Appeal, many young Italian attorneys and judges (especially those
36

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
involved in investigating mafia crimes and terrorism) questioned the govern-ment refusing to wear (during the ceremony) their gown (as tradition pre-scribes) and, in some cases, at the beginning of the discourse of the representa-tive of the government, abandoning the hall. On the same occasion, FrancescoSaverio Borrelli, the Attorney General of Milan, who had had an important roleduring the, unfortunately, too short period of “Mani Pulite” (“Clean Hands”, aninquiry on political corruption) pronounced an energetic discourse against thepresent government. His discourse ended with the subsequent invitation: “toresist, to resist, to resist as on the Piave Line”. This invitation was a quotation from a famous discourse of an important ItalianPrime Minister (Vittorio Emanuele Orlando) and it has been used as a metaphorin that Borrelli explicitly referred to a historical event: during the World WarOne, in 1917, the Italian army has been defeated in Caporetto and the Austro-Hungarian army broke into the plain and was stopped only on the Piave Line(Piave is a river not so far from Venice). In these new positions, the Italian armystayed for a long year before defeating the Austro-Hungarian army in another his-torical battle. In that year, between the defeat and the victory, the Prime Ministerof the time (Vittorio Emanuele Orlando, premier from the 29th October 1917 tothe 23rd October 1919) pronounced a well known discourse in which he urgedsoldiers and citizens repeating three time the same verb: to resist, to resist, toresist.From a technical point of view, that of Borrelli was an image of the third type, inthat it was the presentation of two species: judges who are defending theConstitution and their role and soldiers who were defending their country, in anextreme and difficult line, before the definitive victory. If the analogy and theproportion had been respected (we, judges, are, in the courts of law, as the sol-diers were on the Piave Line), that of Borrelli should have been only the figura-tive description of what was well known in relationships between Italian govern-ment and Italian judges.Before presenting this example, I must make a few considerations on differencesbetween metaphors and images or figures of speech. In a previous essay, boththe terms, metaphor and figure have been used to indicate the use of one con-cept for another, which was justified by the fact that, in form of an image ormetaphor, the concept is capable of crossing (because it ignores them) the lin-guistic and political or scientific pre-existing barriers. Because of the fact thatmetaphors and images cross many barriers, they assume different meanings indifferent contexts, often a new meaning over a new barrier. But, with the differ-ence that images (and, as a consequence, they can be used in “thin description”)have not a heuristic function (in that they don’t add anything to what is alreadyknown), while metaphors, in that they are used only in “thick description”, havea heuristic function.In other terms, metaphors and images were meant to be a linguistic instrumentwhich recognised differences in the context and tried to weaken or annihilatethem. Unlike an image, a metaphor is a dynamic symbol with a long run or strate-gic aim: to weaken pre-existing barriers and to substitute the many audiencesinside a society, to a new larger audience with external barriers and no internalones. A metaphor is a linguistic instrument which, dynamically, reduces the
37

n.22 / 2009
number of linguistic barriers in a society. The first political consequence of thisstrategic aim is that metaphors do not contribute to maintaining bodies ofknowledge which strengthen the traditional subjugating effects on non-privi-leged groups. On the contrary, images were meant to be a linguistic instrumentwhich ignored differences in the context and operated inside these differenceswithout trying to change anything. In the first part of this essay, we argued that, sometimes, in front of an opponentmetaphoric meaning tending to reduce the control of traditional elite on events,this elite elaborates new discourses and images in order to prevent the loss ofcontrol on events, when in difficulty. This is the well known tactic to changeeverything (in the formal discourse) in order to change nothing (in the substan-tial discourse or in practice). A conservative elite generally prefers to use imagesin that an image is a static symbol with a short run or tactic aim: to obtain a larg-er consent without changing anything. It is a linguistic instrument which, stati-cally, leaves unchanged the number of linguistic barriers in a society. Now, I’ll tryto show that, other elites, in front of an image tending to reduce their control onevents, operate a “metaphorical stretching” (in the sense that they prefer totransform an image in a metaphor) in order to prevent the loss of control onevents, when in difficulty. My opinion is that this reaction is not completely conscious in that it is often aproblem which could pertain to cognitive psychology.However, the present Italian government and majority is not conservative, inthat the Prime Minister is trying to change many things: from parts of theConstitution to the relationships between government and attorneys at lawwhose action the government would like to submit to governmental decisions.So, the reaction of the present majority to the protest of judges has not been theformulation of a new image, but the metaphorical stretching which has trans-formed Borelli’s image in a metaphor of the fourth type.Borrelli said many other things were related to other facts: for instance, thatexamining judges, who were investigating over Berlusconi, have been desertedby Berlusconi’s government. They have been deprived of the escort (even if theywere investigating over the mafia, too). Other things couldn’t be told, but theywere well known: for instance, that the Italian Minister of Justice has moved toanother office one of the three judges in the Berlusconi and others’ prosecutionin order to delay the prosecution (previous trials against Berlusconi have fin-ished because they encountered a negative prescription and the moving of ajudge implies a big delay because it is necessary for the prosecution to restartfrom the beginning). After the protests of judges all over Italy, in spite of Borrelli’s explicit quotation ofthe Piave Line, many exponents of the government and of the parliamentary major-ity focused their attention on the aim of substituting the image of judges resistingas soldiers on the Piave Line with the image of judges resisting as partisans in theItalian Resistance during World War Two. Since Resistance has been a civil warwhich has opposed Italian fascists and other Italians (but, first of all, militants of theItalian Communist Party), the image of judges who resist as communists resistedagainst fascism has been used to confirm or to prove that judges, who were criti-cizing the government, were strongly influenced by communist ideas.
38

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
Attention will be paid to the fact that, after having gone into politics, in 1994,Silvio Berlusconi received (with last inquiries of “Mani Pulite”) a number of noti-fications of investigation. He was inquired of falsification into false accountingand corruption. After a few prosecutions in which he has been acquitted becauseof a negative prescription of the crime, at the moment, in Milan, a really impor-tant trial is being debated. In the Silvio Berlusconi prosecution, Cesare Previti,one of his old lawyers, now member of the Italian Senate, is co-defendant.For a few years now, the present Prime Minister’s lawyers have been involved inthe aim to delay the debate in order to obtain another acquittal due to a nega-tive prescription of the crime. A few months before the inauguration of the judi-cial year, the Minister of Justice, Caselli (an exponent of Lega Nord), has trans-ferred to an other section of the Court of Law (without formally violating any law,on the contrary applying it in a literal sense) one of the three judges involved inthe debate. If the transferring should be operative at once, as the Ministerdemanded, the debate should be interrupted and should re-start from its begin-ning. In order to permit the continuation of the debate, and according to thelaw, the operative effects of the transferring have been suspended (until the endof the debate) by another section of the Court of Law. A conflict arose between the Minister demanding an immediate transferring of thejudge and the Law-Court not granting it. Many exponents of the present majorityspoke of rebellion and of violation of the Constitution and a judicial complaint hasbeen presented. A second Court of Law sentenced that the suspension of theeffects of the transferring was a legal and correct judicial procedure.Another premise, to understand the sense of the metaphorical stretching we aregoing to describe, is the fact that, before these events, on a few occasions, thepresent Prime Minister declared that judges, who were and are investigating onhim, on some of his lawyers and on some of his collaborators, were and are “redgowns” (i.e. they were influenced by a communist ideology and they were notreliable in that they were judging in accordance with preconceived ideas).The most organized explanation of the how and the why preconceived hiddenthoughts were present in Borrelli’s invitation to resist was presented in a TV pro-gram by an Italian parliamentary, Nando Adornato, who, once, was a militant ofthe Italian Communist Party and, in 2001 elections, was elected in Forza Italia,the Italian party founded by the present Prime Minister, Silvio Berlusconi. Theprogram was a well known talk show, Sciuscià, and it was hosted by MicheleSantoro, a TV journalist whom we are going to speak of later because he is dis-liked by our Prime Minister.As Adornato spoke of a “Berlusconi theorem”, before presenting Adornato’sreconstruction of the hidden thoughts in Borrelli’s metaphor, we must explainwhat, in Italian political life, the concept of “theorem” is. By the term “theorem”a complex judicial hypothesis is intended; a hypothesis based on a few signs orsymptoms, but which is susceptible to be rich in investigative results. The con-cept of theorem, when used together with the family name of the man who firstproposed that design of interpretation and investigation, in Italy has been usedto indicate the central idea of a new way to investigate on mafia (thus, Buscettatheorem because Buscetta has been an important member of the mafia who, firstin Italy, has denounced other members of mafia and their ties with Italian politi-
39

n.22 / 2009
cians) or a central idea of a new way to investigate terrorism (Calogero theoremwhere Calogero has been the examining judge who sent to jail Toni Negri andothers) and so on.According to Adornato, Borrelli, who has invited judges to resist pressure byBerlusconi and other politicians, and Italian leftists, who have supportedBorrelli’s urge, are convinced of the persistence of a Berlusconi theorem (of theidea that Berlusconi is guilty of many crimes, first of all that of attempting toinfringe the Constitution). Italian leftists were prosecuting Berlusconi in thestreets and not in the Law-Courts. They were sure that Berlusconi was guilty ofthe crimes he was under trial, for that the intervention of the Minister of Justicehas been made acting in bad faith to give the Premier judicial help, thatBerlusconi is a danger for Italian democracy, that his interest is in perennial con-flict with public interests, and that he has hidden ties to mafia. So, it is the Adornato’s conclusion, when Borrelli invited to resist, to resist, toresist, Italian leftists thought he was inviting to a resistance identical to that civilwar, during World War Two, named Resistance. Adornato avoided adding (butBerlusconi and others have had fewer precautions) that this was the demonstra-tion that in Milan there are a lot of red gowns (i.e. judges influenced by a com-munist ideology and not reliable in that they were judging in accordance withpreconceived ideas).A few weeks later, Michele Santoro, Enzo Biagi (a historical and important ItalianJournalist) and the comic Luttazzi have been presented, by Silvio Berlusconi, ina press conference abroad, as examples of men undeserving to conduct a TVtransmission (in the RAI, the government television) in that they are factiousmen. Excluding Luzzatti whose presence in the government television was occa-sional, many leftists and journalists predicted that Biagi and Santoro were goingto lose their TV programs.A few days later, a member of the RAI board of directors declared they weregoing to move the popular Enzo Biagi’s five minute program, at 8.30 p.m., to another hour (maybe, in the middle of the night). Naming extraordinary programthe subsequent talk show, Sciuscià of the 20th April 2002, Michele Santoroopened the program (completely dedicated to Enzo Biagi) taking to hummingthe most popular Italian song of Resistance: Bella Ciao. He sung without musicand completely out of tune. With this program, Borrelli’s urge to resist, defini-tively, became an urge to the Resistance against Berlusconi. At the presentation, in June, of the new palimpsest, everybody could see that Biagiand Santoro were without a personal program in the government television.The crisis, between judges and government, arrived at its maximum when thejudges announced a strike. Two days before the strike, in the Italian Senate, anex President of the Republic, Francesco Cossiga (as any President, at the end ofhis mandate, became a life member of the Senate), announced his solidarity toBerlusconi persecuted by examining judges and declared the strike as an actinfringing the Constitution. Another ex President of the Republic, Oscar LuigiScalfaro, after Cossiga’s words, defended in the Senate, Italian judges even if hedeclared to consider the strike as an error.In Italy, what an ex President says about judges is particularly important in thatevery President is, during his mandate, President of the “Consiglio Superiore
40

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
della Magistratura” (the constitutional organ of self-government of Italian judici-ary). A President, in this role, is the first judge. After Cossiga’s words, two impor-tant exponents of the majority, with the aim to moderate the political effects ofCossiga’s words, declared they were considering the strike as a political act, notas an infringing one. The strike of judges obtained a high percentage of adhesion (more than 80%).After these events, Berlusconi’s judicial problems began to be discussed, in pol-itics, through direct discourses (i.e. well defined terms) and no longer throughindirect discourses (i.e. metaphors).Why did the present majority’s need to react to Borrelli’s words with a metaphor-ical stretching? And, why did Italian leftists and TV journalists need to accept theidea that Boorelli’s urge was referred to the Resistance? Both the answers are inthe fact that, after Borrelli’s urge, spontaneous committees, in many Italian cities,organised new forms of political manifestations: citizens met around the build-ing of the Law-Courts, staying hand in hand and moving in an ideal ring aroundthe building. These spontaneous meetings were influenced by another luckymetaphor invented by Nanni Moretti, in a movie, five years ago. Before presenting the Moretti’s metaphor, it is interesting to notice thatBorrelli’s metaphor was represented, a few months later, by policemen and, thistime, it was used against examining judges. Before the demonstrations in Genova (July 2001), when many no-global demon-strators have been brutally treated by policemen (with many illegal arrests, manyinjured and a demonstrator – Carlo Giuliani - killed), in Naples, the 17th March2001, less brutal, but however illegal actions were made by policemen. In themonth of May 2002, a few of them were imprisoned and almost one hundredwere charged. Repeating the style of manifestations in solidarity to judges,policemen met around police-stations, they were staying hand in hand and theywere moving in an ideal ring around their station. In a Television interview(Sciuscià hosted by Michele Santoro), a policeman, of one of the special police-corps (the one named Celere) which has the function to control people riots,declared that they were not culpable of any crime because they were just obey-ing to the order arriving from the Home Secretary: to resist, to resist, to resist (ofcourse as Italian Soldiers resisted on the Piave Line, not as communists resistedduring the Resistance).Why did policemen restore the metaphor in the original sense given by Borrelli?Why did they do it if they were supported by rightist majority (against whichBorrelli’s metaphor has been used)? In my opinion, they were going to launch awarning in an indirect or metaphorical way. In other words, policeman inter-viewed said that they were going to do what Borrelli did: an empowering of pub-lic opinion in order not to stop examining judges (I hope this is not yet possiblein Italy), but to stop politicians of the Centre and of the Left. It is well known, infact, that what policemen did in Naples, when Centre-Leftist governed Italy, hadbeen a little thing compared to what they did in Genova, when the Right gov-erned Italy. In fact, in Naples, policemen had a less brutal and illegal behaviourin comparison with the one they had in Genova; nevertheless it has been, inmany circumstances, an illegal behaviour; as a consequence, many have beencharged and a few imprisoned; in this situation, they used Borrelli’s metaphor to
41

n.22 / 2009
denounce, in some way, a sort of complicity of the Centre-Left government; inmy opinion, the behaviour of policemen in Naples has never been a problem:policemen were sure they would be exculpated and freed (in fact they correntlyare free and, after the Genova trial, it is possible that they will be exculpated) andthe imprisoning and the charge of so many people has been realized to obtain abig scandal in the mass media; a scandal tending to signal to Centre-Left politi-cians they can suffer the same political scandal the Right will go to suffer becauseof Genova (when the policemen brutality and illegality will emerge with hun-dreds of charged and many imprisoned).In Genova, inquiries are disclosing that false news (that a policeman was killedby no global people) produced the desired reaction: in the language adopted byexamining judges, the false news produced a “suspension of legality”. It is com-ing out too that, when policemen entered a school, where they thought therewere arms and they didn’t find anything, they declared they had found incendi-ary bottles (and they exhibited them) to justify their illegal irruption. The threatwas an answer in that Borrelli’s metaphor has not been used against the Right atthe government, as used by Borrelli, but against the Centre-Left in order toobtain a more pliant position when the real judicial problem (the behaviour ofpolicemen in Genova) will be faced.Last news about Borrelli’s metaphor is the fact that, during controversies, in theItalian Senate, related to the passing of an act on “justified suspicion” (legittimosospetto) according to which, a trial can be transferred from a Law-Court toanother (with other judges). Because many leftists were thinking that the newdecree, if approved, would be used to transfer the trial against Berlusconi toanother Law-Court and the consequent delay would produce a new negative pre-scription, many leftists demonstrated in the streets to question the urgencyshown in passing the decree. In these demonstrations, in the last days of July,Borrelli’s metaphor “to resist, to resist, to resist”, definitively referred to theResistance. Having obtained this important result (to oblige the opponents to abandon anyreference to soldiers on the Piave Line, Berlusconi started a new controversialphase. He attacked leftists in saying that the real slogan of the left was not “toresist, to resist, to resist”, but it was “to lie, to lie, to lie”. Fassino, the political sec-retary of DS, answered that Berlusconi’s slogan against the left was “to swindle,to swindle, to swindle”. On this new ground, the leftists, in the new formassumed by the old controversy, completely lost their original advantage in thatthey lost their priority and were forced to react to Berlusconi’s attacks.
8.3 The second important joyful metaphor: “say something ... leftist”To approach the problem in a roundabout way, I want speak first of three moviesdirected by Nanni Moretti. The first is “Palombella Rossa”, of 1989; the second isa documentary named “La Cosa” (The Thing), of 1990; the Third is “April” of1996. It was the most important Italian newspaper (Il Corriere della Sera) to con-nect Palombella Rossa to the political event constructed around a political inter-vention of Nanni Moretti. It was the cry of a woman, during Moretti’s interven-tion, to connect the event to April. The last movie, La Cosa, is naturally connect-ed in that it is a political documentary.
42

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
43
Palumbella Rossa is a movie about a crisis, of a man and of a party (the ItalianCommunist Party, PCI, which was going to change its name and at the momentwas colloquially named, on the mass media, “The Thing” – La Cosa – which isthe name of the second movie we are going to speak of). It is a movie in whichcrisis is presented as a difficulty and a form of incommensurability of the lan-guage used in politics. The language is unable to describe political crisis, in thatit is an ambiguous term in politics. Crisis is declined, in the movie, in every pos-sible way, using the many synonyms the term has.The main character in the movie says that, in a moment of crisis, every stable def-inition is impossible or untrue. “A concept, when it is written, becomes sudden-ly untrue”. The main character, Michele Apicella, is presented as a parliamentaryelected as a candidate of PCI, the Italian party which was going to change itsname. As the party, Michele has lost his identity (in the sense that he has for-gotten his name and who he is). Everything happened during a TV conferencewhen the stress of a new defeat, while Michele is looking at figures representingthe main Italian parties and those parties in favour of which the PCI votes went.Michele, instead of answering the journalists, started humming a song.The figures he looked at were the result of the application of a mathematicalmodel to individuate and compute a syntactic way of producing sense withoutany semantics (communication) or pragmatics (interaction) involvement. Whenwe use a syntactic way of producing sense, it is as if we stay silent or if we speakwithout listening or understanding others. The silence or the incommunicabili-ty is the problem of the first movie and even these figures are a form of silence(in that they are the demonstration that leadership does not want to listen tomilitants or electors, but it expects to know everything without human commu-nication or form of interaction).The second movie, La Cosa, is a documentary on the transition period betweenthe old party, named PCI, and the new, not yet named and indicated as TheThing, La Cosa, by mass media. The documentary presents a selection of inter-ventions of militants of PCI during the most important local meetings to discusswhy and how to change the name of the party. Participants to debates, held inmany Italian cities, are nostalgic or wishing a new future, pessimistic or opti-mistic, happy or angry, confused or convinced, and so on. Their languages aregreatly differentiated as the change is not yet well understood or accepted. Thisdocumentary too is on the incommensurability within the party and of militantstowards leaders.In 1991, the new name of the old PCI was chosen and approved in a party con-gress. The new name was PDS (Leftist Democratic Party). The last movie is an inquiry during the two years between the 1994 electoraldefeat and the 1996 electoral victory of the leftists. This movie is connected tothe first one in that the change of the name is presented as a way to change iden-tity, but even a way to go to the centre to gain moderate votes. In this movie, wemeet the metaphor which has had an important role in past months. Even thismetaphor is on silence.During the electoral campaign, all the leaders were invited to a talk show hostedby Bruno Vespa, a well known Italian journalist. We see only a few images of thatprogram, those in which Berlusconi is speaking and D’Alema, the leader of DS (in

n.22 / 2009
44
that, with D’Alema, the old PCI become PDS, has assumed a new name: DS,Democratics of the Left), is listening to him. This movie is connected with the firstin that the desire to move to the centre, in order to gain moderate votes, has beentransformed in a political strategy by Massimo D’Alema. Watching the television,the main character of the movie (who has the same name as the author of themovie, Nanni Moretti) says a lot of times: “D’Alema, say something leftist;... saysomething leftist;...... say something!”. These metaphorical expressions have beenmemorable and have been reported, for a long time, as an amusing joke.These expressions are used as a metaphor in that they reproduce, for a lessinformed public, the discourse on the silence presented in the previous movies(Palumbella Rossa and La Cosa) and in that they added a new sense, a heuristicvalue which can be represented only in a metaphorical way.There is something that, in politics, can be said only in a metaphorical way, i.e.using an indirect language and not a direct one. Politics, at least in Italy, but per-haps even elsewhere, is a de-specialized profession in that: a) politicians speakabout everything; b) anyone can become a politician, if he acquires consensusand, later, is elected by the citizens. Thus, anybody, if not yet a politician, canaspire to go into politics. This means that, if you criticize a politician from a polit-ical arena, it can be thought that you are doing so because you are aspiring totake his place.This forms a vicious circle among those, and there are many in Italy, who believethat politicians are not credible and are liars. If you say that a politician is a liar,and you don’t say it in the pubs or in a street corner (the classical arenas of com-mon people without political power), but you say it in a place from which, or sothat, you can be heard by a lot of people (the classical political arena, whatever bethe place or the way), you assume the role of a politician and what you say can besaid about you. In the sense that, if, from a political arena, you say “you are a liar”to a politician, this becomes true even for you; if you say “you are saying nothing”to a politician, from any political arena, this becomes true even for you.Traditionally, the vicious circle is broken and even changed into a virtuous circle(to speak of politics without appearing as a politician), when the political speechis made from a common people arena (firms, ale-houses, clandestine press or asmall broadcasting place with no money and much enthusiasm, etc.). A lot ofnew political leaders began a successful career starting from those common peo-ple arena in that they used the places or the way they were speaking as ametaphor: the metaphor of the unselfish ordinary people denouncing selfishpolitical leaders; the metaphor described in the fable of the naked king where noone (except a young boy) dares to tell the king that he is not dressed becauseeveryone thinks he might not be credible. In the example we are going to introduce, the vicious circle has been broken byspeaking from a classical political arena (the platform of a political meeting)because of two concomitant events: whoever spoke was not invited to speak; heascended the platform while a woman spoke him not as a real person, but as ifhe were the main character (Michele Apicella) of a film (the film April wedescribed before). Before describing these two events, let me introduce a little synthesis ofMoretti’s ideas as presented in his movies: the correctness of the discourse is the

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
45
evidence of the real identity of a politician. If a politician loses his leftist lan-guage, it is because he has lost his leftist identity. The presence of a leftist dis-course is the way to differentiate those who are leftist from those who are not. If we present Moretti’s ideas in the Aristotelian language, we can say we have twospecies and a genus in a well defined ladder of abstraction:Genus: those who define themselves as leftists;First species: Those who use leftist language (they get a leftist identity);Second species: Those who do not use leftist language (they have lost their left-ist identity).This is the (added) new sense: The main leftist leader (D’Alema) does not useleftist language; thus he has lost his leftist identity. In an indirect way, i.e. in ametaphorical way, Moretti says that D’Alema is not a leftist.Last expression, at the end, “D’Alema, say something” goes further on the direc-tion of lost identities. In fact, it is the way of saying that the main leftist leadereven lost his political identity (he his no longer a politician, a winning leader).Even in this case, in an indirect sense, i.e. in a metaphorical way, Moretti says thatD’Alema is not a politician, he is not a winner.The image of D’Alema trying to communicate, as the species of politicians does,is a metaphor of the third type; in that Moretti says that D’Alema is unable to com-municate, is unable to say anything, thus he is not a politician, a leader, a winner,the image of the third type is transformed into a metaphor of the fourth type.Let me now, briefly, describe the political events before Moretti’s metaphoricalspeech: after the 2001 elections, Berlusconi’s victory had completely discour-aged leftist electors. The more the time passed and the more the leftist manifes-tations were empty. At the beginning of the new year, only a few people werepresent in meetings with national leaders of parliamentary opposition.Moreover, leftist leaders were divided: Fausto Bertinotti, leader of RifondazioneComunista, a party at the left of DS, and Antonio Di Pietro, the most popularattorney of Mani Pulite, who had entered politics, have refused to bring theirorganizations into the coalition between the leftists and the centrists. Now, theyare quarrelling with each other and with the leaders (Massimo D’Alema andFrancesco Rutelli) of the coalition named Ulivo (olive-tree). After Borrelli’s urge to resist, spontaneous meetings were organized around theLaw-Courts. The manifestations consisted in the fact that people surroundedLaw-Courts staying hand in hand. In Florence, a few professors (Francesco Pardi,Paul Ginsborg and others who had had experiences, in the far past, in the move-ment of students) thought of organizing these spontaneous protests through acomity that they called “Laboratory of Democracy”. In only ten days, they organ-ized, in Florence by the 24th of January, a manifestation which obtained a bigparticipation, especially of militants and electors of DS.Meanwhile, the Ulivo’s leaders were trying to organize traditional meetingswhich received a little participation. The places where people were urged to lis-ten to Ulivo’s leaders remained almost empty. In Piazza Navona, for instance,three weeks after Borrelli’s invitation, exactly the 2nd of February, the mostimportant Ulivo’s leaders (Rutelli and Piero Fassino, the Secretary of DS,D’Alema, the President of DS who didn’t speak, in that occasion, and others)were speaking to a few electors. Before them had spoken an unknown professor

n.22 / 2009
who had organized, in Florence, the dancing in a ring around the Law-Courts.Francesco Pardi, this is the professor’s name, was going to obtain a big popular-ity in subsequent weeks. After Fassino and Rutelli’s speeches, suddenly, from thepublic, Nanni Moretti went up the platform of orators. Being well known, theylet him speak. And he spoke in this way: “Before Fassino and Rutelli, we listened to Pardi whowas saying interesting things. Fassino and Rutelli spoke later repeating the samethings, as if they hadn’t listened to him. Pardi should be our future leader, withthese leaders (Rutelli, Fassino and D’Alema) we’ll surely lose the game”. It wasnot an oblique or metaphorical speech. It was reported by mass media as anangry and direct discourse. The direct discourse was identical to the metaphoras commonly intended in the previous movie (April).The evidence is in the fact that what Moretti said has been quickly forgotten and hispolitical speech has been substituted and represented, to leftist electors, by the cryshouted to him, before his speech, by a woman: “Moretti, say something leftist!”.Mass media reported the cry and it has become an important metaphor in thesubsequent months. As a metaphor it has been used in all the possible occasions.After a few days, many militants of protest movements started to use the crychanging only the surname and the final word. Spontaneous manifestations havebeen an occasion to produce new messages with the unique structure of the firstmetaphor. This structure is: a family name, the expression “Say something....”and an adjective to conclude the phrase. After the Piazza Navona meeting, we lis-tened to and saw a lot of new slogans: “Berlusconi, Say something .... legal”;“Rutelli, Say something ... correct”; “Mr X, Say something .... honest”, and so on.During a visit of Aurelio Ciampi, President of the Italian Republic, in Padua, no-global students extemporized a manifestation with a unique big stripe: “Ciampi,Say something .... Constitutional”. In other words, spontaneous manifestations were constructing a new political lan-guage to say that the leftist leaders don’t do what people expect them to do, thatBerlusconi is only formally legal, that others are only apparently honest, and so on.Last, but not least, even President Ciampi is presented as a President who is notdefending the Constitution. These things were said without any risk of contempt.Even this new production of metaphors can be presented as a “metaphoricalstretching”. Of course, this second one is a kin of stretching different from the first:the first is, in fact, realized, entirely on the pragmatic dimension of semioticsthrough the transmission of an image from the third to the fourth type ofmetaphors. The dimension is that of pragmatic in that it is the different aim ofeach actor which produces difference in meanings, i.e. difference in semanticinterpretation of the image, and the new interpretation, in that it adds some-thing to what is well known, transforms the image into a metaphor; the second is, on the contrary, realized in the syntactical dimension of semioticsin that it implies the production of different images from a unique linguisticstructure. The dimension is that of syntax, not because the semantic or the prag-matic dimensions are not present, but in that they do not construct the contextwhere the stretching is operated.This syntactic process of producing new metaphorical meanings is frequent inItalian political life. An identical example was really popular during the time of
46

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
Mani Pulite. In that period, under the city sign of Milan (in one of the periph-eries) appeared a placard with the new name “Tangentopoli”. The word wascomposed by two parts: the first to indicate a “tangente” which is the Italianname to indicate a bribe; the second “opoli” to indicate the idea of city as pres-ent in the Italian version of Walt Disney’s cartoons. In fact, the most popular car-toon town is named, in Italy, “Paperopoli” which means, more or less, “city ofDonald Duck”. Tangentopoli, i.e. “city of bribes”, became almost immediately,after the publication of the photo on an important newspaper, the name for thecity of Milan, in that, in Milan, Tangentopoli had its beginning. In a few weeks,this metaphor became really popular and, on the Italian mass media, this openedanother view of producing titles through the productions of new metaphors:Mafiopoli, which means the city of Mafia, to indicate Palermo, in Sicily;“Camorropoli”, which means the city of Camorra, to indicate Naples; affittopoli,which means the city of rent, to indicate Rome as the city of an other scandal: ithad been discovered that a lot of members of the Parliament, of the majority andof the opposition, lived in ancient and important palaces without paying any-thing or paying only very low rents.
8.4 From Girotondi’s movement to antipolitics and to a political defeatWith Borrelli’s metaphor, moderate electors of the Centre understood that theyshould go in the streets to participate in political meetings to defend someimportant values as: the equality of every men towards justice; the right of every-one to say whatever they think (even in the government television) or to saysomething which was contrary to the government; etc. With Moretti’s metaphor,moderate electors understood that they could introduce in politics new ques-tions which had been forgotten by leftist leaders who were, and are, more inter-ested in intending politics as a form of rational bargaining. It was an original invention of the first demonstrations; they used the smiling andlaughing new language to distinguish themselves from traditional politicians,while participating and introducing old forgotten issues in the political debate.With this new language, they were trying to remind leftist leaders that politics isa struggle for their own ideas, but not necessarily a tedious one, possibly a smil-ing and laughing one.This new political rhetoric produced, as a first effect, that the division amongCentrists and Leftists were soon forgotten during these manifestations and, as asecond effect, that, in the administrative elections of June 2002, Centre and Leftwon their electorate battle against Berlusconi. For the first time, after the 2001defeat, the Centre and the Left were able to participate in a unique coalition withunique candidates and they realized what, at the beginning of the year, seemedto be impossible.In 2004 and 2005, Berlusconi’s communicative strategy was no longer winning:when he appeared on TV, in 2004, unlike in the past when he obtained a largeraudience, the audience decreased. Without respecting any rule of correctnessand fairness, the day of the 2004 administrative elections, he invited electors totransfer their vote from little parties to great parties (and thus to vote for his ownparty instead of his allied parties), but he was punished: the other parties of hiscoalition increased their votes, while his party received fewer votes, much fewer
47

n.22 / 2009
votes than before (Gangemi 2004). In 2005, at the administrative elections thatinvolved 15 Regions out of 20 (and many electors, who voted for the mayor orfor the president of the Provinces, in the remaining 5 Regions), Berlusconi’scoalition was defeated with a 10% difference.After this defeat, Berlusconi waited to see whether the Centre-Left was going tonominate, as a leader, a young politician with a new joyful language or an old onewith a dull one. When he was sure that the Centre-Left, after the convincing vic-tory of Romano Prodi over other leaders in the primaries, was going to nominatethe old winner of the 1996 elections, Berlusconi thought it was possible to winthe next elections. With the aim to achieve this result, he immediately changedthe electoral law and immediately started (in November) a negative campaign,alternating jokes with insults. In six months he nearly won the elections (at theHouse he lost by 20.000 votes; at the Senate he obtained more votes but he lostbecause of the new electoral law). Why did he nearly win? Mostly because the smiling and laughing movement hadnot received great attention from traditional leftist leaders and had not been ableto renovate the leading class, which went from the consensus for moderateantipolitical leaders such as Nanni Moretti and Francesco Pardi to consensus formore ironic (but, unfortunately, violent in their political discourse) antipoliticalleaders. First of all, the comedian Beppe Grillo, the comedian Sabina Guzzantiand other mixed figures that used mockery to justify violent attacks on politi-cians and even on the Pope. In Italy, the most interesting virtual antipolitical sitesare managed by authors of mockery (two examples for all are Beppe Grillo andDaniele Luttazzi), authors of satire and theatre (Dario Fo and Franca Rame), jour-nalists (even television and newspaper, for instance, Marco Travaglio, SandroRuotolo), politicians (take the Blog of ex Minister Antonio di Pietro), independ-ent journalistic and electronic heads, associations, committees, movements,blogs of single “intellectual” citizens, “polymaths” and “columnists” (CarloBertani, Eugenio Benetazzo, Piero Ricca, etc.). After 2005 primaries, a lot ofyoung people and disenchanted electors have refused to vote, having been con-vinced that Left or Right were the same.Beppe Grillo indicted, on the 8th of September 2007, a mass petition drive tocollect signatures to propose a new law to the Italian Parliament (a law on themorality and on the eligibility of deputies and senators). He was present at themeeting in Bologna while many other towns had places where people could gofor signatures (and Beppe Grillo’s discourse was broadcasted on internet). Thediscourse was memorable in that the comedian, to express it in a more politeway, told many Italian politicians to go to hell. Actually, he used the wordVaff****** against rightist and leftist politicians. Because of this expression, usedby the comic, 300.000 persons rushed to these places to sign their names in allthe Italian towns, and this event was reported the day after as “Vaff******-Day”or the “Vaff-Day”. The day was memorable for many young people and it wasrepeated after the 2008 elections.After almost winning the 2006 elections, Berlusconi continued his negative cam-paign refusing to recognize the adversary’s victory and denouncing electoralintrigues. After two years and a half of this negative campaign he won the 2008elections by a wide margin. None of his adversaries (neither Prodi in 2006, nor
48

Giuseppe Gangemi and Francesca Gelli Metaphors and Politics
Walter Veltroni in 2008) ever proposed a generative metaphor or practised asmiling and laughing elaboration of a set of metaphors (even if Veltroni tried aquiet campaign, without insults and without using the name of his adversary,Berlusconi). Nanni Moretti wwent back to being just a well known film directorand an actor (whom even rightist politicians speak respectfully of). He neverintervened in the 2006 electoral campaign and he was invited, only as a memberof the audience, during one of Veltroni’s electoral meetings in the 2008 cam-paign. Francesco Pardi, who was elected in the list of the IdV, the party foundedby Di Pietro, was hardly known as deputy in the Parliament.In conclusion, we may say:1) different languages construct different realities, different facts (in the sensethat facts assume different meanings) and different processes (in the sense theysearch different ends). Thus, politics can be seen as a strategy which is or is notable to understand, learn from and act according to different practices or poli-cies. Rhetoric is a narrative important tool of persuasion and politicians maintaintheir consent when, using rhetoric narration of the situation, they appear to bein control of the difficult situations;2) it can be said that those who control words have the power to control poli-tics, but in three different senses in that we have three different kinds of words.To control words means to control metaphors and images or to control welldefined concepts or to control ritual concepts. It can be seen that those whocontrol words with plenty of metaphorical meanings, (maybe) will control thefuture of politics; those who control well defined concepts with a current rele-vant meaning, control the present; those who control ritual concepts withoutany residual meaning have controlled the past, but they are not yet controllingthe present or are going to lose this control.3) Negative campaigns are a way for achieving the de-structuring of the adver-sary’s language without elaborating a new project for the future. Berlusconi didnot use metaphors in the 2006 and 2008 campaigns. Neither did Prodi in 2006,and Veltroni’s most important metaphor was Obama’s: “Yes, we can”. It was notenough even if Veltroni’s decision to have a campaign without criticism andinsults directed to the adversary yielded a good percentage of votes to his party.The extreme Left, which used a more aggressive campaign against Berlusconi,obtained its worst electoral results in the past decades: no deputy or senatorelected in the Parliament.
ReferencesArendt, Hannah (1989), The Human Condition, Chicago and London, Universityof Chicago PressAugè, Marc (1993), Non luoghi: introduzione ad una antropologia della sur-modernità, Milano, EléuteraCacciari, Massimo (1997), L’Arcipelago, Milano, Adelphi, Crosta, PierLuigi (1998), Politiche. Quale conoscenza per l’azione territoriale,Milano, Franco AngeliDeleuze, Gilles (1990), “Les conditions de la question: qu’est-ce que la philoso-phie ?”, Chimères, n.8, May, pp.123-132Deleuze, Gilles and Guattari, Felix (1980), Mille Plateaux, Paris, Les èditions de
49

n.22 / 2009
Minuit Deleuze, Gilles and Guattari, Felix (1991), Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris,Les èditions de Minuit Deleuze, Gilles and Vuarnet, Jean-Noel (1968), “A propos de l’édition des œuvrescomplète de Nietzsche”, Les lettres française, March Foucault, Michel (1981), Power/knowledge. Selected interviews and other writ-ings. 1972-1977, New York, PantheonFoucault, Michel (1976), La volonté de savoir, Paris, Editions Gallimard Friedmann, John (1996), “Introduction: Borders, Margins and Frontiers: Mythand Metaphor”, Yehuda Gradus and Hervey Lithwick (editors), Frontiers inRegional Development, Rowman & Littlefield PublishersGangemi, G. (2004), “Regieren und Zivilgesellscahft in Zeiten der RegierenBerlusconi“, Aus Politik und Zeitgeschichte, vol. 35-36, pp. 39-46 Geertz, Clifford (1973), The interpretation of cultures: Selected essays, NewYork, Basic Books Inc.MacIntyre, Alasdair (1981), After Virtue, London, Duckworth, 1981Marris, Peter (1987), Meaning and Action: community planning and concep-tions of change, London, Routledge & KeganSartori, Giovanni (1984), Guidelines for Concep Analysis, pp. 15-85, in Sartori(Ed.), Social Sciences Concepts. A Systematic Analysis, Beverly Hills, SageSartori, Giovanni, Concept Formation in Comparative Politics, The AmericanPolitical Review, LXIV, 1970, n. 4, pp. 1033-63Vandelli, Luciano (1999), Commento agli articoli della legge n° 265/99, A.Vigneti e S. Riccio (a cura di), Nuovo ordinamento e status degli amministrato-ri: commento agli articoli della Legge n. 265/99, Bologna, Maggioli Editore.Villani, Tiziana (1997), “Il filosofo è un alchimista ?”, pp. 281-6 in AA.VV., Il seco-lo Deleuziano, Milano, Mimesis
50

51

52
Parte prima: dalla logica del poterealla dimensione del governo
1.1 Introduzione: dal potere al governo attraver-so una scienza delle politiche.
La scienza politica applicata allo studio dellaPubblica amministrazione e quindi alla scienza del-l’amministrazione (cfr. Mayntz, 1982; Dente, 1989;Freddi, 1998; Peters, 1991; Thoenig 1992; Crozier,1992, 2000; Gualmini 2006) si occupa direttamen-te delle politiche. Se consideriamo, ad esempio, lalezione di Theodor Lowi la scienza politica diviene,una volta applicata appunto all’amministrazione,una scienza delle politiche (cfr. Lowi, 1989). Ora questa declinazione della scienza politica per-mette di tematizzare quanto sia importante pensa-re la politica in relazione alla dimensione dellapubblica amministrazione. Permette di considera-re come punto di riferimento la pratica ammini-strativa e quindi le politiche pubbliche (Meny,Thoenig, 1989; Crosta, 1998; Regonini, 2001;Dente, 1990; Gelli 2002, Capano, Giuliani 2002;Donolo, 2006), la policy anziché la politics, e diandare all’origine della costruzione della scienzadell’amministrazione, in relazione con la costruzio-ne delle scienze dello Stato (sarebbe qui da richia-mare la genesi delle Staatswissenschaften nellavicenda del pensiero politico tedesco. Essa dimo-stra l’intrinseco legame tra la scienza dello stato edella società, con le dottrine dell’amministrazioneed il nesso tra governo e amministrazione: cfr.Schiera, 1968; Scattola, 1994; per come si è svilup-pata invece la scienza dell’amministrazione in Italiaed i suoi legami con la tradizione tedesca si consi-deri Mozzarelli, Nespor, 1981). La vicenda dell’am-ministrazione pubblica si connette con quella dellagenesi dello Stato moderno (cfr. Miglio 1988, pp.255-324). Oggi siamo in una fase che molti indica-no di crisi dello Stato (cfr. ad esempio Cassese,
2002) e di crisi della concettualità che ha pensatoe costruito in termini perfomativi lo Stato. Lo stes-so dibattito sulla democrazia ne è una testimo-nianza (Cfr. Duso, 2006, pp. 367-390; Duso, 2004;Bobbio 19953; Sartori, 20003; Dahl, 2002; Mouffe,2007; sul rapporto tra democrazia e politiche pub-bliche cfr. G. Regonini, 1995)Certamente la disciplina della scienza dell’ammini-strazione è molto ampia e non c'è un manuale chesia soddisfacente da questo punto di vista. Pensaread un manuale di Scienza dell’Amministrazione è inqualche modo privo di senso, perchél’Amministrazione è qualcosa che si apprende, nonqualcosa che si impara. Per apprendere bisognaessere dentro i meccanismi dell’amministrazione,cioè amministrare. Per averne un’idea non è neces-sario un manuale con generalizzazioni e regole,occorrono semmai esempi, narrazioni. Diventa così,anche dal punto di vista della cognizione, fonda-mentale l’esperienza dell’azione, la dimensionedella prassi, piuttosto che quella della teoria. Vorrei quindi, in termini introduttivi, svilupparedelle considerazioni a partire da un particolarepunto di vista, ovvero apportare uno specifico con-tributo ad una scienza politica vocata alla dimen-sione amministrativa a partire da una matrice filo-sofica-politica, laddove il filosofico è inteso nelsenso pragmatico proposto da John Dewey, nelsenso vichiano del verum-factum e nel senso delconcetto di governamentalità e di regolazione diFoucault (cfr Lascoumes, Le Galés, 2004). Mi riferi-sco ad alcune conseguenze relative all’approfondi-mento della Storia concettuale quale modalitàdella filosofia politica, un approfondimento nonestraneo alla necessità di accedere all’analisi dellepolitiche pubbliche in termini sperimentali, comeconferma il concetto di “Pubblico” di Dewey (cfr.Dewey, 1927, trad. it. 1971, spec. pp. 145-170). Sela storia concettuale indaga la concettualità moder-na, alla base della teoria politica moderna, e ne
Giovanni Tonella
L’analisi delle politiche pubbliche
Il faro

Giovanni Tonella L’analisi delle politiche pubbliche
mette in evidenza la storicità (determinata), allostesso tempo, almeno dal punto dell’analisi deiconcetti, mette in evidenza la modernità del prin-cipio del potere le aporie della logica del potere(sulla storia concettuale come filosofia politica cfr.Duso 1993, 1999a, 1999b, 2003; Brunner, Conze,Koselleck, 1972-1997; la prospettiva storico-con-cettuale, sebbene ci siano dei punti di contatto, vadistinta, si badi, da quella storiografica del discorsoproposta da autori quali Pocock, 1972, trad. it,1990; Skinner, 2001), e l’esigenza, a partire dalledifficoltà e dalle contraddizioni della democrazia,anche quella contemporanea, di indagare unapproccio più realistico, che fugga da percorsi dineutralizzazione della politica, ovvero di neutraliz-zazione della partecipazione e di un concetto dipubblico più ampio di quello identificato con leistituzioni statali. Ecco che diventa fondamentaleapprofondire il governo come pratiche di ammini-strazione. Per prima cosa cercheremo di spiegare perchéattraverso l’analisi delle politiche pubbliche pos-siamo pensare la critica della logica del potere epensare la dimensione del governo (Donolo,Fichera, 1981). Poi cercheremo, analizzando lapubblica amministrazione, quale intreccio di azio-ne, burocrazia e politiche, di indagare il paradigmadelle politiche pubbliche, ovvero la centralità del-l’implementazione e della valutazione, oltre ladecisione, e quindi della pluralità dei soggetti. Perquesta tipologia di analisi sulle politiche pubblicheè fondamentale l’approccio scientifico di originepragmatista della policy inquiry, approccio chesottopone a critica la logica della programmazioneespressa dall’Analisi razionale delle politiche.Autori di riferimento sono Aaron Wildavsky e C.E.Lindblom (si considerino: Wildavsky, 1975, trad.it., 1978; Braybrooke, Lindblom, 1970; Pressman,Wildavsky, 19843; Wildavsky, 200611; Lindblom,Cohen, 1979; Lindblom, 1990). Poi considereremonello specifico le politiche di capacitazione (cfr. suquesto tema March, Olsen 1997, pp. 119-180), pro-prio a partire dal tema della partecipazione: miriferisco alle politiche di promozione della parteci-pazione o dell’empowerment della comunità intermini di capitale sociale e legami sociali. In parti-colare sono importanti le politiche che promuovo-
no forme partecipative nella redazione dei bilancio nella progettazione e pianificazione territoriale(sulla pianificazione territoriale cfr. P.L. Crosta,1983, 1990a, 1990b; sull’urbanistica partecipata siconsideri a titolo d’esempio del suo fiorire la sito-grafia italiana: www.avventuraurbana.it;www.abcitta.org; www.atelierlocali.org;w w w . c a n t i e r i a n i m a t i . i t ;www.cittapossibilecomo.org; www.lacittapossibile-fvg.it; www.cittapossibiletorino.org; www.focus-lab.it; www.ecoazione.it; www.gruppopalomar.it;www.ombrello.org; www.azionelocale.it. Cfr.anche: Batini, Capecchi, 2005; Sclavi, 2006;Bobbio, 2007). La partecipazione, infatti, costitui-sce il fulcro più dinamico del concetto deweyanopiù largo di pubblico, e, dall’altra, implica il puntolimite della crisi democratica (almeno della demo-crazia rappresentativa, che tuttavia non va consi-derata in antitesi con quella diretta) e quindi anchela valorizzazione della dimensione locale delgoverno (e della comunità) (cfr. sulla tematica delgoverno locale Bobbio, 2002; Pellizzoni, 2007;Della Porta, 1999; Gelli, 2005; Truini, 2004, pp. 5-52; Dewey, 1927, trad. it. cit., pp. 87-170).
1.2 Dal potere al governo debole.
Dal Potere al Governo dunque. Questo passaggiosignifica cogliere criticamente il nesso storico-concettuale tra la filosofia politica moderna oscienza politica moderna nella sua matrice concet-tuale hobbesiana del potere (che è poi l’arco checompie il passaggio dal giusnaturalismo modernoall’epoca della rivoluzione e della costituzione eche concettualmente si dà nella sociologia politicadel potere di Max Weber) e la logica del poteredegli Stati democratici e quindi il rapporto tra que-sta logica con i soggetti della politica quali rappre-sentanti politici della volontà sovrana del popolo.Questa concettualità oscura il problema della giu-stizia e del bene, neutralizzandolo in base alla for-male autorizzazione della volontà politica, e,dando riconoscibilità politica solo all’individuo,soggetto individuale, o al soggetto collettivo, loStato, neutralizza politicamente i soggetti reali dellapolitica, nelle loro articolazioni. Si tratta allora sia diconsiderare una concezione del potere, in quanto
53

n.22 / 2009
54
comando, più realistica e restituirle una maggioreaderenza rispetto ai processi reali, sia di tematizza-re il problema della partecipazione politica di fron-te alle forme di depoliticizzazione. Questo passaggio implica comprendere come lariduzione del potere ad un atto di volontà formal-mente autorizzata dal popolo quale grandezzacostituente è appunto astratta, e non fa i conti congli aspetti fondamentali del comando (e che d’altraparte conduce ad una aporia fondamentale ovveroalla contraddittoria mediazione tra volontà genera-le e volontà individuale, dal momento che que-st’ultima per porsi politicamente ha bisogno dellaprima, ma nel momento in cui pone la prima,toglie se stessa nella sua dimensione politica), enon comprende che oltre al comando vi sonoforme ulteriori di regolazione interdipendentedelle azioni umane e quindi politiche che riguar-dano la comunità. Accanto alla regolazione cheeccede il comando, regolazione come costume,regolazione come rule of law (cfr. Leoni, 1961,trad. it., 1994), vi è una regolazione che potremmoindicare nella mediazione che la decisione in quan-to tale subisce una volta che diventa attuazione, euna volta che questa attuazione è implementazio-ne che si accompagna accanto ad azioni necessarieper essa ma non derivanti dalla decisione; vi è unamediazione della decisione che necessita, nelladimensione dell’azione e quindi della pluralità,della negoziazione e della interazione con altri sog-getti. Il potere quindi acquista la sua dimensionereale in una dimensione di governo, ovvero di inte-razioni tra parti in cui c’è certo un inizio, uncomando, ma c’è soprattutto un concorso, che cirestituisce una idea di comando efficace se è uncomando che si implementa nel consenso e nellacooperazione. L’analisi delle politiche pubbliche ci ricorda che ladecisione non si dà in una tabula rasa, bensì in unadimensione piena, concreta, costituita; ciò signifi-ca che in questa dimensione emerge o viene rin-tracciato un problema che si pone di fronte il poli-tico e che deve essere risolto. Una dimensione chetuttavia ci fa comprendere come nella stessa riso-luzione del problema si creano nuovi problemi eche questa dialettica ripropone l’importanza asso-luta dell’implementazione.
Lo studio dell’analisi delle politiche pubbliche edel legame tra pubblica amministrazione e politi-che concrete permette il passaggio del fuoco del-l’attenzione dalla Politica alle politiche. Insomma ilpassaggio si potrebbe dire dal tema della legittima-zione politica a quello dell’economia dell’azionepolitica in tutte le sue articolazioni. In Italia grazieai lavori di Bruno Dente (cfr. Dente, 1989, pp. 16-111) vi è stata l’introduzione dell’attenzione nel-l’ambito della scienza dell’amministrazione verso irisultati di una particolare linea di ricerca dellascienza dell’amministrazione come investigazionepolitica, policy inquiry. La politica si scomponenelle politiche, che hanno una dimensione pubbli-ca non perché il soggetto della politica sia solo loStato o le istituzioni pubbliche, bensì perché atten-gono a problematiche che hanno a che fare con ilPubblico, con la comunità nella sua interezza. Orasi tratta quindi di dare una definizione di questepolitiche che eccedono la politica e ci fanno guar-dare ad essa da un’altra prospettiva. Appunto quel-la del governo. Questa politica (che è policy e nonpolitics) va definita in generale come termine inrelazione alle attività di governo, ai soggetti e nonsono solo alle istituzioni; inoltre la policy riguardanon solo gli effetti previsti, ma anche quelli nonintenzionali e si struttura essa stessa come un veroe proprio campo di ricerca dai confini mobili. Si tratta allora (anche a partire dalla legge dellapercezione del potere di Kaufmann, 1981, p. 4: “Ilpotere che un osservatore ritiene di attribuire aduna persona o a un gruppo è direttamente pro-porzionale al quadrato della distanza dell’osserva-tore dall’osservato. Più l’osservatore si avvicinaall’osservato, più il potere dell’osservato apparelimitato. E quando la distanza è zero, cioè quandola situazione è vista con gli occhi di chi detiene ilpotere, ciò che spicca sono le fragilità e i limiti delpotere, non la sua grandezza”) di avvicinarsi altema del governo, del potere esteso diluito, debo-le, insomma quello che in un saggio di Donolo èdefinito il governo debole, a partire dalle forme edai limiti della razionalità politica (cfr. Donolo,Fichera 1981, pp. 9-97). Donolo mette in evidenzail tema della crisi della governabilità, ovvero le cre-scenti domande a cui è esposto il sistema politico-amministrativo e le limitate capacità di risposta. Il

Giovanni Tonella L’analisi delle politiche pubbliche
governo (inteso come potere) è il problema e lasoluzione è appunto il governo debole (dal potereal governo, alla governance). Il punto di partenzaè appunto la crisi dello Stato, la presa d’atto dei fal-limenti della politica, soprattutto dei fallimentidella pianificazione. A partire dagli anni settantaemergono molteplici risposte teoriche a questaproblematica. La destra politica liberista proponela regolazione del mercato e l’arretramento delloStato (idea in connessione con il New PublicManagement, i processi di esternalizzazione e diaziendalizzazione e di privatizzazione) e teorizzauno Stato regolatore in senso debole che favoriscel’ordine spontaneo. La sinistra invece ritiene che larisposta non possa essere l’ordine spontaneo o lasemplice regolazione del mercato, ma lo Stato cheinterviene, programma e regola; l’accento è postosull’accrescimento della capacità di governo politi-co: vi è tuttavia la variante tecnocratica-razionaliz-zatrice, la variante dell’ingegneria costituzionale, lavariante neocorporativa, e la variante della sinistramarxista. Insomma da un lato meno Stato e piùmercato, dall’altro più Stato nel senso di più politi-ca (cfr. Donolo, Fichera, pp. 9-15). Da un lato una risposta diciamo di destra, che perònon prende in adeguata considerazione la necessi-tà del governo, la necessità strutturale di governo,e dall’altro una risposta di sinistra che non consi-dera adeguatamente la difficoltà del governo e nonapprofondisce i limiti del potere (cfr. ivi, p. 19).Nel primo caso, poi, vi è il paradosso per cui pergarantire meno Stato, c’è la necessità che sia loStato, in maniera forte, ad intervenire. Un esempioè quello della razionalizzazione delle amministra-zioni locali, ovvero del governo locale, operatadalla Thatcher (cosa resa comunque possibile dallacultura politica inglese) (cfr. Bobbio, 2002, pp. 73-75). Il primo approccio non comprende la com-plessità dell’intreccio politico statuale, rischia dicollidere con l’elevata stratificazione degli interes-si e degli scambi socio-economici. D’altro canto ilgioco dei vari sottosistemi socio-economici richie-de sempre una regolazione ed un intervento stata-le. Pertanto siamo in presenza di una complessitàdi problematiche non risolvibili solamente dalmercato: basti considerare la tutela dell’ambiente.Infine vi è il paradosso che si richiede il cambia-
mento al soggetto che viene identificato come fal-limentare e incapace di attuarlo: il paradosso dellacapacità dell’autoriforma (ad es. della classe politi-ca) (cfr. Donolo, Fichera, 1981, pp. 20-21). Difficoltà hanno anche però gli approcci del “piùStato” e “più politica”. Infatti si manifesta un disli-vello strutturale tra fabbisogno di governo e capa-cità effettiva di governo e di programmazione, spe-cie si intesa in termini sinottici. Ci sono due limitidi fondo: un deficit di consenso e di integrazione,per l’elevata differenziazione della società, esoprattutto un deficit di razionalità e di orienta-mento a lungo termine, dovuto all’incertezza delfuturo e all’aumento dei rischi collegati con la cre-scita tecnica e scientifica. Ogni pianificazione “sitrova di fronte alle seguenti difficoltà: a) si basasempre su di una carente ed incompleta informa-zione, b) il costante mutamento economico, tec-nologico, sociale (e normativo) porta a continuemodifiche del quadro; c) crea strutture di imple-mentazione che si comportano inerzialmente neiconfronti dei futuri e necessari cambiamenti equindi rendono difficile un adattamento della pia-nificazione a condizioni mutate” (ivi, p. 24). Comeci dice Lindblom l’ideale di pianificazione sinotticanon è adatto per una serie di motivi: per limitatecapacità di risoluzione dei problemi dell’uomo,per l’inadeguatezza delle informazioni, per il gran-de costo dell’analisi, a causa di fallimenti nellacostruzione di un metodo di valutazione soddisfa-cente e per l’oscurità della relazione osservata trafatti e valori nel far politica, per le diverse formenelle quali i problemi politici attualmente si pre-sentando ecc.(cfr. Braybrooke, Lindblom, 1970,pp. 47-57). Si deve allora comprendere come vi sia una disag-gregazione e un decentramento delle problemati-che e dell’amministrazione: una crescente ampiez-za e complessità dei compiti e degli apparati delloStato. Insomma il sistema politico-amministrativoche dovrebbe essere la soluzione è il problema.Una situazione così frammentata e complessa con-duce inevitabilmente alla difficoltà di risponderealla complessa frammentazione sociale, causandoun deficit di consenso. Possiamo quindi sottoli-neare la debolezza del paradigma della stanza deibottoni.
55

n.22 / 2009
56
L’idea del decisore del tipo “crisi/problemi allorasoluzione” è insostenibile: si deve passare ad unavisione per cui vi è una relazione reciproca trasoluzione e crisi/problema: ciò significa valorizzarela logica dell’iterazione, del coordinamento, deldecentramento, della segmentazione decisionale,dell’incrementalismo (cfr. Donolo, Fichera, 1981,pp. 47ss). Non c’è una teoria ed una prassi cherispecchia la teoria, non c’è un soggetto. Il governo è allora in questo senso debole, perchéè una risultante non prestabilita di processi di inte-razione tra governi parziali (imprese pubbliche eprivate, organizzazione degli interessi, frammenta-zione istituzionale e politica) e governo centrale,pluralismo dei soggetti che si determinano in rap-porto reciproco; è una risultante entro margini dioscillazione, di interazione, di non-decisione (cfr.Bachrach, Baratz, 1970, trad. it., 1986), e di decisio-ne; è un governo con preferenza per i cicli politiciminori, politica reattiva, settoriale, incrementale.Se la soluzione è la presa d’atto della dimensionedel governo debole, che per definizione alludeall’intreccio di più politiche differenziate e di unamolteplicità di approcci (che ad esempio prevedel’assunzione per la comprensione delle azionidegli attori politici di un mix di razionalità sinotti-ca e - secondo la lezione di Lindblom - di adatta-mento reciproco), allora è importante cercare dicapire, dal punto di vista della ricerca, quale sial’approccio o il programma di ricerca che puòessere più indicato per la comprensione delladimensione del governo.
1.3 Il paradigma delle politiche pubbliche: cen-tralità dell’implementazione e della valutazione,oltre la decisione. Le indicazioni della policyinquiry.
Se leggiamo la crisi di governabilità come occasioneper evidenziare la necessità del passaggio dalla logi-ca del potere a quella del governo, diventa fonda-mentale l’analisi dell’amministrazione come prati-che governo e quindi l’analisi delle politiche pubbli-che nelle loro caratteristiche. Si tratta, almeno nellospirito, di parlare con verità del potere e quindi alpotere (Wildavsky, 1979, 200611), sapendo in qual-che maniera che l’analisi politica significa innanzi-
tutto riflettere in seguito all’osservazione e trovare iproblemi circa ciò che potrebbe e dovrebbe esserefatto. Indagare il governo debole, indagare il pianodella realtà e non quello della rappresentazioneideologica del potere. All’interno di questo quadro si può dire che la stes-sa soluzione del problema individuato tramite l’os-servazione e la riflessione è parte della definizionedel problema (ivi, p. 3). Il Problem-finding è analo-go all’inventare e al teorizzare. Una volta individuato il problema, ecco che si dis-chiude la possibile soluzione (anche perché nosolution, no problem). E in tutto ciò serve creati-vità: in termini di teoria gestaltica, ristrutturazionedel campo, e riflessione fenomeologica (cfr. Sclavi,2003). L’analisi politica quindi si lega all’inventiva,all’individuazione dei problemi, all’osservazioneche utilizza e si nutre di radici sociali e quindi dellastoria. Storia come nutrimento del pensiero, ovve-ro una storia che è l’insieme di vicende da cui trar-re insegnamento, magari prognostico o emulativo,e non piuttosto una storia che è al contempo unafilosofia della storia (storia allora non tanto comeGeschichte, ma come Historie) (cfr. Koselleck,1979, trad. it., 1986). In questo senso l’analisi di uncaso diventa il metodo per eccellenza. Divental’occasione per porre le domande e trovare le solu-zioni, per sottoporre a critica la pianificazione ope-rata da un punto di vista totalizzante, sinottico, cheha la pretesa di avere le informazione necessarie esufficienti. E quindi diventa l’opportunità per sce-gliere come decisivo il problema dell’implementa-zione (Pressmann, Wildavsky, 19843), nella quale sidevono individuare i soggetti che agiscono, l’azio-ne, il numero dei soggetti, il numero delle regole edelle regolazioni, i livelli di governo istituzionale.L’impostazione di scienza delle politiche che hacentrato il tema dell’implementazione è quellacosiddetta della policy inquiry (cfr. sul termineinquiry Dewey, 1938, trad. it. 1974; sulla nozione diinquiry di Dewey: Schön, Rein, 1994, p. 52: “La teo-ria sviluppata da John Dewey… attribuisce al ter-mine inquiry un significato ben più ampio di quel-lo comune di investigazione, per far invece riferi-mento alla generale interazione tra pensiero e azio-ne. Per Dewey l’inquiry inizia come risposta a unostacolo nel fluire delle azioni, quando chi va in

Giovanni Tonella L’analisi delle politiche pubbliche
avanscoperta incontra una situazione problematicache è intrinsecamente dubbia o indeterminata”). Sitratta di un’analisi dei processi decisionali e deiprocessi di implementazione delle politiche chenon assume come paradigma ideale la razionalitàsinottica, l’economicità o l’obiettivo di una correttasoluzione dei problemi. Al centro di questo approc-cio sta l’idea che qualunque proposta di interventodeve partire dal riconoscimento che i problemi dipolicy (nella inquiry secondo Schön, 1971, p. 213:“La diagnosi si manifesta attraverso l’intervento”) ele aspettative circa le soluzioni affondano le lororadici in complesse interazioni sociali, in inevitabiliconflitti politici, in incerte congetture non solo sulfuturo ma anche sul passato. Insomma assumepotremmo dire come terreno d’analisi quello pro-prio dell’azione e quindi della prassi, un terreno incui si rischia. Secondo questo orizzonte “le riformenon dipendono solo da un’idea brillante, ma da unduro lavoro di scavo per far emergere quel che staaccadendo, e da un’insistenza ancora più dura sulfatto che l’interpretazione di questi risultati dev’es-sere negoziata con una franca discussione” (Heclo,Wildavsky, 1974, p. 389).Innanzi tutto le politiche sono da intendersi comeconoscenze in uso. Infatti le politiche implicanoteorie, in modo più o meno esplicito e trasparente.Da questo punto di vista le politiche sono una fonteimportante di conoscenze sulla società in cui ci èdato vivere e un’occasione quindi di apprendimen-to. Inoltre le politiche sono intese come interazio-ni. La policy inquiry si basa sul ruolo che l’intera-zione tra gli attori svolge nella definizione delle poli-tiche. Per capire questa prospettiva è fondamentalecomprendere come essa prenda le distanze dall’a-nalisi razionale delle politiche pubbliche (si pensialla Programmazione per obiettivi e alla metodolo-gia POSDCORB) a cui viene imputato una deforma-zione astratta intellettualistica e una impossibile dalpunto di vista cognitivo razionalità sinottica onni-sciente. Wildavsky sottolinea: “La politica si presen-ta come individuale, ma di fatto è sociale, mentre lapianificazione si presenta come sociale, ma di fattoè personalistica” (Wildavsky, 1979, 200611, p. 123).All’interno della logica dell’interazione, che implicaquella dell’aggiustamento reciproco, l’analista è inqualche modo il facilitatore dei processi di intera-
zione, certamente (verum) è il costruttore delsenso dei processi di interazione (factum). Nellostudio dell’interazione il ricercatore sociale devepresupporre che quando la gente non lo capisce èlui che sbaglia; inoltre deve far emerge tutti gli inte-ressi in gioco, deve favorire l’interazione. Diventacosì fondamentale approfondire le tecniche diascolto (cfr. Sclavi, 2003, pp. 21-115). Ancora, secondo l’approccio della policy inquiry lepolitiche sono da intendersi come processo. Comeafferma Lindblom: “Noi consideriamo il policymaking come un processo estremamente comples-so, senza un inizio o una fine, con confini cherimango in gran parte incerti” (Lindblom, 1980, p.5). Non sono le norme, le leggi, le decisioni forma-li, bensì il flusso dei processi a rivelare il senso diquello che accade nella sfera pubblica. La consape-volezza di una politica pubblica è quindi retrospetti-va: ciò determina il fatto che nell’analisi delle politi-che la formulazione del problema è paradossalmen-te più vicina alla fine che all’inizio dell’analisi. Ora in relazione al processo vanno distinti i fini daimezzi: nella prospettiva top-down si parte dalladefinizione dei fini per arrivare alla scelta dei mezziper la concerta implementazione; nella prospettivabottom-up si parte viceversa dai mezzi per la con-creta implementazione e si va all’interpretazionedei fini. Questo secondo approccio è quello piùconforme alla policy inquiry ed alla considerazio-ne della politica come processo. L’azione politicacome processo implica inoltre la circolarità delpolicy making. Infatti ogni momento può esserevisto come chiusura di un percorso o come iniziodi un altro, e come implementazione di una pre-cedente scelta o come irruzione di un nuovo pro-blema. Pertanto è fondamentale nell’analisi dellepolitiche riconoscere la centralità dell’implementa-zione, l’importanza di una valutazione riferita con-testualmente alla stessa implementazione e la con-tinuità dei percorsi, in genere aperti solo a modifi-che incrementali (la cosiddetta dipendenza dalpercorso, path dependence). Sul piano descrittivol’incrementalismo tende a ridimensionare l’alonedi eccezionalità con cui i policy makers amano cir-condare le loro iniziative. Vengono così contestatela visione di politiche orientate ad uno scopo ecoerenti e l’idea di strategie di ampia portata.
57

n.22 / 2009
58
Wildavsky propone la cosiddetta legge delle AmpieSoluzioni che “asserisce che più larga è la porzionedello spazio di policy occupata da una presuntasoluzione, e più difficile è trovare una soluzione chenon diventi il proprio peggior problema”(Wildavsky, 1979, 200611, p. 63).Un altro modo per interpretare le politiche, all’in-terno della logica della policy inquiry, è quellodella teoria del bidone della spazzatura. Questateoria limita l’idea che l’azione politica sia domina-ta da una razionalità coerente e finalizzata, oltreche pianificante. La visione per cui esiste una rela-zione unidirezionale tra l’intenzionalità dell’agentee gli esiti dei processi di scelta collettiva, tale dafondare la stessa concezione della responsabilità eresponsività politica (accountability) democrati-ca. Infatti a causa della molteplicità degli attori,della complessità delle cause e del condiziona-mento reciproco tra gli agenti è difficile trovare uncentro di imputazione. Per tali ragioni l’idea diresponsabilità politica è piena di ambiguità, ambi-valenze e contraddizioni. I resoconti delle politi-che sono perciò spesso una forma di giustificazio-ne ex post. Gli attori sviluppano e narrano storieche danno un senso e un ordine ad un processoche in realtà è caratterizzato dall’ambiguità.Ora, nel modello cosiddetto del bidone della spaz-zatura o del cestino dei rifiuti alle relazioni causaliè sostituito il criterio della concomitanza tempo-rale: “Problemi, soluzioni, decisori e occasioni discelta inizialmente sono collegati solo dal tempo diarrivo sulla scena e dalle possibilità disponibili inquel tempo” (March, 1994, p. 201, trad. it., p. 210).“Nel processo bidone della spazzatura si assumeche gli arrivi delle occasioni di scelta, dei problemi,delle soluzioni e dei decisori siano esogeni e rego-lati dal tempo. Problemi e soluzioni sono attaccatialle scelte, e quindi tra di loro, non da qualche col-legamento mezzi-fini, ma per la loro vicinanza tem-porale. Al limite, ad esempio, una qualunque solu-zione può essere associata a un qualunque proble-ma, purché entrambi siano evocati nello stessotempo […]. Le occasioni di scelta mettono insie-me decisori, problemi e soluzioni” (ivi, p. 200,trad. it., p. 209). Si tratta quindi di comprenderel’allineamento e la relazione tra il flusso degli atto-ri (che mutano e sono molteplici), quello dei pro-
blemi (più che risolvibili, soppiantabili)(Wildavsky, 1979, 200611, p. 83: “I problemi nonsono tanto risolti quanto, piuttosto, soppiantati[…]. Ad essere fuorviante è la nostra aspettativa diuna chiusura, di una decente sepoltura, anziché dirigenerazione e rinascita”; Schön, 1971, p. 142:“Nel governo, come in filosofia, le vecchie questio-ni tendono a non trovare risposte: vanno solo fuorimoda”) e delle soluzioni (che mutano, invecchia-no, ritornano), tenendo conto della fondamentaleimportanza dell’attenzione, quale risorsa cognitivascarsa e discontinua. Ora per l’analisi delle politiche pubbliche l’impli-cazione più inquietante della teoria del cestino deirifiuti è la divaricazione tra decisione e processodecisionale: “Molte decisioni sono prese in man-canza di meglio, e i processi decisionali spessosono un’esercitazione sui problemi che non portaa una soluzione. Le decisioni sono prese al di fuoridi un esplicito processo decisionale, e i processidecisionali spesso non riescono a produrre deci-sioni” (March, 1994, p. 177, trad. it., p. 187). Ledecisioni sono quel che si produce quando un’op-portunità di scelta crea un punto di incontro tra gliattori, le soluzioni e i problemi in quel momentosulla scena. Spesso i decisori per decidere voglio-no e raccolgono informazioni a dismisura, ma allostesso tempo non decidono in base alle informa-zioni: queste ultime quando non arrivano tardi, adecisioni già prese, non vengono selezionate perle decisioni, ma solo per giustificare ex post ladecisione. Inoltre la conoscenza utilizzata per unadecisione raramente è innocente. Lo stessoapprendimento non è da intendersi in terminilineari: si tratta invece di un adattamento recipro-co, per cui un competente si adatta ad esempio adun incompetente e non viceversa. L’apprendimento è vincolato a dei limiti cognitivi el’implementazione non traduce necessariamenteciò che si è appreso.
1.4 Le politiche di capacitazione politica: le poli-tiche deliberative e la questione della partecipa-zione.
Molti osservatori indicano come stia morendo ilvecchio “Stato amministrativo centralizzatore e

Giovanni Tonella L’analisi delle politiche pubbliche
burocratico, trasformandosi in un arcipelago diorganismi differenziati per tipo e funzione, forte-mente intrecciati con attori economici, sociali etecnico-scientifici” (Donolo, 2006, XI). Siamo quin-di di fronte ad una evoluzione della funzione pub-blica (cfr. Crozier, 1992). Mentre nel fordismohanno prevalso politiche pubbliche per la macro-regolazione del ciclo economico, per il sostegnodelle riconversioni industriali e per la crescita del-l’occupazione (politiche industriali), per la redi-stribuzione del reddito (welfare), per la dotazioneinfrastrutturale (investimenti pubblici, politichedistributive), nella fase attuale, postfordista e glo-bale, sono richieste: politiche regolative e integra-te in tutti i settori critici (innovazione, ambiente,esternalità, welfare mix), investimenti sulle reti, esulla logistica, e quindi politiche di governo strate-gico del tempo e dello spazio (cfr. Donolo, 2006,XII; tra l’altro Donolo sottolinea come questoimplichi la consapevolezza di come le politicheche si svilupperanno sono diverse da quelle criti-cate dall’impianto logico di Wildavsky e Lindblom).A noi tuttavia interessa sottolineare che fra lenuove politiche che vengono avvertite stiano lecosiddette politiche attive che, più che garantire inastratto diritti, fanno investimenti sulle azioni poli-tiche che promuovono capacità, su politiche nego-ziali e/o con forte componente deliberativa intutto il governo dei fattori di crisi e di rischio. Sitratta di politiche interattive e transattive orientateall’enactment (cfr. Weick, 1997, pp. 30-39) e allacapacitazione degli attori (cfr. Donolo, 2006, XIII). Dobbiamo quindi approfondire l’importanza dellaproduzione di politiche per la capacitazione neiprocessi deliberativi e implementativi: indagare iltema delle cosiddette politiche deliberative chepoggiano su di una cornice teorica che comprende-re il tema della partecipazione (cfr. Bobbio, 2002a,pp. 101-141, 2004b, pp. 5-29, 2005, pp. 67-88, 2007b,pp. 359-383; Regonini, 2005, pp. 3-31; si veda ancheil numero monografico sulle forme deliberativedella “Rivista Italiana di Politiche Pubbliche”, 2/2007.Inoltre dal punto di vista del loro utilizzo nellaPubblica amministrazione cfr. Bobbio, 2004a e2007a; sulla deliberazione e sulla democrazia deli-berativa si veda Pellizzoni 2005; in rapporto allademocrazia partecipativa cfr. Gbikpi, 2005, pp. 97-
130; in termini generali cfr. anche Held, 2007, pp.399-440 e Bosetti, Maffettone, 2004).Quello che conta in questi casi è che “la definizio-ne del problema e la ricerca di una soluzione sonoesplicitamente demandate all’interazione tra unapluralità di attori (pubblici, associativi, privati) cherispecchiano gli interessi e i punti di vista rilevantiper la questione sul tappeto. Le istituzioni rinun-ciano (parzialmente e temporaneamente) a scio-gliere il nodo secondo le procedure canonichedella democrazia rappresentativa e scelgono disvolgere un altro ruolo: quello di promotori di unconfronto e di garanti della sua correttezza. Dadecisori si trasformano in facilitatori, da giocatoriin arbitri” (Bobbio, 2005, p. 69). Ciò avviene nonsolo per gestire e prevenire i conflitti, ma ancheper produrre un percorso decisionale inclusivo epartecipativo, in grado di catalizzare le risorse dellacittadinanza attiva, di recepire idee dalla società equindi tale da essere più forte in se stesso e pro-duttore di competenze sociali e cognitive nuove,produttore di civismo. “Sia che si tratti di risolvereo prevenire un conflitto, di dirimere questioni con-troverse, di progettare il futuro di una comunità, divarare interventi integrati, il risultato è alla finemolto simile: si costruiscono ambiti specializzati diinterlocuzione in cui si confrontano in modo strut-turato i principali punti di vista o i principali inte-ressi che sono coinvolti dal tema sul tappeto” (ivi,p. 71). I processi di questo tipo possono avvicinar-si di più o di meno alla democrazia deliberativanella forma in cui interpretano le caratteristichedell’inclusione (per sorteggio e per campione rap-presentativo, o per autoselezione o includendo glistakeholders) (cfr. ivi, pp. 72-74) e della delibera-zione, ove abbiamo a che fare con le seguenti tipo-logie: i sondaggi deliberativi - deliberative opinionpolls (Fishkin, 2003), Plannungszelle (Dienel,20025) le citizens juries, le consensus conferencesecc. (cfr. Bobbio, 2004b, Pasquino 2007). L’arena deliberativa non prevede di ricorrere allavotazione, e per tale ragione non ha il problemarappresentato dal fatto che votare dissuade al con-fronto in base alle argomentazioni e alle ragioni asostegno di una tesi, e tende a riprodurre i rap-porti di forza e le posizioni precostituite. Essaquindi favorisce appunto il confronto e la trasfor-
59

n.22 / 2009
60
mazione delle posizioni iniziali, la deliberazioneanziché la negoziazione (cfr. Elster 2005, spec. pp.97-153. Nel primo caso le parti non hanno bisognodi argomentare e giustificare il proprio punto divista, devono portare a casa un vantaggio. Nelsecondo invece vi è appunto un processo di giu-stificazione e argomentazione in base alle propriragioni, facendo riferimento a principi condivisi). Per quanto riguarda l’inclusione, è chiaro chedipende dal numero dei portatori di interessecoinvolti. Si rischia di non dare voce ai gruppi dis-organizzati, magari diffusi ma non organizzati, omarginali e non organizzati. Si pensi agli immigra-ti, ai bambini, agli anziani, alle giovani donne, allefuture generazioni. Insomma agli interessi deboli edispersi. Su questo aspetto è importante produrreun approfondimento: infatti un differente punto divista, critico rispetto agli assetti sociali attuali, chesottolinea invece gli aspetti di governamentalità edi regolazione che cercano di neutralizzare il con-flitto producibile da parte dei soggetti riconosciutima non autorizzati (migranti clandestini, abitantidegli slums, occupanti di case nelle periferie dellegrandi metropoli globali) o autorizzati ma nonriconosciuti (precari, lavoratori intermittenti: tutticoloro che a differenza dei primi possono esserericonosciuti come cittadini, e che non sono tutta-via di fatto socialmente abilitati al pieno godimen-to dei diritti sociali e di cittadinanza), rileva comele nuove forme di governance non riescano insenso positivo, nonostante la loro vocazione, adeterminare e controllare questi soggetti (cfr.Chignola, 2008, e Chatterjee, 2004). Ora, al di là diquesto approfondimento critico, si può evitare ilrischio di non dare voce ai soggetti deboli (comeaccade nella fase preparatoria dei piani territoriali,strategici, progetti di riqualificazione urbana) met-tendo in atto una campagna preliminare di ricerca-ascolto o di animazione territoriale in modo da faremergere e coagulare tali interessi (cfr. ad esem-pio la campagna preparatoria del progetto “Nonrifiutarti di scegliere” descritto da Bobbio, 2002a,pp. 110-111), o di coinvolgimento verso le profes-sioni che hanno una maggiore sensibilità verso ilfuturo. Infine l’inclusione diventa difficile versoquei gruppi di puro antagonismo, che non sonodisposti ad accettare forme di compromesso.
A partire dall’analisi delle forme di democraziadeliberativa si possono considerare le differentiforme di arene deliberative. Si trovano arenesostanzialmente chiuse formate da pochi attoricon interessi omogenei (arene neocorporative),oppure aperte e formate da molti attori con inte-ressi disomogenei (i piani strategici, le Agende 21,gli interventi di urbanistica o il bilancio partecipati-vo). Oppure arene in posizione intermedia: adesempio quelle dei casi di concertazione per lo svi-luppo locale, con rappresentanza più variegatadelle arene neocorporative, ma con interessi piùomogenei di natura economica, rispetto alle altrearene più inclusive. Nella costruzione di queste arene, si compie unastrutturazione che dà luogo alla capacità di mette-re in campo un sistema allargato di governo e dipromuovere le forme di cittadinanza attiva. Si con-sidera giustamente l’importanza di valorizzare leforme della cittadinanza attiva e le sue forme diimpegno politico e di pensare la dimensione delgoverno come quella che catalizza le risorse politi-che di impegno della società (Cfr. Moro, 1998, pp.27-49; Osborne, Gaebler 1992, trad. it. 1995: inquesto importante saggio si propone una riformadella pubblica amministrazione sulla base di diecicaratteristiche innovative: 1) guidare anzichéremare; 2) responsabilizzare le comunità anzichéservirle; 3) immettere concorrenza nella fornituradei servizi; 4) trasformare le organizzazioni guida-te dalle regole in amministrazioni guidate dallamissione; 5) finanziare i risultati anziché i provve-dimenti; 6) andare incontro alle esigenze del clien-te e non a quelle della burocrazia; 7) guadagnareanziché spendere; 8) prevenire anziché curare; 9)passare dalla gerarchia alla partecipazione e al lavo-ro di gruppo; 10) cambiare attraverso il mercato.L’idea di fondo è che le amministrazioni debbanotrasformarsi in governi catalizzatori, cioè capaci ditrovare e attivare risorse ed energie per svolgerecompiti che esse non hanno più la possibilità diassicurare da sole. In esso vengono coinvolte siarisorse pubbliche che private, sia quelle del terzosettore. Inoltre ed è questo l’aspetto funzionaleall’affermarsi dell’importanza della cittadinanzaattiva al centro della teoria del governo catalizzato-re c’è l’idea che bisogna responsabilizzare le comu-

Giovanni Tonella L’analisi delle politiche pubbliche
nità anziché assisterle. La gestione comunitaria èsuperiore rispetto ai servizi gestiti da enti e profes-sionisti per diverse ragioni: 1) le comunità mostra-no un impegno nei confronti dei propri membrimaggiore di quello che i sistemi di fornitura deiservizi mostrano verso l’utenza, 2) le comunitàcapiscono i loro problemi meglio dei professioni-sti; 3) i professionisti e le burocrazie fornisconoservizi; le comunità risolvono problemi; 4) istitu-zioni e professionisti offrono un servizio; le comu-nità offrono un aiuto; 5) le comunità costanomeno dei professionisti dei servizi; 6) le comunitàfanno rispettare le norme di comportamento inmodo più efficace delle burocrazie o dei professio-nisti dei servizi; 7) le comunità si concentrano sullecapacità; i sistemi dei servizi si concentrano sullecarenze). Nelle forme di democrazia deliberativa vi è più cheuna netta divisione un continuum tra l’atteggia-mento strategico teso a negoziare tra interessi fortiprecostituiti e quello comunicativo più interessatoad argomentare e a trasformare in base a richiamirazionali, ragionevoli o morali le posizioni in campo(per una critica, tuttavia, ad una concezione dellapolitica che ha troppa fiducia di neutralizzare ilconflitto si veda: Mouffe, 2007. La Mouffe riprendela lezione si Schmitt: cfr. Schmitt, 1972, spec. pp.89-208. Su quanto sia determinante nell’azionepolitica la determinazione dei soggetti antagonisti ela dimensione pubblica della contesa, in termini dicritica alla concezione pluralista, si veda ancheSchattschneider, 1960, trad. it., 1998, spec. pp.61-78). Possiamo definire due poli: negoziazione(re)distributiva e deliberazione con in mezzo variesfumature. Ci sono quindi diversi gradi di delibera-zione: ciò va inteso appunto in riferimento alla pre-valenza o meno del polo negoziale. Il polo nego-ziale prevale con pochi attori in cui il peso degliinteressi è forte ed è fortemente polarizzato (areneneocorporative), diminuisce via via in funzione del-l’aumento degli attori e della diminuzione del pesodegli interessi, e della loro polarizzazione (giurie dicittadini, in cui cittadini comuni sono sorteggiati).Ci sono inoltre esperienze invece che tendono asituarsi in una posizione intermedia. Ci riferiamo aipiani strategici e ai processi di Agenda 21 chehanno una composizione variegata tale da permet-
tere una comunicazione basata su argomenti, seb-bene sono esposti a integrazione di natura oppor-tunistica, in cui il risultato finale risulti una giustap-posizione degli interessi dei partecipanti. Invece ipatti territoriali e le altre forme di concertazioneper lo sviluppo locale tendono più nettamenteverso il polo negoziale.Nell’esperienza della Pubblica amministrazione edelle politiche pubbliche, malgrado i limiti, leesperienze deliberative sono in forte aumento,poiché rispondono alla oggettiva necessità di daremaggiore legittimazione e creare maggiore con-senso attorno all’azione politica, in una fase dideclino dei partiti e soprattutto di frammentazionesociale e amministrativa. Non solo: rispondonoanche alla necessità di prevenire e gestire i conflit-ti e favorire l’implementazione. Inoltre la logica deliberativa, se non tende ad inte-grarla, devia dalla logica democraticista dellademocrazia maggioritaria e decisionista, oggi ingrande voga, sul tema della lentezza della rispostapolitica (cfr. Bobbio, 20036, spec. pp. 86-97). Ecerca anche di costruire spazi di partecipazione edi azione congiunta dei soggetti diversi della realtàpolitica, favorendo l’affermazione di nuove catego-rie del pensiero politico, meno legate alla logicadella rappresentanza politica tradizionale. Si trattaallora di fare un passaggio analitico relativo allanozione di partecipazione. Infatti le indagini com-piute rispetto ad essa ci indicano come vi sianoalcune caratteristiche fondamentali per definirla,intendendola come un fenomeno sociale in cui sidà su di una scala di minore o maggiore presenza.Non solo: la partecipazione reale è direttamenteproporzionale all’azione politica, alla sua dimen-sione di rendicontazione pubblica (Cfr. Tonella,2006, pp. 59-67), alla sua capacità di incidere sullestrutture della decisione (Cfr. Pellizzoni, 2005, pp.479-511; per esperienze concrete di partecipazio-ne nelle decisione dei bilanci partecipativi Ravazzi,2006, pp. 61-89; in generale sulla partecipazionepolitica, Raniolo, 2002, anche la scala della parteci-pazione delineata da Arnstein, 1969, pp. 216-224):dal grado zero al massimo grado: manipolazione,cura, informazione, consultazione, pacificazione,partnerariato, delega di potere, controllo da partedei cittadini), e si dà nella maniera più radicale
61

n.22 / 2009
62
quando non è ricondotta a forme routinarie, bensìquando si esprime su singole istanze. Ciò significache acquista particolare importanza l’ambito loca-le, e specialmente quello del governo locale, qualedimensione più consona a favorire politiche dicapacitazione e partecipazione (questa è la sfidache lancia Dewey alla fine di Comunità e potere).
1.5 Conclusione.
Alla luce di quanto osservato in questa percorsoanalitico, si può comprendere come dalla minieradell’analisi delle politiche pubbliche, si possonorinvenire le tracce di sentieri utili per promuovereuna nuova riflessione sulle categorie del pensieropolitico, che siano consapevoli della crisi della con-cetti politici moderni, e che operino un loro oltre-passare, per radicarsi in maniera più realistica neiprocessi storico-politici. Alla luce di questo intentoacquista rilevanza ancor maggiore un paradigma diricerca che sottolinea l’importanza della praticafederalista (cfr. Elazar, 1998; sul federalismo intesocome critica al potere cfr. Duso, 1999b, pp. 161-189; sul federalismo come pratica in relazione allastoria politica e della scienza politica italiana cfr.Gangemi, 1994) e la ricerca di nuove forme di par-tecipazione politica, e di responsabilizzazione neiconfronti del destino comune che lega le nostrecomunità storiche. Si tratta di avviare un appro-fondimento sulle forme di partecipazione politica,di capacitazione politica e di deliberazione, ancheperché sono strettamente legate alla necessità direndicontare l’azione politica e responsabilizzarnegli attori.
Parte seconda: elementi di analisi edottrina sperimentale delle politichepubbliche.
2.1 Introduzione. Pratiche di governo innovative.
Appare necessario riprendere il discorso iniziato in“L’analisi delle politiche pubbliche (I). Dalla logi-ca del potere alla dimensione del governo” par-tendo dalle conclusioni ed in particolare dall’im-portanza della dimensione legata al governo localecome terreno per l’applicazione di politiche di
capacitazione democratica e di tipo deliberativo. Se noi vogliamo valorizzare quelle pratiche digoverno funzionali all’attivazione della cittadinan-za attiva, alla promozione di partecipazione singo-lare e produttiva, alla valorizzazione del civismo edei legami che potremmo definire comunitari efunzionali non solo all’urbs e alla civitas, nella suacomponente infrastrutturale e materiale, ma anchealla polis (cfr. Sebastiani, 2003, pp. 35-52; 2007; siveda anche Della Porta, 2006 e Baccetti, 2008),ovvero all’idea politica di città, come luogo apertoall’azione, all’iniziativa del cittadino, è necessariofocalizzare l’attenzione sulle tecniche di governo edi empowerment della comunità ad oggi affinate(cfr. Batini, Capecchi 2005; sulla nozione di capaci-tazione Nussbaum, 2001, spec. pp. 90-120). E que-sto per collocare la ricerca sulle politiche pubbli-che in relazione al problema di come attivare epromuovere le comunità locali e la lodo dimensio-ne pubblica e politica, come insomma potenziare ilPubblico, in senso deweyano (Dewey, 1927, trad.it. 1971).Si tratta di una ricerca importante, che coinvolge lametodologia della ricerca sociale, l’etnografia urba-na, l’urbanistica, la scienza delle politiche oltre chela politica intesa come luogo ineliminabile dellacontesa tra interessi avversi (contesa che non vaneutralizzata o esternalizzata, come è insito nelsogno della scienza politica moderna, ma che vagovernata) (cfr. Mouffe, 2007: il saggio dellaMouffe è interessante perché, a partire dalla valo-rizzazione della riflessione politica di Schmittdemistifica l’illusione della subpolitica promossadalla terza via di Beck e Giddens, illusione chetende ad esorcizzare il conflitto redistributivo,rimuovendolo trasformando l’avversario in nemicomorale. La via illusoria della neutralizzazione delconflitto vive anche alla radice della modernitàpolitica, accanto alla genesi dello stato moderno.Si tratterebbe in realtà di una riedizione dellanevrosi ossessiva del Leviatano hobbesiano. La car-tina di tornasole di questa impostazione è la con-cezione della guerra. Su questo si consideriScattola, 2003, spec. pp. 9-42). Si tratta di promuo-vere la costituzione di sfere pubbliche, l’istituzionedel Pubblico, nel senso deweyano della comuneindagine-ricerca-azione finalizzata alla scoperta ed

Giovanni Tonella L’analisi delle politiche pubbliche
alla risoluzione di problemi intersoggettivi e inter-dipendenti che riguardano una comunità, un terri-torio, una città, indagine che non tollera, tra l’altro,gerarchia tra pensiero specialistico e non speciali-stico, tra esperto e cittadino (cfr. Crosta, 1983,1990, 19904, 1998).
2.2 Il nuovo ruolo del politico.
All’interno della logica di capacitazione politica equindi di costruzione di forme innovative di gover-no delle risorse identitarie, relazionali e epistemi-che delle comunità in funzione della risoluzione diproblemi comuni, è fondamentale comprendereche ruolo sociale assume il politico: ovvero la fun-zione di colui che si assume l’onere e la responsa-bilità di rappresentare la comunità. Il tema qui sisposta sulla comprensione del ruolo della decisio-ne e del processo decisionale. La decisione politi-ca è di norma imputabile solamente a colui cherappresenta e quindi è autorizzato dalla comunitàpolitica. In questo caso, se la rappresentanza siriduce, come nella sua logica concettuale, a auto-rizzazione senza vincolo del rappresentante, è evi-dente che la decisione è concepita come sospesanel vuoto, come se di fronte a d essa non ci fossenulla, una tabula rasa (cfr. Duso, 1999). Ciò nonavviene né a livello di senso comune, per il qualela delega non è pensata in questi termini, né a livel-lo fattuale, considerando il groviglio spesso di inte-ressi, ragioni e passioni che innervano lo spazio sucui incide il decisore politico. Fuor di metafora:una decisione priva di consenso, rischia di nonessere in grado di prevenire e di gestire il conflittoche da essa può scaturire, e rischia quindi di ren-dere di difficile attuazione ed implementazione ilcontenuto della decisione. Per questo nella rifles-sione politologia, quella legata all’analisi delle poli-tiche pubbliche, che fa della centralità dell’imple-mentazione il punto focale e decisivo, è avanzatal’idea di un decisore consapevole della complessi-tà del processo decisionale, delle condizioni relati-ve alla decisione e della materia su cui si decide. Ilruolo del politico suggerito è quello sempre piùdel facilitatore e garante di processi decisionali e didecisioni che abbiano un largo consenso preventi-vo e quindi che siano capaci di prevenire il conflit-
to, di riconoscerlo e gestirlo e che siano in gradodi valorizzare i saperi, le capacità e le competenzedella cittadinanza (cfr. Bobbio, 20036; Moro,1998).Questa impostazione analitica e questa indicazionese si vuole normativa sembra cozzare con il “sensocomune”, propenso al governo veloce e facile, inun quadro oggettivo di sovraccarico della doman-da e quindi di aumento della critica verso la politi-ca percepita inefficiente sempre più come tale.Insomma si evidenza una possibile polarizzazionetra la necessità di velocizzare e rispondere alladomanda sociale in tempi celeri e la presa d’attodella complessità di quello che abbiamo definito ilgoverno debole. Tuttavia all’altezza del governo(specialmente) locale e del governo inteso comeinsieme di politiche funzionali alla partecipazione,non c’è dubbio che l’ideologia del governo veloceè una fotocopia sbiadita della logica autoritativa(del potere) (cfr. Duso, 1999, 20012) che non hareso più semplice il governo e non ha risposta alproblema della caduta di fiducia della popolazionenella politica. Si tratta di proporre non solo unavisione diversa che ritiene di essere maggiormenterealistica del processo politico (partendo dagliassunti dell’analisi delle politiche pubbliche, sialegate all’analisi razionale delle politiche, chesoprattutto all’analisi del policy making e dellapolicy inquiry) (cfr. Regonini, 2001), ma anche unpunto di vista normativamente altenativo alla logi-ca del potere (così interpreto ad esempio lo sforzoteorico-pratico di Sclavi, 2006), per il quale il poli-tico assume il ruolo di facilitatore, garante, arbitro,creatore di spazio di partecipazione delle soggetti-vità interessate alla risoluzione dei problemi a par-tire dalle loro competenze specifiche su di essi (suquesta tematica, anche di natura epistemologica, siveda, con riferimento al dibattito sul rinnovamen-to della scienza politica italiana, la Premessa di G.Cangemi, 2006, pp. 9-40, spec. pp. 9-35. Gangemisviluppa una riflessione relativa alla concezionedell’antipolitica e dell’impolitica. Si veda su questaproblematica Esposito, 1999). E proprio sotto que-sto aspetto è possibile classificare tutti quei tenta-tivi di democrazia deliberativa e partecipativa chepossono essere considerati come le forme innova-tive che dovremmo tematizzare.
63

n.22 / 2009
64
Innanzitutto cominciamo a considerare il proble-ma dello stadio decisionale e dei partecipanti, perpoi trattare i metodi e le tecniche e quindi le tec-niche relative all’ascolto (relative alla raccolta disaperi ed informazioni), all’interazione (da finaliz-zare in modalità costruttive) e alla gestione delconflitto (da riconoscere e rendere agonistico,anziché distruttivo o antagonistico) (seguiremo leindicazioni assai fruttuose di Bobbio, 2004, 2007;Sclavi, 2003, 2006; Batini, Capecchi, 2005).
2.3 Il problema del processo decisionale.Decisione, decisori e stadio decisionale.
Il tema di fondo è quello del valore del processodecisionale come processo inclusivo: non si devo-no distinguere questi due momenti. Ciò significache il problema della decisione si interfaccia conquello della partecipazione ovvero che la strutturae il metodo della decisione si relazione costitutiva-mente con quelli della partecipazione. L’inclusioneparte dalla considerazione dei soggetti coinvoltinella decisione e nella stessa formazione delladecisione. Per quanto riguarda la decisione in quanto tale, laricerca ha delineato una molteplicità di modelliper interpretarla e spiegarla. In sintesi possiamoconsiderare, a seconda di quale approccio e corni-ce teorica scegliamo in merito all’analisi delle poli-tiche, quattro modelli per spiegare un processodecisionale: 1) la decisione interpretata all’internodi una visione sinottica della programmazione; 2)la decisione interpretata all’interno della logicadella scelta razionale; 3) la decisione interpretatacome aggiustamento negoziato; 4) la decisioneintesa all’interno della logica cosiddetta del cestinodei rifiuti (per una presentazione di queste teoriedella decisione si veda: Bobbio, 20036). Ma questi modelli diversi devono essere misuratiin concreto e soprattutto relazionati sia con glistadi e con le circostanze della decisione, sia con lemodalità di implementazione della decisione. Daquesto punto di vista emerge che nell’analisi empi-rica delle politiche pubbliche certamente dalpunto di vista applicativo e normativo convivono esono presenti tutti i modelli indicati, alcuni intesicome descrittivi, altri come prescrittivi. Tuttavia gli
ultimi due modelli sono quelli più interessanti percomprendere l’implementazione delle politichepubbliche a fondo. E vanno considerati comepunto di riferimento, cornici, semmai da ristruttu-rare e su cui fare leva nell’azione politica e dicostruzione di politiche pubbliche di capacitazio-ne, finalizzate, nella logica della democrazia deli-berativa (Pellizzoni, 2005; in termini generali cfr.Held, 2007, pp. 399-440 e Bosetti, Maffettone,2004), a promuovere civismo, partecipazione, avalorizzare le risorse della cittadinanza attiva, adincrementare la forza e la legittimazione delle deci-sioni politiche, innalzando la qualità cognitiva delladecisione e dell’implementazione. È necessario quindi cercare di delineare nel con-creto alcuni soluzioni, tecniche e strumentazioniper la promozione di politiche di capacitazionepolitica. Per prima cosa considereremo il quadrorelativo alle metodologie di ascolto attivo e di pro-gettazione partecipata, tese a migliorare la comu-nicazione politica e pubblica e a costituire meglioil Pubblico, nella sua capacità di indagine sociale einterazione cognitiva. In secondo luogo, ugual-mente in termini generali, faremo riferimento alproblema della gestione del conflitto. Insommaconsideriamo tre passi: come si ascolta, come sicoinvolge e come si gestiscono le interazione, inpresenza di conflitto.
2.4 Metodi e tecniche dell’ascolto attivo. Comeprimo passo si ascolta.
L’ascolto attivo è caratterizzato da alcuni elementifondamentali. Come approccio parte dalla consa-pevolezza che la comunicazione avviene tra sog-gettività che comprendono, elaborano e comuni-cano in base a cornici cognitive. E la comunicazio-ne avviene sullo sfondo si cornici diverse, differen-ziate. Secondo questa premessa, allora, si trattaattraverso un ascolto consapevole di questa situa-zione cognitiva, di essere consapevoli e quindi fareleva sui seguenti dati: 1) si comunica tra sistemicognitivi complessi, 2) in cui le stesse cose hannosignificati differenti, 3) vi sono diverse premesseimplicite e scontate (che rendono quindi, se nongestite, difficile la comunicazione), 4) tutti i puntidi vista hanno delle ragioni, o hanno ragione, 5)

Giovanni Tonella L’analisi delle politiche pubbliche
che le reazioni inattese e le emozioni veicolanonuove conoscenze, 6) che il mondo è pluricultura-le. L’ascolto deve esplorare mondi possibili. Inbase a queste considerazioni si possono derivareuna serie di regole dell’arte di ascoltare: “1) Nonavere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le con-clusioni sono la parte più effimera della ricerca; 2)quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Perriuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambia-re punto di vista; 3) se vuoi comprendere quel cheun altro sta dicendo, devi assumere che ha ragionee chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventidalla sua prospettiva; 4) Le emozioni sono deglistrumenti conoscitivi fondamentali se sai com-prendere il loro linguaggio. Non ti informano sucosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è rela-zionale e analogico; 5) Un buon ascoltatore è unesploratore di mondi possibili. I segnali più impor-tanti per lui sono quelli che si presentano allacoscienza come al tempo stesso trascurabili e fasti-diosi, marginali e irritanti, perché incongruenticon le proprie certezze; 6) Un buon ascoltatoreaccoglie volentieri i paradossi del pensiero e dellacomunicazione interpersonale. Affronta i dissensicome occasioni per esercitarsi in un campo che loappassiona: la gestione creativa dei conflitti; 7) Perdivenire esperto nell’arte di ascoltare devi adottareuna metodologia umoristica. Ma quando hai impa-rato ad ascoltare, l’umorismo viene da sé” (questesette regole dell’arte dell’ascolto sono il fruttodella ricerca etnografica di M. Sclavi: Sclavi, 2003,passim; 2006, p. 201). L’ascolto diventa così più profondo e più predi-sposto a supportare un’azione che ha presente lecaratteriste plurali dei pubblici potenziali e consi-dera la circolazione delle idee produttiva (si tengapresente come questa produttività va colta anchenei processi organizzativa non solo delle pubblicheamministrazioni ma anche nell’impresa: si consi-deri: Crozier, 1990). Il politico come facilitatorequindi deve porsi il problema di come ascoltarepiù a fondo e in maniera più creativa. Di come: 1)comprendere e uscire dalle cornici di cui siamoparte; 2) di come superare gli stereotipi; 3) dicome saper distinguere le possibilità di un campoe come saper porre o favorire una variazione stes-sa di campo – e quindi saper esplorare mondi pos-
sibili, anche a partire dallo sconcerto e dal dis-orientamento (cfr. Sclavi, 2003, pp. 23-114). Se questa è la cornice di partenza, all’interna diessa si possono collocare tutte le metodologie e letecniche dell’indagine sociale che cercano di rica-vare informazioni e idee dai cittadini o che cerca dicomprendere come i cittadini possono pensarla suun determinato problema e che vogliono essereforme di democrazia deliberativa (outreach, cam-minata di quartiere, brainstorming, focus group,tecniche proiettive, sondaggi deliberativi, giurie dicittadini, consensus conferences ecc.) (cfr.Bobbio, 2004, pp. 5-29). Queste metodologie pos-sono essere distinte in misura di che tipo di inclu-sione e selezione fanno dei cittadini (sorteggio,autoselezione, gruppi di rappresentanza, organiz-zazioni, comitati spontanei ecc.), in misura dellaloro trasversabilità e utilizzabilità a seconda deicontesti ed in misura della loro stretta formalizza-zione (che può essere più o meno stringente e rigi-da). Inoltre esse hanno un elemento in comuneoltre al coinvolgimento dei cittadini in termini deli-berativi (più che aggregativi): il ruolo fondamenta-le e professionalizzato dei facilitatori che organiz-zano e implementano tali metodologie quali formedi indagine sociale, empirica, sperimentale e inter-disciplinare.
2.5 Metodi e tecniche della progettazione parteci-pata. Come secondo passo si coinvolge.
Innanzi tutto, specialmente nell’ambito della ricer-ca sociale indirizzata alla progettazione urbana par-tecipata, possiamo identificare nell’outreach unaforma preliminare di ascolto. E si basa su di unprincipio semplicissimo: andare in cerca delle per-sone per ascoltarle. Insomma andare a consultarele persone piuttosto che aspettare che siano esse avenire da noi. L’outreach permette di coinvolgeresoggetti che altre tecniche non consentono dicoinvolgere, specialmente quei soggetti poco pro-pensi o impossibilitati per ragioni di lavoro o ditempo personale o per questioni relative alla per-sonalità o a caratteristiche motorie e cognitive par-ticolari ad entrare nei processi partecipativi.L’outreach implica un lavoro di investigazione e diricerca, in una logica per cui è l’istituzione a cerca-
65

n.22 / 2009
66
re il cittadino. È evidente quanto sia decisivo ilruolo del soggetto che fa la ricerca e che coinvolgeil cittadino. L’outreach utilizza una serie di sup-porti tecnici: dalla distribuzione di materiale infor-mativo con contatto diretto, all’utilizzo di mass-media locali, spot informativi, giornali locali, news-letter, siti istituzionali, ad interventi informativimirati nell’ambito di riunioni di specifici gruppi,dall’utilizzo di strutture mobili all’utilizzo di puntidi riferimento in loco. L’outreach, comunque, èfondamentalmente una raccolta preliminare diinformazioni e di conoscenza ordinaria. Questametodologia può prepara la cosiddetta camminatadi quartiere.Con “camminata di quartiere” si intende una formadi ascolto attivo del territorio, che implica l’andaredi persona tutti insieme nei luoghi ritenuti dagliabitanti più significativi, nel bene e nel male (pro-ducendo una mappa cronotopica delle problema-tiche, delle informazioni e delle osservazioni utili).Ciò produce un rapporto interattivo tra il tecnicoprofessionista ed il cittadino del quartiere inmaniera tale da mirare e produrre una sorta di pia-nificazione democratica in cui: a) vi sia una depro-fessionalizzazione, b) una decentralizzazione, c)una demistificazione, d) una democratizzazione,che io definirei meglio come azione federale o pra-tica federalistica, visto che fa convergere in un otti-ca di governo sia dei governanti che dei governatiparti differenti con saperi e competenze proprie.Nella “camminata di quartiere” e nella dimensioneinterattiva tra cittadini e progettisti possono essereutilizzate tecniche e metodologie di analisi ulterio-ri, ad esempio l’analisi SWOT (ovvero l’analisi chepone in evidenza e ricerca dinamicamente i rischie le opportunità, e staticamente i punti di debo-lezza e quelli di forza) (per un esempio della suaapplicazione si veda: Gasparini, in Pellizzoni, 2007,pp. 335-386).Altra metodologia è quella del cosiddetto“Cantiere evento”. In questo caso tuttavia il gradodi coinvolgimento è molto più basso e ha più chel’obiettivo di coinvolgere i cittadini nella progetta-zione quello di stimolare il senso di appartenenzaai luoghi, l’educazione, la manutenzione, la pre-venzione o la mitigazione dei conflitti e la facilita-zione di un regolare svolgimento dei lavori. Il can-
tiere evento lega alla conduzione del cantiere unaserie di iniziative legate alla informazione in locosul cantiere e quindi sul processo di progettazionee costruzione, l’educazione coinvolgendo i bambi-ni con strumenti di animazione territoriale, labora-tori di progettazione ecc, la formazione per avvia-re al mondo del lavoro disoccupati attraverso unascuola cantiere. Più che di partecipazione in que-sto caso dovremmo parlare di coinvolgimento (cfr.Arnstein, 1969, pp. 216-224: dal grado zero al mas-simo grado: manipolazione, cura, informazione,consultazione, pacificazione, partnerariato, delegadi potere, controllo da parte dei cittadini).Altra tipologia di metodologia è il cosiddetto plan-ning for real (pianificare per davvero). In questocaso ci troviamo di fronte ad una forma di proget-tazione (più che di coinvolgimento). La cittadinan-za è coinvolta nella progettazione, attraverso deigiochi coordinati da uno o più facilitatori che pre-vedono l’utilizzo di materiali facilitanti costituitifondamentalmente da un plastico, ovvero unmodello tridimensionale dell’area su cui si inter-viene e da un pacchetto di suggerimenti (fino a250). Tra la costruzione del plastico e l’interventocon suggerimenti vi deve essere un’opera di infor-mazione e di coinvolgimento dei cittadini inmaniera tale che appunto giocando facciano osser-vazioni e diano suggerimenti in base al materialefacilitante. Si tenga presente che in questa faseintermedia si può anche somministrare questiona-ri. Lungo l’intero processo i facilitatori devonoanche favorire l’interazione tra i cittadini. Il giococontempla anche dei materiali relativi alla prioritàda dare: segnali cioè di priorità temporale. Cosìfacendo il processo si conclude con la definizionidelle priorità tra i suggerimenti e con la definizio-ne delle azioni da fare e dei soggetti atti a farle.
2.6 Il problema della gestione e della risoluzionedei conflitti. Come terzo passo si gestiscono ledinamiche.
Ora il processo decisionale e quello di governointerconnesso hanno la necessità certamente diaffrontare questioni delicate, nodi salienti, proble-mi di non facile risoluzione. Certamente la neutra-lizzazione del conflitto, della polarizzazione, del-

Giovanni Tonella L’analisi delle politiche pubbliche
l’opposizione non è possibile: sono forme conna-turate alla dimensione politica, ineliminabili (cfr.Schmitt, 1972, spec. pp. 89-208; Mouffe, 2007;Schattschneider, 1960, trad. it., 1998. spec. pp. 61-78). Nelle forme di partecipazione affrontate ilruolo del facilitatore è fondamentale, come anchesono fondamentali le competenze sociali e cogniti-ve di coloro che sono coinvolti. In ogni caso, tut-tavia, c’è da tenere in conto l’emersione di conflit-ti o polarizzazioni. Si tratta in questi casi di gestiree risolvere il conflitto. Anche per questa problema-tica si sono sviluppate delle metodologie. Prima fra tutte è la cosiddetta Alternative DisputeResolution che cerca di superare il conflitto evi-tando la negoziazione posizionale e favorendo laconciliazione. La letteratura sulla questione (testiimportanti sono: Fisher, Ury, 1981, trad. it. 1995;Ury, 1991) mette in evidenza alcune strategie fon-damentali atte a favorire o gestire al meglio i con-flitti. Si tratta di strategie ampiamente utilizzate inmolti contesti. Innanzitutto è fondamentale opera-re per mettere a fuoco gli interessi, e non le posi-zioni, ovvero evitare di cristallizzare le posizionicon le loro razionalizzazioni oppositive, per feno-menologicamente far emerge gli interessi retro-stanti, che spesso possono apparire ed esseremeno distanti delle posizioni, mediabili o favoren-ti da posizioni maggiormente mediabili e/ o vicine.Ora per far emergere gli interessi si deve porre unaserie di domande: Quali sono i bisogni, le speran-ze, i timori, i desideri che quella posizione soddi-sfa? Come percepiscono le posizioni e rivendica-zioni dell’altra parte? Come mai le rifiutano e cosaimpedisce loro di accettarle? In che modo sonocoinvolti gli interessi umani basilari? Ora risalireagli interessi conviene perché possiamo aumenta-re le possibilità di posizioni coerenti agli interessie quindi tra di questi individua interessi concilian-ti. Rimanere sulle posizioni è pericoloso, conducea rigidità: si rischia di fissarsi, di dover esserecoerenti, di rimanere fermi alla logica io ho ragio-ne, tu hai torto. Si rischia la rottura, la radicalizza-zione. Oppure si rischia di andare ad un mediocrecompromesso, oppure di dover con grande faticaoperare in maniera controintutiva. Tra l’altro lalogica negoziale tra posizioni rischia di incorrerenelle seguenti problematiche: rimanere fissi su di
un giudizio prematuro, ricercare per forza la rispo-sta giusta, assumere che la torta è quella e non sipuò espandere, considerare i problemi come solodegli altri. L’ideale sarebbe quindi di evitare di infi-larsi in una negoziazione posizionale. Si deve farein modo di far emerge ciò che unisce: l’idea diessere nella stessa barca e non di essere semplice-mente alternativi. Inoltre un ulteriore passo fonda-mentale è quello di evitare le personalizzazioni: sideve separare cioè il problema dal personale, lagente dal problema. Spostare il fuoco su elementioggettivi, non coinvolgere le persone, cercaresoluzioni vantaggiose per tutti e cercare la dimen-sione comune del soggetto che deve risolvere unproblema. L’importante è che in questo processoci sia la capacità di cogliere le premesse implicite,le cornici e di essere in grado di ristrutturarle, tra-mite un cambiamento gestaltico di campo. È deltutto evidente come sia importante una professio-nalizzazione specifica per implementare pratichedi questa natura.
2.7 Conclusione.
Ora l’analisi delle pratiche che abbiamo considera-to ci fa comprendere come esse siano strategie digoverno complesse, che tuttavia intrecciano il pro-blema di lungo corso di come poter far leva sullacittadinanza attiva, su come far leva sulle risorse, esu come rafforzare il capitale sociale e relazionaledella società. Il pubblico, così, in una dimensionedel processo decisionale e dell’indagine più consa-pevole dell’interrelazione e dei limiti cognitiviassume una dimensione regolativa di sviluppiincrementali e di salti di qualità gestaltica in micro-regolazioni. Appare tuttavia fondamentale nonsolo il ruolo facilitatore e regolatore del pubblico,ma anche l’importanza di come la dimensione delgoverno necessita di cooperazione e di atteggia-mento attivo anche da parte dei governati. Infattiessa si esplicita come una a) strategia di recuperorispetto alla caduta di partecipazione che caratte-rizza le democrazie avanzate; b) di allargamentodel consenso o di consolidamento della base par-tecipativa della democrazia; c) e come una leva perl’implementazione amministrativa del comando ingrado di tradurre la protesta in dialogo costruttivo;
67

n.22 / 2009
68
di neutralizzare, cooptare, reclutare la società civi-le e i suoi nodi alla trasmissione di un lavoro diordinazione altrimenti, a volte, impossibile omolto difficile.
Riferimenti bibliografici parte prima
Arnstein S.R., (1969), A Ladder of CitizenParticipation, in “Journal of American Institute ofPlanners, pp. 216-224;Bachrach P., Baratz M., (1970), Power andPoverty: Theory and Practice, Oxford UniversityPress, New York 1970, trad. it. (1986), Le due faccedel potere, Liviana, Padova; Batini F., Capecchi G., (2005) (a cura di),Strumenti di partecipazione. Metodi, giochi e atti-vità per l’empowerment individuale e lo svilupposociale, Erickson; Bobbio L., (2002a), Come smaltire i rifiuti. Unesperimento di democrazia deliberativa, “Stato eMercato”, n. 64, pp. 101-141;Bobbio L., (2002b), I governi locali nelle demo-crazie contemporanee, Laterza, Roma-Bari; Bobbio L., (20036), La democrazia non abita aGordio. Studio sui processi decisionali politico-amministrativi, Milano;Bobbio L., (2004a), (a cura di), A più voci.Amministrazioni pubbliche, imprese, associazio-ni e cittadini nei processi decisionali inclusivi,ESI, Napoli; Bobbio L., (2004b), Le arene deliberative in “RivistaItaliana di Politiche Pubbliche”, pp. 5-29; Bobbio L., (2005), La democrazia deliberativa nellapratica, “Stato e Mercato”, pp. 67-88; Bobbio L., (2007a), (a cura di), Amministrare con icittadini. Viaggio tra le pratiche di partecipazionein Italia, Rubettino, Soveria Mannelli; Bobbio L., (2007b), Tipi di deliberazione, “RivistaItaliana di Scienza Politica”, pp. 359-383; Bobbio N., (19953), Il futuro della democrazia,Einaudi, Torino; Bosetti G., Maffettone S., (2004), (a cura di),Democrazia deliberativa cos’è, Luiss, Roma; Braybrooke D., Lindblom C.E. (1970), A Strategyof Decision. Policy Evaluation as a SocialProcess, The Free Press., New York; Brunner O.-Conze W.-Koselleck R., (1972-1997),
(hrsg. v.), Geschichtliche Grundbegriffe.Historisches Lexicon zur politisch-sozialenSprache in Deutschland, I-VIII, Stuttgart;Capano G., Giuliani M., (2002), Dizionario di poli-tiche pubbliche, Carocci, Roma (spec. le seguentivoci: “Studio delle politiche pubbliche”, “Politica epolitiche”, “Implementazione”, “Politica pubblica”,“Politica distributiva”, “Politica costituente”,“Politica regolativi”, “Politica redistributiva”,“Governo”, “Decisione”); Cassese S., (2002), La crisi dello Stato, Laterza,Roma-Bari;Chatterjee P., (2004), Oltre la cittadinanza. Lapolitica dei governati, Meltemi, Roma; Chignola S., (2008), La politica dei governati,Paper, Paris, 26 maggio, Collège International dePhilosophie; Crosta P.L., (1983), (a cura di), L’urbanistica diparte, Milano; Crosta P.L., (1990a), (a cura di), La produzionesociale del piano, Milano; Crosta P.L., (1990b), La politica del piano, Milano;Crosta P.L., (1998), Politiche, Franco Angeli,Milano;Crozier M., (1992), Stato modesto, Stato moderno.Strategie per un cambiamento diverso, EDS,Roma; Crozier M., (2000), Il fenomeno burocratico. Ilsignificato della burocrazia nelle organizzazionimoderne, Etas Kompass, Milano; Dahl R.A., (2002), Sulla democrazia, Laterza,Roma-Bari; Della Porta D., (1999), La politica locale, IlMulino, Bologna; Dente B., (1989), Politiche pubbliche e pubblicaamministrazione, Maggioli, Rimini; Dente B., (1990), (a cura di), Le politiche pubbli-che in Italia, Il Mulino, Bologna; Dewey J., (1927), The Public and its Problems. AnEssay in Political Inquiry, New York; trad. it.,(1971), Comunità e potere, La Nuova Italia,Firenze;Dewey J., (1938), Logic, the Theory of Inquiry NewYork, trad. it., (1974), Logica: Teoria del-l’indagine, Torino, Einaudi;Dienel P.C., (20025), Die Plannungszelle. DerBürger als Chance, Westdeutscher Verlag,

Giovanni Tonella L’analisi delle politiche pubbliche
Wiesbaden; Donolo C., (2006), (a cura di), Il futuro delle poli-tiche pubbliche, Bruno Mondatori, Milano; Donolo C., Fichera F., (1981), (a cura di), Il gover-no debole. Forme e limiti della razionalità politi-ca, Bari;Duso G., (1993), (a cura di), Il contratto socialenella filosofia politica moderna, Milano; Duso G., (1999a), (a cura di), Il potere. Per la sto-ria della filosofia politica moderna, Carocci,Roma; Duso G., (1999b), La logica del potere. Storia con-cettuale come filosofia politica, Roma-Bari; Duso G., (2003), La rappresentanza politica: gen-esi e crisi del concetto, Franco Angeli, Milano;Duso G., (2004), (a cura di), Oltre la democrazia.Un itinerario attraverso i classici, Carocci, Roma; Duso G., (2006), La democrazia e il problema delgoverno, “Filosofia politica”, XX, n. 3, pp. 367-390;Elazar D.J., (1998), Idee e forme del federalismo,Bruno Mondadori, Milano; Elster J., (2005), Argomentare e negoziare, BrunoMondadori, Milano;Fishkin J.S., (2003), La nostra voce. Opinione pub-blica & democrazia, una proposta, Marsilio,Venezia;Freddi G., (1998), (a cura di), Scienza dell’ammi-nistrazione e politiche pubbliche, Carocci, Roma; Gangemi G., (1994), La questione federalista.Zanardelli, Cattaneo e i cattolici bresciani,Liviana, Padova;Gbikpi B., (2005), Dalla teoria della democraziapartecipativa a quella deliberativa: quali possi-bili continuità?, Stato e Mercato, n. 73, pp. 97-130; Gelli F., (2002), Politica & politiche. Lo studio dicaso? Una domanda di ricerca, Giuffrè, Milano; Gelli F., (2005), (a cura di), La democrazia localetra rappresentanza e partecipazione, FrancoAngeli, Milano; Gualmini E., (2006), L’amministrazione nelledemocrazie contemporanee, Laterza, Roma-Bari;Heclo H., Wildavsky A., (1974), The PrivateGovernment of Public Money. Community andPolicy inside British Politics, MacMillan, London;Held D., (2007), Modelli di democrazia, Il Mulino,Bologna;J.C. Thoenig, (1992), Scienza dell’amministrazio-
ne, Jaca Book, Milano; James W., (1907), Pragmatism, Cambridge Mass.; K.E. Weick, (1997), Senso e significato nell’orga-nizzazione. Alla ricerca delle ambiguità e dellecontraddizioni nei processi organizzativi,Raffaello Cortina, Milano; Kaufmann H., (1981), Fear of Bureaucracy. ARaging Pandemic, “Public AdministrationReview”, 41, n. 1, pp. 1-9;Kosellek R., (1979), Vergangene Zukunft. ZurSemantik geschictlicher Zeiten, Frankfurt amMain, trad. it., (1986), Futuro passato. Per unasemantica dei tempi storici, Il Melangolo, Genova. Lascoumes P., Le Galés P., (20049, (a cura di),Gouverner par les instruments, Paris ;Leoni B., Freedom and the Law (1961) trad. it, Lalibertà e la legge, Liberilibri, Macerata 1994; Lindblom C.E., (1980), The Policy-Making Process,N.J., Prentice-Hall, Englewood Cliffs;Lindblom C.E., (1990). Inquiry and Change. TheTroubled Attempt to Understand and Shape, YaleUniversity Press, New Haven (Conn.); Lindblom C.E., Cohen D.K., (1979), UsableKnowledge. Social Science and Social ProblemSolving, Yale University Press, New Haven (Conn.); Lowi T.J., (1999), La scienza delle politiche, IlMulino, Bologna;March J.G., (1994), A Primer on Decision Making:How Decisions Happen, New York, trad. it. (1998),Prendere decisioni, Il Mulino, Bologna;March J.G., Olsen J.P., (1997), Governare la demo-crazia, Il Mulino, Bologna; Mayntz R., (1982), Sociologia dell’amministrazio-ne pubblica, Il Mulino, Bologna; Meny Y., Thoenjg J.C., (1989), Le politiche pubbli-che, Il Mulino, Bologna; Miglio G., (1988), Le origini della scienza dell’am-ministrazione, in Miglio, Le regolarità della politi-ca. Scritti scelti, raccolti e pubblicati dagli allievi,I, Giuffrè, Milano, pp. 255-324;Moro G., (1998), Il manuale della cittadinanzaattiva, Carocci, Roma; Mouffe C., (2007), Sul politico. Democrazia e rap-presentanza dei conflitti, Bruno Mondatori,Milano; Mozzarelli C., Nespor S., (1981), Giuristi e scienzesociali nell’Italia liberale. Il dibattito sulla scien-
69

n.22 / 2009
70
za dell’amministrazione e l’organizzazione dellostato, Marsilo, Venezia;Osborne D., Gaebler T., (1992), ReinventingGovernment: How the Entrepreneurial Spirit isTrasforming the Public Sector, Addison-Wesley,Reading Mass., trad. it., (1995), Dirigere e gov-ernare, Garzanti, Milano;Pasquino G., (2007), (a cura di), Strumenti dellademocrazia, Il Mulino, Bologna;Pellizzoni L., (2005a), (a cura di), La deliberazionepubblica, Melteni, Roma;Pellizzoni L., (2005b), Cosa significa partecipare,“Rassegna italiana di sociologia”, XLVI, n. 3, pp.479-511; Pellizzoni L., (2007), (a cura di), Democrazia loca-le. Apprendere dall’esperienza, Isig-Dsu, Gorizia; Peters B. Guy., (1991), La pubblica amministra-zione. Un’analisi comparata, Il Mulino, Bologna; Pocock J.G.A , (1972), Politics, Language andTime: Essays on Political Thought and History,London, trad. it. (1990), Politica, linguaggio e sto-ria: scritti scelti, Milano;Pressman J.L., Wildavsky A., (19843),Implementation, University of California Press,Berkeley; Raniolo F., (2002), La partecipazione politica,Bologna;Ravazzi S., (2006), Quando i cittadini decidono,“Rivista Italiana di Politiche Pubbliche”, n. 2, pp.61-89;Regonini G., (1995), (a cura di), Politiche pubbli-che e democrazia, ESI, Napoli; Regonini G., (2001), Capire le Politiche pubbliche,Il Mulino, Bologna; Regonini G., (2005), Paradossi della democraziadeliberativa, “Stato e Mercato”, n. 73, 1, pp. 3-31;Richter M., (1997), Un classico contemporaneo: i“Geschichtliche Grundbegriffe” e il futuro dellaricerca storica, “Filosofia politica” XI, 3, pp. 359-369.Sartori G., (2003), Democrazia. Cosa è, Rizzoli,Milano; Scattola M., (1994), La nascita delle scienze dellostato. August Ludwig Schlözer (1735-1809) e lediscipline politiche del Settecento tedesco, FrancoAngeli, Milano;Schattschneider E. E., (1960), The Semi-Sovereign
People. A Realist’s View of Democracy in America,New York, trad. it., (1998), Il popolo semi-sovrano.Un’interpretazione realistica della democraziain America, Ecig, Genova; Schiera P., (1968), Il cameralismo e l’assolutismotedesco. Dall’Arte di governo alle Scienze delloStato, Giuffrè, Milano; Schmitt C., (1972), Le categorie del politico, IlMulino, Bologna;Schön D. A., (1971), Beyond the Stable State,Norton, New York;Schön D.A., Rein M., (1994), Frame Reflection:Toward the Resolution of Intractable PolicyControversies, Basic Books, New York;Sclavi M., (2003), Arte di ascoltare e mondi possi-bili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte,Bruno Mondatori, Milano;Sclavi M., (2006), Avventure urbane. Progettarecittà con gli abitanti, Eleuthera, Milano; Skinner Q., (2001), Dell’interpretazione, IlMulino, Bologna;Tonella G., (2006), Dalla crisi della rappresen-tanza a nuove forme di legittimazione politica: inuovi strumenti di rendicontazione dell’azioneamministrativa, “Foedus” 15, pp. 59-67. Truini A., (2004), Il vocabolario del Governo loca-le. Considerazioni introduttive, Rivista trimestraledi Scienza dell’Amministrazione, n. 2, , pp. 5-52; Weber M., (1922), Wirtschaft und Gesellschaft,Mohr, Tübingen;Wildavsky A., (1975), Budgeting. A ComparativeTheory of Budgetari Processes, Little Brown,Boston (Mass.), trad. it., (1978), Bilancio e sistemapolitico, Franco Angeli, Milano; Wildavsky A., (1979, 200611), Speaking Truth toPower. The Art and Craft of Policy Analysis,Transaction, New Brunswick, (N.J.)-London; www.abcitta.org; www.atelierlocali.org;www.avventuraurbana.it; www.azionelocale.it.www.cantierianimati.it; www.cittapossibilecomo.org; www.cittapossibile-torino.org; www.ecoazione.it; www.focus-lab.it;www.gruppopalomar.it; www.lacittapossibilefvg.it;www.ombrello.org;

Giovanni Tonella L’analisi delle politiche pubbliche
Riferimenti bibliografici parte seconda
Arnstein S.R., (1969), A Ladder of CitizenParticipation, in “Journal of American Institute ofPlanners, pp. 216-224; Baccetti C., (2008) La nuova politica locale, Utet,Novara;Batini F., Capecchi G., (2005), (a cura di),Strumenti di partecipazione. Metodi, giochi e atti-vità per l’empowerment individuale e lo svilupposociale, Erickson, Trento;Bobbio L., (2004), (a cura di), A più voci.Amministrazioni pubbliche, imprese, associazio-ni e cittadini nei processi decisionali inclusivi,ESI, Napoli; Bobbio L., (2007), Amministrare con i cittadini.Viaggio tra le pratiche di partecipazione inItalia, Rubbettino, Soveria Mannelli; Bobbio L., (20036), La democrazia non abita aGordio. Studio sui processi decisionali politico-amministrativi, Franco Angeli, Milano; Bobbio L., (2004), Le arene deliberative in “RivistaItaliana di Politiche Pubbliche”, 3, pp. 5-29.Bosetti G., Maffettone S., (2004), (a cura di),Democrazia deliberativa cos’è, Luiss, Roma; Cangemi G., (2006), (a cura di), Le elezioni comeprocesso. Nuove tecniche di indagine e nuoviambiti di ricerca, Franco Angeli, Milano;Crosta P.L., (1983), (a cura di), L’urbanistica diparte, Franco Angeli, Milano;Crosta P.L., (1990a4), (a cura di), La produzionesociale del piano, Franco Angeli, Milano;Crosta P.L., (1990b), La politica del piano, FrancoAngeli, Milano; Crosta P.L., (1998), Politiche, Franco Angeli,Milano;Crozier M., (1990), L’impresa in ascolto, Il Sole 24Ore, Milano; Della Porta D., (2007), La politica locale, IlMulino, Bologna;Dewey J., (1927), The Public and its Problems. Anessay in Political Inquiry, New York, trad. it.(1971), Comunità e potere, La Nuova Italia,Firenze;Duso G., (20012), (a cura di), Il potere. Per la storiadella filosofia politica moderna, Carocci, Roma; Duso G., (1999), La logica del potere. Storia con-
cettuale come filosofia politica, Laterza, Roma-Bari;Esposito R., (1999), Categorie dell’impolitico, IlMulino, Bologna; Fisher R., Ury W., (1981), Getting to Yes.Negotiating Agreement without Giving in, NewYork, trad. it. (1995), L’arte del negoziato,Mondadori, Milano;Gasparini A., (2007), Quale compatibilità tra par-tecipazione e buone pratiche? È la Swot analysisun metodo per fondere l’una nelle altre?, inPellizzoni L., (2007), (a cura di), Democrazia loca-le. Apprendere dall’esperienza, ISIG-DSU,Gorizia, pp. 335-386. Held D., (2007), Modelli di democrazia, Il Mulino,Bologna;Moro G., (1998), Il manuale della cittadinanzaattiva, Carocci, Roma;Mouffe C., (2007), Sul politico. Democrazia e rap-presentanza dei conflitti, Bruno Mondatori,Milano;Nussbaum M., (2001), Diventare persone. Donnee universalità dei diritti, Il Mulino, Bologna; Pellizzoni L., (2005), (a cura di), La deliberazionepubblica, Melteni, Roma; Regonini G., (2001), Capire le Politiche pubbliche,Il Mulino, Bologna; Scattola M., (2003), (a cura di), Figure della guer-ra. La riflessione su pace, conflitto e giustizia traMedioevo e prima età moderna, Franco Angeli,Milano;Schattschneider E. E., (1960), The Semi-SovereignPeople. A Realist’s View of Democracy in America,New York, trad. it., (1998), Il popolo semi-sovrano.Un’interpretazione realistica della democraziain America, Ecig, Genova; Schmitt C., (1972), Le categorie del politico, IlMulino, Bologna; Sclavi M., (2003), Arte di ascoltare e mondi possi-bili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte,Bruno Mondatori, Milano; Sclavi M., (2006), Avventure urbane. Progettarecittà con gli abitanti, Eleuthera, Milano; Sebastiani C., (2003), Dal sistema degli statiall’Europa delle città, in P. Messina, a cura di,Sistemi locali e spazio europeo, Carocci, Roma,pp. 35-52;
71

n.22 / 2009
72
Sebastiani C., (2007), La politica delle città, IlMulino, Bologna; Ury W., Fisher, R. (1991), Getting Past No.Negotiating Your Way From a Confrontation toCooperation, New York, trad. it. (2005) L’arte delnegoziato. Per chi vuole ottenere il meglio in una
trattativa ed evitare lo scontro, Corbaccio,Milano; Ury W., (1991), Getting Past No. Negotiating YourWay From a Confrontation to Cooperation, NewYork, 1991.

73
“L’amore e l’arte non abbracciano ciò che èbello, ma ciò che grazie al loro abbracciodiventa bello”.
“Un pensiero è legittimo soltanto sesi ha la sensazione di essersi colti in flagrante pla-gio di se stessi”.Karl Kraus
“Quando disegnate un albero, doveteAvere la sensazione di salire con luiQuando cominciate dal basso”.Henry Matisse
“Denunciare, criticare il mondo? Ma non sidenuncia nulla dall’esterno, bisogna prima abi-tare la forma che si vuole amare o criticare.L’imitazione può risultare sovversiva, molto piùdi tanti discorsi frontali che gesticolano la sov-versione”. N. Bourriaud
PREMESSA
Tutti i caratteri della post-modernità partecipano,direbbe Platone, in questo tardo pomeriggio onto-logico, della dissoluzione, decomposizione e scio-glimento di quanto nel tempo lungo della moder-nità è stato pazientemente tessuto. Il nucleo durodi questo lavoro, più che un tema vuole essere l’incipit preso in prestito da un aforisma di KarlKraus e dalla considerazione che la crisi dellemeta-narrazioni fondative della modernità, che
Lyotard chiama speculative, si manifesta proprio inquesta idea novecentesca – «Ursprung ist das Ziel»– che l’origine sia la meta. (K.KRAUS, 1972).
La meta è da sempre stata concepita come il com-pimento di un processo, nell'idea che l'origine siala meta; ma ora si impone una differente conce-zione: la meta è anche la realizzazione di un altroinizio, di un inizio che non è mai iniziato, che èrimasto realissimo nella sua virtualità.
Tutta la mia argomentazione è vulnerabile e aperta:non chiede soluzioni, esige interrogativi. Come al tempo di Copernico vedevamo abbattersile mura che ostruivano il dialogo tra cielo e terra,oggi vediamo abbattersi quelle che ostruiscono ildialogo tra uomo e natura, tra natura e cultura, dis-integrate da una serie di processi sistemici checome una valanga travolgono ogni dimensione esi-stente.La relazione di separazione tra le discipline che,nel tempo hanno eretto una grande muraglia tra ilsoggetto e l’oggetto e tra loro stesse, ora si infran-gono e precipitando lasciano che le loro compo-nenti si mescolino e i terreni siano invasi e pervasida flussi provenienti da più direzioni senza che iconfini siano più nettamente percepibili. Processi decostruttivi interessano ormai i più dis-parati ambiti del sapere, delle realtà, delle istitu-zioni, dei linguaggi, dei codici, dei comportamentisistemici, delle organizzazioni e ciò non è imputa-bile solo alla crescita esponenziale dei saperi, all’e-voluzione delle nuove tecnologie, al superamento
Santa de Siena
Verso una teoria della creatività
Viaggiando tra le costellazioni del sapere

n.22 / 2009
74
dei confini nazionali tra gli stati, alla planetarizza-zione delle culture, alla mondializzazione. Ma,come direbbe Heidegger, tutto ciò che accade èparte integrante del destino dell’essere, è costituti-vamente il modo d’essere dell’essere. L’esito, inaltri termini, di un processo di lunga durata che hatracciato le linee di questo modello di sviluppodella civiltà umana, di questa forma di razionalità eche oggi, sotto la spinta di insormontabili e insolu-bili contraddizioni, imporrebbe una svolta radicaleall’intero processo evolutivo della storia del piane-ta, spingendo in avanti la storia naturale delle pos-sibilità.Questa mancanza di perimetria, che si sta deli-neando, un tempo i greci lo chiamavano infinito,l’a-peiron anassagoreo, per indicare con esso –contemporaneamente - sia la condizione d’essereimperfetta dell’essere: infinito è di fatto il contra-rio del finito, ritenuto perfetto; sia la sua inenun-ciabilità, in quanto l’assenza di contorni non per-mettere una precisa definizione del tutto. L’idea di un tutto indistinto rinvia all’idea del caos,del disordine, dell’entropia e, perciò, a quella del-l’imperscrutabile, dell’impenetrabile e indistingui-bile, al non soppesabile e classificabile. Poiché dasempre ciò che non è soggetto al vaglio, al giudiziocritico della ragione non può essere oggetto né diconoscenza, né di spiegazione; così l’aleatorio, ilcaso, il diverso, l’irrazionale, la follia, e tutto ciòche non è traducibile razionalmente, sono statiesclusi e rifiutati. Di contro per rendere possibileogni spiegazione fenomenica si è privilegiata la viadella razionalizzazione, che tutto include eavvolge sotto il mantello della sua logica. Logica razionale, principalmente quella aristoteli-ca, che ha finito per dominare l’intera storia dellaciviltà e che a suo modo pensava di aver risolto iconti con quella parmenidea, superando la dicoto-mia tra essere e non-essere. Il principio di identità, di non-contraddizione e delterzo escluso sono stati e sono ancora oggi allabase del pensiero, della struttura cognitiva dellaconoscenza e, dunque, della scienza e di tutto ilmodo di essere e di agire occidentale e non solo.La rivoluzione scientifica moderna ha solo modifi-cato il modo di ricercare le cause, di eliminarequelle superflue dei fenomeni rispetto alla scienza
antica, ma non ha messo in discussione i suoi pre-supposti logici. Presupposti che hanno persevera-to nel delineare la direzione lineare e progressivadei processi, in modo unidirezionale e unilatera-le, salvo qualche rara eccezione, prontamenteinclusa entro lo stesso univoco paradigma.Tutte le dialettiche da Platone a Hegel, inclusaquella negativa della Scuola di Francoforte hannotestimoniato della scelta di una tra queste opzionilogiche, generando di conseguenza la preclusionee l’occultamento dell’altra, delle altre. Ogni filoso-fia che la storia delle idee ha elaborato si è dibat-tuta entro questo schema logico dando vita a para-digmi di pensiero e a teorie estetiche di accetta-zione o rifiuto dell’esistente. Ed è stato lo scontrodialettico tra opposte dicotomie che ha reso pos-sibile lo sviluppo nel senso lineare e progressivoche abbiamo conosciuto, che ha caratterizzato ilnostro modello di sviluppo. E’ mancata, in altri termini, la possibilità di pren-dere in considerazione e quindi di agire un’altralogica in grado di dare vita e significato ad un altropensiero che non solo, ad esempio, includesse ilterzo escluso, ma consentisse meglio di compren-dere ed agire la diversità. Oscillando tra opposti paradigmi non ci si è accor-ti che l’ingiunzione dell’inclusione può essere dan-nosa quanto l’esclusione. Per accedere ad unanuova prospettiva logica più complessa occorreallora concepire la possibilità non solo del terzo,ma anche del quarto, quinto periodico, ecc., siaincluso che escluso. Soltanto l’ampliamento e l’e-spansione delle opzioni logiche può rendere pos-sibile la comprensione della diversità della vita intutta la sua ricchezza, bellezza nella varietà dellesue forme e manifestazioni. Emerge, infatti, in modo sempre più cogente ilbisogno di liberarsi dalle evidenti ristrettezze postedai limiti del pensiero riduttivo umano, affrontan-do il confronto con la logica del vivente, che sot-tende un’altra visione della vita, non intellettualee metafisica, per riconoscere che la biodiversitàevolutiva e creatrice della natura può essere assi-milata a quella della storia delle idee e della civiltàumana, nel complesso di tutte le sue più fecondemanifestazioni, quando essa ha saputo far nascere,nutrire e coltivare le modalità creative e non

75
distruttive della vita. In questa nuova prospettiva epistemologica e logi-ca complessa si inquadrano i numerosi tentativi diridefinire gli antichi ambiti disciplinari e di ricerca,rinunciando alla tentazione delle grandi narra-zioni, come ha detto Lyotard ne suo citatissimoLa condizione postmoderna (1985), e opponendoalle vecchie nuove logiche di pensiero, più capacidi comprendere le sensibilità emergenti e di sod-disfare i nuovi bisogni teorici ed esistenziali, permeglio porci dinanzi alle nuove sfide e alle loroconseguenti ed inedite contraddizioni.Da più parti oggi stanno nascendo nuove ipotesifrutto di teorie e programmi di ricerca che vannosotto il nome di contro: contro l’architettura, idiritti umani, la comunicazione, la politica, l’etica,l’estetica, ecc., volte a sottolineare lo slittamento inatto da un pensiero all’altro, da una logica all’altra,da un paradigma all’altro, assumendo la moderni-tà come punto di non ritorno. Ipotesi nelle quali il contro oppositivo non è sol-tanto e semplicemente il progetto di una nuovadialettica negativa, ma l’espressione semmai delbisogno di affermare l’insostenibilità e non-rifor-mabilità del vecchio ordine di discorso che in ogniambito della conoscenza e delle pratiche di vita,non soltanto si va frantumandosi in mille pezzi edisperdendosi in mille rivoli; ma, soprattutto, per-ché risulta troppo retorico ed ormai insufficientead accogliere la multidimensionalità delle innu-merevoli aperture che si stanno delineando. Se, quindi, il caos è tornato, dal caos non si ci silibera invocando restaurazioni, ma diventando noistessi luoghi di transito, lasciandoci suggestionaree, dunque, attraversare dalle nuove istanze, sensi-bilità, possibilità che sono intrinseche al caloremagmatico del disordine generativo. Cogliendo enon negando interamente le potenzialità creativeche i nuovi linguaggi mettono in gioco e che sonodescrittivi di nuovi scenari, nuovi possibili orizzon-ti di senso; misurandoci e confrontandoci conquanto ancora di inesplorato ed inedito lo spiritoumano è in grado di sfidare. E ancora, non lascian-do mai che le forze nemiche dell’umano e dellanatura prevalgano, ma cercando di coguidare i pro-cessi per rendere sempre più vitale il vitale. La crisi del mondo classico, in questo tardo pome-
riggio ontologico ha avuto inizio con la messa inquestione della moderna e cartesiana scissione trasoggetto e oggetto, con il rifiuto del determinismoe dell’oggettivismo e con l’abbandono dell’idea diprogresso inteso come schema evolutivo lineare einfinito, ma anche con le indagini sull’origine dellavita, sia genetica che estetica. Componenti tutti di un paradigma ormai total-mente insufficiente per dar conto della complessi-tà dei processi, delle interdipendenze e relazionitra e inter-sistemiche. Ciò non vale soltanto perquel che è inerente ai fondamenti teorici e praticidella scienza, ma anche per tutti gli altri pianicome l’arte, la politica, le istituzioni, la comunica-zione, l’ambiente, l’economia, il diritto, e coinvol-ge le basi stesse della convivenza civile, attraversa-ti, come siamo, da processi decostruttivi e percerti versi catastrofici. Processi di liquefazione che qualcuno descrivecome i segni del declino ed altri interpretano,invece, come una grande opportunità per operarequella svolta radicale capace di tracciare unnuovo destino per tutte le specie e per le sorti del-l’intero pianeta.Questo lavoro intende centrare la sua riflessionesull’arte, intesa come una delle più complessedimensioni tra le molteplici dimensioni ontologi-che dell’essere, e tentare di dimostrare, da un latola natura biologica e cognitiva della creazione nelsenso della poiesis quale azione di un soggettoautonomo e dunque come auto-eco-creazione;dall’altro, la impossibilità di continuare a prenderein esame l’estetica in maniera isolata e separatadalle tutte le altre componenti che la rendono pos-sibile, avanzando una prospettiva ecosistemicaesaminata in altri miei lavori e definita ecologica.(DE SIENA, 2002). Partendo dall’idea che, se siripercorre, sin dalle origini, la storia della filosofiadal punto di vista estetico, si può comprenderecome e quanto l’arte, in ogni sua forma e linguag-gio, sia stata considerata una forma altra di saperee come al tempo stesso non sia mai riuscita a libe-rarsi dal senso di colpa di non essere mai stata unavera forma di conoscenza.Ha perciò sempre vissuto e goduto di un’alteritàspeciale, separata, astratta e isolata, connotata -come del resto tutte le diversità - da quella distin-
Santa de Siena Verso la teoria della creatività

n.22 / 2009
76
zione ambigua, che se da un lato l’ha esaltata benoltre e al di sopra perfino della metafisica, dall’altral’ha confinata - molto spesso e volentieri - nelle piùingegnose e, al tempo stesso, raffinate forme diesclusione e discriminazione: disprezzata, amata,esaltata, misconosciuta, esclusa, vituperata, identi-ficata sempre con qualcosa d’altro cui essa rinviache non fosse se stessa.
1. Separazioni
L’intera epistemologia moderna, sin da Telesio,Cartesio, Bacone, Galilei è volta a ricercare meto-dologie o tecniche di conoscenza improntate alprincipio di separazione. Separare ciò che è unitoper meglio analizzare e conoscere è stato alla basedella impostazione metodologica autonomisticadella scienza moderna; con la conseguente costru-zione di un épisteme distinta e individualizzata perogni singola scienza. Questa impostazione haavuto il suo rotondo significato entro un precisoparadigma basato su quello che è sempre statoconsiderato un sacro e imprescindibile valore: ilprincipio individuationis.Ricerca dell’épisteme ed affermazione dell’autono-mia disciplinare costituiscono, quindi, l’approcciofondativo della scienza classica, un approccio chesvela, tutta intera, l’intima relazione tra tecnica escienza e, al contempo, l’essenza tecnica dellaconoscenza. Alla base del metodo di investigazione della cono-scenza c’è sempre stata, quindi, la scissione.Modello che si è riprodotto in tutti gli ambiti delsapere, nelle relazioni umane, tra gli individui e ipopoli, tra individui e individui, tra la mente degliindividui e il loro stesso corpo, tra mappa e terri-torio, tra stato e stato, compresa la più innaturaledelle scissioni quella tra uomo e natura. E’statoquesto il modo d’essere e di manifestarsi del pen-siero e dell’agire umano volto a tagliare, separare,distinguere ogni aspetto della vita e della realtà,senza riuscire a ristabilire poi quelle connessionivitali e a restituirle a nuove relazioni. Infatti, il procedimento di semplificazione ha finitoper costituire non una semplice e temporaneadistinzione, ma una netta e definitiva disgiunzione
tra il tutto e le parti; ciò al fine di istituire una pre-cisa e netta demarcazione, di tracciare i confini, didefinirne le identità, di decidere le appartenenze,di stabilire le proprietà, e tutto ciò non solo permeglio comprendere e conoscere, ma anche perdominare e controllare, secondo il noto teoremabaconiano. L’assunzione del principio analitico di distinzionee categorizzazione, la riduzione dal complesso alsemplice si è rivelata indiscutibilmente importantee proficua per lo sviluppo e l’evoluzione delmondo e della civiltà occidentale a partire daAristotele per giungere fino a Kant; una imposta-zione che continua a permanere egemone ed esi-ziale ancora ai nostri giorni. Il problema è però divedere se quella che si è stata inizialmente unaeccellente strategia cognitiva per la soluzione deiproblemi della conoscenza, e cioè il riduzionismo,non abbia poi finito per diventare il problema stes-so, per effetto della sua assolutizzazione, unicità,universalizzazione e cristallizazione.Inoltre, quel che appare di per se scontato e inevi-tabile, e cioè che all’analisi semplicativa e allascomposizione metodologica, faccia seguito la ri-composizione e la connessione capace di ridaresenso al complesso può, se visto da un’altra pro-spettiva, rivelarsi un gravissimo limite; un limiteche necessita, nel tempo lungo del suo invera-mento, di essere messo in questione per lasciarespazio ad altre aperture possibili.Non è stato così per altre civiltà e culture, comeosserva, ad esempio il sinologo F. Jullien, che haconfrontato il nostro pensiero con lo stile cogniti-vo e le forme del pensiero orientale, dal quale sievince una sostanziale e vitale differenza. Il tutto,l’interezza delle parti, la non-separazione, l’immer-sione in un flusso continuo con la processualitàdella natura, era alla base dell’approccio orientale,fatto soggetto-oggetto di una rigorosa descrizionedella condizione taodica di un essere-al-mondooriginario, che liberato dall’ossessione dello scopoe della felicità e “scrostato da tutte le solide con-trazioni, ostruzioni e restrizioni e dunque resti-tuito alla sua primitiva intensità, è portato al suopieno regime di vitalità” alla sua connessione conil cielo (F. JULLIEN, 2006, p. 49).E’ mancato, quindi, al nostro metodo analitico e

77
scompositivo, il momento compositivo con ilquale e attraverso il quale riconnettere le parti dis-giunte e ridare senso nuovo a quella che si è rive-lata essere e, per certi versi può ancora appariretale, una grande creazione. Una gigantesca emagnifica costruzione che va sotto la denomina-zione di modernità, ma che ha finito per sacrifi-care il suo cuore pulsante, l’aspetto migliore di se,e cioè il principale rapporto tra le relazioni vitali,tra il tutto con le parti. Sempre più appaiono evi-denti gli effetti catastrofici di un precipitato storicoche ha privato le singole parti della realtà, del pen-siero, della società, della conoscenza e, principal-mente degli esseri umani con l’ambiente, delleloro connessione vitali con il tutto, che i greci chia-mavano Oikos. Appare la necessità di collegare, riconnettere, rile-gare, sulla base del principio moriniano di relian-ce, ciò che è distinto, separato, scisso, che oggi staemergendo grazie agli sviluppi di una diversa pro-spettiva antiriduzionistica, globale e complessa,che va oltre la dimensione epistemologica e logi-ca classica per proporsi come una filosofia, che èanche un’etica e un’estetica ecologicizzata dellaconvivenza civile planetaria (E. MORIN, 2005). Il pensiero moderno con Vico e Baumgarten, maprincipalmente con Kant, ha sostenuto uno sforzoenorme per affermare il valore autonomo dell’arterispetto alle altre forme culturali; attraverso il prin-cipio dell’autonomia l’arte e non solo, può sentirsipienamente svincolata da ogni riferimento alleverità, filosofiche, metafisiche o religiose chesiano, e può anche emanciparsi dal dover essere inun necessario rapporto di funzionalità etica opedagogica con gli interessi fondamentali dellasocietà. Così anche l’arte, come ogni disciplina, nelrispetto ortodosso del principio di separazione, hadovuto ri-conoscersi circoscritta nel suo definitoconfine di interesse territoriale, con il suo specifi-co ambito o oggetto, il suo linguaggio, la sua sin-tassi, i suoi canoni alludendo forse, soltanto impli-citamente, a valori altri ai quali pure, inevitabil-mente, si richiamava. Il dibattito teorico, che ha interessato filosofi e stu-diosi di estetica, nel corso di tutto l’ottocento e inbuona parte del novecento, si è misurato sostan-zialmente con questo assunto autonomistico che
ha cambiato completamente, rispetto al passato, laprospettiva dalla quale osservare l’arte, stabilirne ifondamenti teorici ed epistemologici, ridelinearnegli specifici ambiti tematici e problematici.Le preoccupazioni più significative hanno, pertan-to, riguardato il bisogno di stabilire se e in chemodo si potesse parlare di autonomia dell’operad’arte rispetto al contesto storico e culturale d’ori-gine; se e in che modo l’arte potesse anch’essasvolgere, una funzione educativa, etica e sociale. Eancora, se e in che modo l’arte potesse essere unaforma di conoscenza diversa della realtà, sia purecon significati differenti rispetto al passato e rispet-to alle altre discipline, altrettanto autonome.Inoltre, anche l’arte come la filosofia e la scienza, èstata sottoposta ad una indagine speculativa eautoriflessiva circa la sua origine, vista ora comeliricamente intuitiva e sensibile (Croce), ora comelucidamente razionale (Hegel). E’ stata, anche, sot-toposta ad esame per definire se e quale significa-to e valore di verità, se ve ne è alcuno, hanno leopere d’arte. Infine, il suo rapporto con la tecnica,con le tecniche, uno tra i più controversi e con-traddittori problemi, visto che non c’è sostanzial-mente arte che con sia anche tecnica e viceversa,tecnica che non sia in se anche arte. Anzi, comesostiene lo studioso di estetica dei media MarioCosta le tecniche non solo rappresentano un ele-mento accessorio nei processi generativi dell’arte,ma oggi assistiamo semmai alla estetizzazionedelle tecniche (2005). Ma la lunga teoria dei divorzi è molto più estesa edinveste le relazioni tra forma e contenuto, bello e ilpiacevole, individuo e società. Con la prospettivautilitaristica e pragmatica di Dewey, ad esempio, siè voluto sostenere la separazione tra il bello e l’u-tile. Mentre, la prospettiva francofortese, ancorataai processi culturali di massa, si è interrogata sulrapporto tra l’opera d’arte e il pubblico, giungen-do a concepire il dissolvimento del modello staticodell’arte per l’arte (Benjamin). E, infine, ci si èposto l’interrogativo degli interrogativi, ossia sel’arte possa rappresentare una forma superiore, eindubbiamente privilegiata di esperienza, rispettoalla filosofia e alla scienza, oppure – ancora - se ilsuo approccio alla realtà debba essere consideratouna sorta di dorata e singolare diversità.
Santa de Siena Verso la teoria della creatività

n.22 / 2009
78
L’alterno destino dell’estetica è stato, come delresto per tutti gli altri saperi, oggetto di contrad-dittorie e controverse rappresentazioni storiche eteoriche, descrittive di un modo di porre ledomande e di delineare una specifica visione delmondo attraverso l’arte. Ma, con lo sguardo del post e alla distanza, il modoin cui i problemi, che nel corso del tempo sonostati posti, oggi ci appaino come costretti da edentro gli schemi di una logica riduzionistica, infi-ciati da inutili polarità contrapposte, sempre oscil-lanti in rigidi out out, piuttosto che in morbidi e e.Si è trattato di questioni indubbiamente dirimenti,oggi travolte da più profonde riflessioni cheimpongono di allargare la prospettiva estetica nonsoltanto a quella sociale, ma anche storica, econo-mica, etica, religiosa e soprattutto biologica, peracquisire una visone più articolata e complessa.Una prospettiva tesa ad connettere ciò che è dis-giunto, a ecologizzare ogni dimensione, cedendoil passo a ripensamenti più radicali, che impongo-no una ricontestualizzazione e riproblematizza-zione generalizzata capaci di collocare e collega-re le questioni estetiche emergenti, in scenari piùampi ed evoluti. Scenari segnati da processi molte-plici e multidirezionali nei quali l’ambivalenza e lacontraddittorietà non è più lasciata al singolo caso,ma si fa intersistemica e complessa (E. MORIN,1983).
2. Il potere della differenza. La differenza delpotere
L’aver considerato i secoli e i tempi storici del pas-sato in termini di superiorità o di dominio di unaprecisa disciplina, ora della filosofia, ora dellascienza, dell’arte e così via; l’aver privilegiato inogni secolo il tempo di un’ arte o di una scienza:l’epoca della tecnica, il secolo della scienza, iltempo dell’etica, il primato dell’estetica, l’era del-l’economia, ecc.; oppure, l’attitudine a periodizza-re la storia della civiltà umana in termini di prima-ti: il primato della filosofia, della religione, dellascienza, è stato sostanzialmente espressivo dellatendenza ad avere una unica visione dominante egerarchizzante della realtà e della storia naturale
dell’umanità, osservata attraverso le lenti produt-tive di una univoca e assoluta rappresentazione,negatrice e occultatrice delle tante esistenti e mol-teplici e diverse alterità. Poco o niente ancora sappiamo di tante correnti dipensiero, di stili cognitivi, architettonici, scrittura-li, iconici e di rappresentazioni pittoriche e grafi-che, di tecniche e sistemi simbolici, di linguaggi ecodici che dentro e fuori dalla nostra storia sonostati misconosciuti, ignorati, occultati, negati,lasciando che una visione unica si imponesse sututte le altre. Così è sempre stato nel rapporto conle altre culture e civiltà. A tal proposito Rey Chowdenuncia, con la sua critica corrosiva, la tendenzaalle scritture autoreferenziali e di dominio tipi-che della cultura euroamericana che le ha permes-so di parlare sempre a nome del mondo intero. Lastudiosa osserva che mai in oriente ci si sarebbesognati di parlare in termini di totalità senza cono-scere nulla dell’occidente. Mentre l’occidente que-sto lo ha fatto (2007).Non è forse ciò indicativo di un particolare com-portamento cognitivo e di un paradigma teoreti-co ideologico centrato su di una concezione verti-cistica e gerarchizzante della realtà, soppressivadelle differenze e multiformi istanze culturali? Nonè forse la logica di separazione una visione didominio che si è poi estesa ai rapporti con le altreculture e ad ogni forma del sapere fino a compro-mettere le sorti della stessa natura e della sua logi-ca vivente? Una logica partorita dalla razionalitàmaschile sostenitrice della sua indiscussa superio-rità, la quale prevede che sia sempre una l’idea,una la politica, una la fede, una la nazione, una laciviltà, una l’arte, la quale non può che essere vin-cente sulle altre. E’ così prevalso un paradigma di dominio che hafinito per essere esteso all’intero modo di vivere epensare ogni aspetto dell’arte, della storia, dellarealtà, della società, della cultura, dell’economia,della politica, insomma di tutte le diverse forme direlazioni e manifestazioni, materiali e simboliche,comprese quelle tra gli umani, sempre improntateal principio dell’autonomia-separazione e dellapriorità gerarchica.L’occidente ha così ereditato, ma anche estremiz-zato la tendenza ad affermare una concezione

79
individualistica che lascia ben poco spazio adaltri ordini di discorso che non contemplino ildominio, la superiorità, l’eccellenza, la singolarità,la genialità, l’originalità, con tutto il corollario checiò implica. Ciò nonostante è giusto riconoscere che alcuni fle-bili tentativi ci siano anche stati per ri-conciliarealcuni ambiti disciplinari, e non poco è stato fattoper tessere le fila di nuove tessiture, di svilupparenuovi dialoghi, per esempio tra filosofia e fede, traetica ed estetica, tra scienza e filosofia, tra cono-scenza ed esperienza, tra filosofia e tecnica, tra fisi-ca e filosofia, tra biologia e arte, tra arte e natura, trapsicanalisi e politica, ecc.; come si è provato a con-nettere filosofie come platonismo e cristianesimo,hegelismo e marxismo, marxismo e scienza, psica-nalisi ed esistenzialismo. Talvolta negando e talvol-ta affermando ma, sempre, ignorando la comple-mentarità di più punti di vista. Piste di ricerca cheper quanto fossero o apparissero temporaneamen-te feconde, finivano per esaurirsi nel volgere di unao due generazioni di studiosi in attesa di ritrovareun nuovo centro gravitazionale, una nuova pro-spettiva locale e parziale, sempre delimitata e com-pressa entro gli asfittici e angusti confini imposti daun riduzionismo parcellizzante.Ma, oltre alle relazioni tra i diversi ambiti delleconoscenze e dei saperi, la resezione più grandeche è stata fatta sulla base di questa logica, è stataquella che si è rivelata un vero e proprio assassinioculturale e che ha riguardato la separazione traconoscenza e natura: la rottura delle connessionitra i saperi e la vita. La vita nel senso del bios. Inforza della sua natura creativa l’arte, per esem-pio, ha troppo spesso ignorato la creatività dellanatura; non cogliendo in essa la bellezza intrinsecaalle meraviglie della sua biodiversità, si è estra-neata rivendicando il diritto di ricreare mondiancora più ricchi e fantastici. Quasi tutte le teorie e in particolare quelle esteti-che, hanno sofferto di questa scissione. Infatti,neppure il rapporto tra arte è scienza si è sottrat-to a questa logica impietosa; anche il loro è statoper noi, nel corso dei secoli, un rapporto sostan-zialmente di estraneità.Oltre alla ben nota disgiunzione tra scienze natu-rali e scienze umane, tra cultura scientifica e cultu-
ra umanistica il rapporto tra arte e scienza è statoancora più tumultuoso e conflittuale, fatto di con-tinue esclusioni e temporanee inclusioni dal gothadel sapere. Dalle iniziali discriminazioni platonichealle più recenti e autorevoli posizioni filosofichedel novecento, lo iato tra i due mondi è statodominato dal bisogno di affermare un inutile,quanto insignificante escludente primato. Il romanticismo ottocentesco ha dichiarato l’espe-rienza artistica come una esperienza privilegiata,in quanto singolare forma di esplorazione dellarealtà di gran lunga superiore sia alla scienza chealla filosofia. Contrariamente a Kant che ne avevaescluso ogni valenza conoscitiva, i romantici la rite-nevano un organo della filosofia in grado di con-durre l’uomo all’Assoluto. Intendendo l’arte nonuna forma di imitazione della realtà, quanto dicreazione, di produzione di realtà. L’idealismo crociano ha inteso, invece, l’esteticacome scienza dell’espressione linguistica o lingui-stica generale, nella quale l’arte viene descrittacome pura intuizione ed espressione, ben distintada tutte le altre forme di conoscenza, diversasoprattutto dalla logica che privilegia lo stile con-cettuale.Non sono mancati movimenti progressisti e rivolu-zionari che hanno rifiutato tale estetismo, descritti-vo di una presunta supremazia artistica, e riaffer-mato il primato della conoscenza scientifica, cheinclude arte e scienza in un’unica idea, conside-randole entrambe riflessi sociali, cioè prodottidel sistema socio-economico.Così, se per Schopenhauer l’arte è un puro cono-scere nel quale il genio guarda, al di là del mondofenomenico o mondo dell’apparenza, il mondoessenziale e assoluto delle idee; per Marx l’arte,come tutti i prodotti culturali, appartiene allasovrastruttura di ogni organizzazione sociale sto-ricamente determinata. Anche se, egli non mancadi riconosce che l’arte è in grado di determinare innoi, al di là delle condizioni storiche in cui è origi-nata, una forma di piacere e un godimento esteti-co, indipendenti da tali condizionamenti.In antitesi ad ogni intellettualismo filosofico escientifico, ma per una esaltazione estetica dell’esi-stenza, si muovono invece sia Kierkegaard cheNietzsche, la cui riflessione filosofica nel primo è
Santa de Siena Verso la teoria della creatività

n.22 / 2009
80
alimentata e animata dal gusto del pathos, di quel-la passione che liberata dalla ragione scopre il valo-re della verità come paradosso.Ma se per il Nietzsche della Nascita della tragedial’arte è espressione dell’ebbrezza dionisiaca,dello slancio vitale e creativo coinvolgente di tuttele manifestazioni della giovialità e vitalità poetiche.Che unita alla magnifica illusione apollinea, nelrigore armonico e preciso della forma generatricedi bellezza, diventano entrambe costitutive delladimensione essenziale dell’esistenza; nella qualel’uomo non solo partecipa di una comunità supe-riore, ma smette di essere un’artista per divenireesso stesso un opera d’arte. Dalla combinazione dientrambe, infatti, emerge l’opera d’arte, comequalcosa di unico ed incomparabile nella cultura.E la bellezza è, perciò, vista quale libera esplicazio-ne della volontà di vivere e come l’autentico svela-mento della verità capace di squarciare e lacerareogni finzione e apparenza. (F. NIETZSCHE, invece,1978).Per il Nietzsche di Umano troppo umano i tonisono molto più grevi e il destino dell’arte è irrime-diabilmente compromesso dallo spirito razionale escientifico, da quello spirito teoretico e metafisicoche ha distrutto la bellezza creativa del mito, com-presa quella gioiosità dell’imparare dal sogno.Con lo stratagemma della morte di Dio egli annun-cia, così, il definitivo tramonto dell’arte, destinataa divenire, nel mondo moderno, dominato unica-mente dallo spirito apollineo, una magnifica reli-quia, ad essere avvolta e trasfigurata nella magiadella morte. (F. Nietzsche, 1979). Di questo mondo senza Dio progressivamenteintellettualizzato e razionalizzato ne è lucido inter-prete Max Weber che parla di disincatamento delmondo indotto dalla scienza. Ma ciò che rende dif-ferente l’arte dalla scienza è secondo Max Weber eMartin Heidegger, non il dinamismo della lorocreatività che è simile in entrambi, quanto il pro-gresso cui esse danno vita. Mentre, infatti, l’attivitàscientifica è foriera di progresso e pertanto è sog-getta a invecchiamento, l’arte invece non invecchiamai; per essa il progresso non ha senso, non è pro-gressiva, ma comprensiva. L’arte, dunque, nonaccresce il nostro sapere, ci fa solo ampliare ilnostro orizzonte di senso (M. HEIDEGGER, 1968).
Così, mentre l’arte ha accesso al significato pro-fondo, nascosto del mondo e dell’essere, non ècosì per la scienza la quale non è sensibile allaricerca di quel significato; la scienza, infatti, non èun mezzo per giungere a Dio, né alla felicità, né alvero essere, né è in grado di porsi le domande, gliinterrogativi radicali sull’essere dell’essere-nel-mondo. Per i due filosofi tedeschi la rappresenta-zione scientifica ha molto poco a che fare con laverità dell’Essere, poiché riducendo ogni cosa adoggetto, essa può cogliere solo uno dei modi diessere dell’Essere, che rimane nella sua interezzacomunque inattingibile. Da ciò si evince come sotto accusa sia la causaoscurantista, il riduzionismo scientifico che impe-disce di cogliere l’Essere dinanzi alla sua aperturaontologica, in quanto descrittivo, con lo sguardodominante della sua razionalizzazione, proprio diquell’oblio dell’essere di cui ha parlato Heidegger.Sguardo profondo e autentico che invece, secon-do il filosofo, l’arte possiede in quanto soltantocon essa è in gioco tutto l’essere e solo con essa viè la messa in opera della verità. (M.HEIDEGGER,1968, pp.3-69).
3. Ecopoiesis
Che cosa emerge da questa breve e sintetica espo-sizione, che non può essere naturalmente limitataa questi soli esempi? Emerge una visione scissa senon addirittura antagonista, fatta di contrapposi-zione tra scienza e arte, che non può non essereestesa alla gran parte della coscienza filosofica edestetica del novecento, sia pur nella difformità distili, di interpretazioni ed espressioni.Non sempre, infatti, si evince con chiarezza dalgenerico riferimento all’arte a quale tipo di mani-festazione o genere artistico si faccia riferimento epuò riguardare indistintamente tutte le arti: lamusica, la poesia, la tragedia, la pittura. Emerge, inoltre, proprio la mancanza di unadomanda radicale che nel tempo del disincanta-mento del mondo si fa sempre più impellente eineludibile: dinanzi ai mutamenti tumultuosi ecoinvolgenti, alle dinamiche complesse che attra-versano ogni sistema vivente e non, può l’arte

81
con le trasformazioni che l’organizzazione socialeandava sviluppando, proprio con quelle potenzeextra-artistiche, che avevano provocato la perditadella sua antica essenza, inventando nuovi stilicognitivi e linguaggi comunicativi.Non vi è dubbio che la mancata riflessione su que-ste dirimenti questioni abbia notevolmente incisonel generare un fondamentale pessimismo suldestino dell’arte, oltre che un totale fraintendi-mento sul lavoro di apertura che le avanguardieartistiche del novecento e l’ermeneutica in parti-colare, hanno svolto per comprendere quantoandava accadendo. Nel tempo degli dei fuggiti, percepiamo sempre dipiù il bisogno di allargare i nostri orizzonti di sensoed evitare di rinchiudere l’arte entro il cerchio del-l’effimero, della bellezza, della verità, di un mondofatto di astratte e metafisiche essenze, e di rifiuta-re, con Gadamer, ogni riduzione dell’arte a meracoscienza, per guardare non più all’estetica comepensiero dell’arte su se stessa, quanto all’esperien-za dell’arte in quanto tale. Un’esperienza, che nonè mai soltanto artistica, ma nella quale e con laquale si modifica un mondo, cioè si costituisce,heideggerianamente, un mondo attraverso il lin-guaggio poetico. Tesi questa ripresa dall’approccio fenomenologicoelaborato ne La via di mezzo della conoscenza daricercatori come F. Varela, E, Thompson, e E.Roch (1992), con il quale si tenta una riformulazio-ne delle scienze della cognizione a partire dal pre-supposto che la conoscenza non sia una rappre-sentazione del Mondo, ma sia invece costruzionedi sensi, di mondi. Viene così portata, in altri ter-mini, a compimento la tesi circa la natura auto-poietica, della cognizione descrittiva di una nuovascienza della conoscenza che coinvolge tutte letonalità percettive (1992).Con questo non si vuole lasciar supporre che,dinanzi alla crisi di futuro che investe sin nelle radi-ci tutte le forme della nostra società minacciata dauna cultura fortemente appiattita sul presente, l’e-straneazione possa rivelarsi una strategia efficacee risolutiva e l’arte rappresentare il potenziale piùidoneo, come vedremo più avanti con Marcuse. Non è così per Gadamer, per il quale non bisognaosservare l’opera d’arte guardando soltanto a ciò
ancora oggi essere considerata immutabile e con-cepita nella sua universalità, non mutata dai com-plessi e dinamici processi di trasformazione cheinteressano tutte le altre realtà e sistemi? E soprat-tutto, quale rapporto ha oggi l’arte, nelle sue mol-teplici e differenti forme espressive, per esempiocon le tecnologie, con i nuovi linguaggi, con l’eco-nomia di mercato e con l’evoluzione biogenetica ebiotecnologica? Nel tempo della complessità siste-mica le questioni possono ancora essere poste intermini di netto rifiuto e separazione: la vita del-l’arte dalla vita della società, dell’economia, dellaricerca, di vie d’accesso al sapere così diverse, dif-formi e divergenti? Un sapere che è sempre piùsofisticato, specializzato e tecnicizzato? Nell’eradelle tecniche diffuse e della sua infinita e illimita-ta riproducibilità non solo tecnica, ma manipolati-va, trasformativa l’arte può conservare ancora tuttointero il suo valore assiologico, la sua purezza ori-ginaria e il suo portato univoco di significato everità? Anche se Heidegger ha infine riconosciuto che nelcorso del tempo le scienze si sono via via incor-porate nell’arte ”in modo sempre più decisivo oinsieme meno appariscente, in tutte le formedella vita moderna: industria, economia, inse-gnamento, politica, tecniche belliche, pubblicisti-ca di ogni genere”, l’atteggiamento di fondo èstato, come in quasi tutta la filosofia del novecen-to, quello di una rappresentazione dell’arte decisa-mente insidiata, costretta a subire le irrimediabiliperdite della sua essenza e trascendenza a causadel processo di secolarizzazione indotto dallascienza. (M. HEIDEGGER,1976, p. 28). Ha peròdimenticato, come osserva M. Costa, che la stessaincorporazione è avvenuta da parte dell’arte nellascienza e che proprio perché costretta a secolariz-zarsi e a “staccarsi dal “significato” e dalla “tra-scendenza”, l’arte si è interamente posta sotto ilsegno dell’antropologia; chiamata ad abitare nelmondo in un’”epoca senza Dio e senza profeti”,l’”arte si è trasformata in avanguardia artisticao, meglio, in arte sperimentale”(M. COSTA, 1990,p. 10). In altri termini, assumendo pienamente l’hic etnunc della temporaneità l’arte ha ridisegnato lasua funzione e il suo orientamento misurandosi
Santa de Siena Verso la teoria della creatività

n.22 / 2009
82
che determina negli effetti immediati, perché essaè anche storia, storia degli effetti che ha prodottonel tempo e che continuerà a produrne nel tempoa venire. Per questo il filosofo rigetta la tesi kantia-na esposta ne La critica del giudizio, che relegal’esperienza artistica sul piano puramente soggetti-vo e sentimentale privandola di qualsiasi valoreconoscitivo e propone di ripensare il concetto diesperienza in modo più ampio rispetto a come loaveva pensato Kant.Nell’Esperienza dell’arte, afferma H.G. Gadamer,“vediamo attuarsi un’esperienza che modificarealmente chi la fa, e poniamo il problema del-l’essere proprio di ciò che viene in tal modo espe-rito. Così possiamo sperare di comprenderemeglio che verità sia quella che qui ci vieneincontro”( 1986, p 82). Egli guarda all’arte noncome all’unica possibilità di conoscenza vera cheriduce ogni esperienza di verità al suo propriomodello, ma a quell’accrescimento di essere, chein quanto esperienza di verità, l’arte rende possi-bile all’uomo. L’arte, dunque, è conoscenza sullabase dell’apertura ad una molteplicità di irriduci-bili differenze che estendono e pluralizzano ilsignificato di esperienza e la fanno diventare crea-trice d’esperienza.Gadamer ha così operato con l’estetica lo stessosmascheramento che Heidegger ha operato con lametafisica, chiedendo all’arte di non pensare se stes-sa in astratto, ma di esperire la sua verità, impeden-dole di scindere il pensiero dalla realtà di cui essa sinutre. Ne è conseguito uno slittamento dal pianoteoretico al piano artistico radicalmente nuovo,volto a far mutare sia la filosofia che l’estetica.Si incomincia a delineare una nuova estetica che vaoltre la soggettivizzazione ed esige di essere sem-pre più concepita come una storia, una storia distorie, una trama sottile di narrazioni e visioni delmondo, di esplorazioni della verità, che sono -come sostiene l’ermeneutica gadameriana - nellospecchio dell’arte. (H. G. GADAMER, 1986). La convinzione che si fa strada rispetto al problemadella conoscenza è che vada ormai definitivamen-te abbandonata sia la concezione hegeliana dellarisoluzione dell’arte nella filosofia, con la quale sistabiliva il primato di quest’ultima, sia la negazio-ne di ogni valore conoscitivo all’esperienza non
oggettivistica, deterministica e fenomenica.Entrambe espressioni della scissione dei e tra isaperi disciplinari ossessionati dal mito autonomi-stico, dal mancato ri-conoscimento della sostanzia-le incorporazione della scienze e della tecnica nel-l’universo artistico, da un lato e, dalla mancatainclusione dell’oggetto della conoscenza nel sog-getto, dall’altro.L’arte, dunque, non è soltanto questione di piace-re o di godimento estetico, essa va al di là del fattoartistico del bello in sé e riguarda la ricerca, nonsolo della verità, nel senso più ampio del termine,epurata da ogni visione assolutizzante e oggetti-vizzante.Visione che ci consente di cogliere appieno la ric-chezza e la reciprocità delle influenze produttricedi quella circolarità ermeneutica che si è venutaspontaneamente a costituire ed autogenerare trafilosofia, arte e scienza e il complesso dei saperinella loro evoluzione. E senza la quale risulta diffi-cile, se non impossibile, comprendere le profondetrasformazioni che l’insieme dei processi autori-produttivi ed autocreativi si sono andati generan-do e inscrivendo in una più ampia e complessivaevoluzione del gusto, operata da quelle macchinedesideranti quali siamo, e che non riguarda solol’arte, ma più in generale il destino della cultura,della scienza, delle società e, infine, dell’interaumanità. Contribuendo a quella storia naturale cheemerge dalla indissolubile relazione tra l’ambientee il vivente, e che chiamiamo con il nome dicoevoluzione. Poiché quel che non abbiamo ancora appreso avedere è come ogni parte - nel bene e nel male -partecipi e concorra, a proprio modo, alla tessitu-ra della trama della vita il cui disegno non è statoscritto da nessuno ma è semplicemente l’esito diuna spontanea auto-eco-organizzazione nellaquale tutti insieme abbiamo la possibilità di coevol-vere. E dove la generatività, sostiene, a questo pro-posito, S. Manghi “non perviene solo all’autono-mia individuale delle singole parti: autopiesis;ma anche, insieme e inestricabilmente, all’ecolo-gia dell’interazione tra le parti: ecopoiesis (1997,p.101).

83
4. Multidimensionalità negate
Del resto uno straordinario spostamento delpunto di vista che ha provocato un profondo einnovativo cambiamento di prospettiva teorico-pratica è già avvenuto in passato, nel corso di alcu-ne manifestazioni artistiche del novecento, con ilrifiuto, da parte di alcune avanguardie, di quelletendenze realistiche e oggettive espressioni dell’e-stetica positivistica. Una volta tramontata l’ipotesiestetizzante che rivendicava l’arte per l’arte, gliartisti sono ritornati a ripiegarsi intimisticamentesu se stessi, a concentrarsi sul mondo intimo eoscuro del soggetto umano per scoprire la com-plessità della vita interiore, del tempo, posti dinan-zi alle contraddizioni laceranti e insuperabili.Difficile unificare in una sola prospettiva la varietàdei modi e la molteplicità degli stili di questo siapur comune ritorno al soggetto. Le numerose avanguardie artistiche fiorite tra lafine dell’Ottocento e la prima metà del Novecentoaffermano il bisogno di guadare oltre la realtàapparente delle cose, non più per ri-produrla, maper ri-crearla, per poterla trasfigurare in piena eassoluta libertà. Nuove regole tutte interne all’o-pera vengono individuate e imposte nel descrive-re, raffigurare, musicare fatti che si traducono inversi, in narrazioni che si dissolvono in trame direlazioni molto diverse da quelle percepite dallosguardo comune, e ciò proprio per rimarcare ladistanza, e stabilire una differenza tra l’artista e lamassa. Della creazione di nuovi linguaggi pittorici ne sonoun esempio straordinario la dissoluzione dellefigure in geometrie variabili, fatte di cerchi, trian-goli e aggregati di ogni genere, con segni voluta-mente disposti in modo incoerente, attraversati damacche e nubi di colore, da rette, curve e puntiche testimoniano l’impossibilità di racchiudere inun ordine razionale e cosciente tutta la realtà feno-menica, come ha fatto il pittore Kandinskij. L’intento è quello di dimostrare che l’arte è unaforma di comunicazione intersoggettiva che svol-ge la essenziale e primaria funzione di stimolare lacoscienza per far emergere ciò che da soli, indivi-dualmente, non verrebbe mai ad affiorare. Si affer-ma la tendenza a concepire l’arte come trasfigura-
zione della realtà, attraverso l’immaginazione gui-data dall’inconscio, con la quale ci si prefigge loscopo di recuperare una dimensione vera, in con-trasto con quella falsa. La prospettiva della ricercaè tutta rivolta al futuro con la quale si cerca, ri-creando e ri-generando temi, stili, linguaggi eforme, di dare vita ad una nuova realtà più auten-tica, come è accaduto per la pittura di RenéMagritte o per il cinema di Luis Buñuel.Di notevole impatto innovativo è stato il ruolosvolto dalle poetiche sviluppate da tutti quei pro-grammi e manifesti che gli innumerevoli movi-menti artistico-letterari hanno prodotto, o dalleriflessioni fatte dai singoli artisti per spiegare edescrivere il significato della propria arte.Dall’insieme degli spunti, delle suggestioni e delleargomentazioni sono emerse specifiche concezio-ni estetiche, quasi tutte riconducibili ad una fun-zione complessiva dell’arte e delle stesse avan-guardie quale critica e rifiuto dell’esistente. C’è alfondo, sia pur nella diversità delle posizioni, laconsapevolezza di vivere una condizioni di vita e dipensiero dominate dal conformismo mistificante,al quale l’arte vuole opporre la sua resistenza,negando e destituendolo del suo fondamento.Ma, c’è anche, l’impegno ad affermare una nuovavisone della creazione artistica che si pone comedonatrice di senso ad una realtà che ne è priva.Il ruolo più critico e al tempo stesso più innovati-vo è stato svolto dalle avanguardie musicali, comela Dodecafonia, o dalle arti visive comel’Espressionismo, il Futurismo, il Cubismo,l’Astrattismo, il Dadaismo, il Surrealismo esteseanche al cinema e alla letteratura. In quasi tutti imovimenti prevale l’idea di riuscire, attraverso latrasformazione dei modelli e delle tecniche espres-sive, che riflettono i rivolgimenti e i mutamentiepocali, ad affermare l’autosufficienza dell’arte,rivendicando spazi assoluti di azione e rifiutandotalvolta ogni mediazione con la realtà. Emerge inognuno di essi l‘implicita convinzione di riusciread affermare nella dimensione estetica la libertàindividuale dell’artista. Sullo sfondo delle drammatiche tensioni e lacera-zioni del proprio tempo, contrassegnato dal vio-lento ritorno dei regimi totalitari e dal conformi-smo di massa, l’artista rivendica la propria libertà
Santa de Siena Verso la teoria della creatività

n.22 / 2009
84
espressiva e un’umanità smarrita da riconquistare.Ne sono un esempio la tendenza quasi generaliz-zata alla deformazione della realtà e all’esaspera-zione del colore tipica degli espressionisti; ma,anche, l’atteggiamento di rivolta contro un mondopiatto e violento il cui simbolo ed emblema èl’Urlo di Edvard Munch.Ad una rottura degli schemi logico-razionali dellarealtà e della scienza si accompagna la riscopertadella dimensione onirica interiore e il bisogno diestrinsecare l’inconscia immaginazione intesacome la capacità dell’artista di rappresentare realtàpiù vere, rispetto alla vacuità del presente, come èavvenuto nei Surrealisti. In tutti i movimenti d’avanguardia, dunque, daldadaismo alle nuove-avanguardie, dai surrealisti aisituazionisti, da Duchamp ai lettristi, dai concet-tualisti alla body art, dalla land art alla poesia visi-va gli artisti hanno portato alle estreme conse-guenze quel processo di destrutturazione e di dis-soluzione del soggetto, annunciato da Nietzsche esostenuto da Heidegger, Gadamer, Derrida, ecc. Un soggetto privato della sua forte razionalità esoggettività che rinuncia agli assoluti metafisici perfluttuare in un universo di differenze, simbiotica-mente legato al mondo nel quale è venuto a nasce-re, fatto di realtà autentiche ma anche di crudeltàestreme, di sentimenti ed emozioni, ma anche dirazionalità calcolante e tecnologie avanzate. Scienza e tecnica si fa, dunque, destino che insie-me svelano la vera essenza umana; i suoi prodottisi mescolano, si ibridano ad ogni piano e livellodell’esistenza con i prodotti dell’arte provocandola più profonda e radicale trasformazione dellastoria dell’immaginario e dell’estetica.Accresciute da sempre più nuove e sofisticate tec-nologie le arti mutano, si moltiplicano, cambianola loro funzione e destinazione, ma soprattuttomutano gli scenari della comunicazione, delleimmagini, delle spazialità, dei suoni, dei contatti; econ la trasformazione estetica e la creazione dinuovi prodotti artistici, a cambiare è - ancora unavolta - il gusto e le sensibilità. Si intraprendono indagini sempre più specialisti-che, volte ad esplorare la possibilità di produzionedi nuovi significati e significazioni legate alle singo-le tecnologie e alle loro ibridazioni e applicazioni.
Emergono dispositivi tecnologici che permettononuove sperimentazioni artistiche coma la videoart,la Computer-art, il tridimensionale, l’olografia, laFractal Art, l’Arte post-mediale, la Relaction art,ecc.; nuove modalità di fruizione estetica legataall’utilizzo delle nuove tecnologie sempre più inte-grate, vengono ricercate.La pluralizzazione delle arti è veicolo generativodi nuovi equilibri sensoriali che delineano nuoveestetiche, sempre più specialistiche come l’esteti-ca della comunicazione, l’estetica del gusto,dellaluce, del suono, del colore, dei media, ecc. Ne consegue che piuttosto che continuare alamentare la perdita dell’essenza originaria del-l’arte e a tentare di descrivere ciò che l’arte non èpiù, sarebbe giunto forse il momento di iniziare acomprendere ciò che essa incomincia ad essere. Ese, per molti autorevoli critici, la sperimentazionenon è considerata arte nel senso pieno della paro-la, resta l’ingiunzione di cercare di capire che cosaessa sia e che cosa potenzialmente essa possadiventare, da quando le tecno-scienze, che nonsono affatto neutrali, hanno sconvolto la vita del-l’immaginario, le forme della cultura e, di conse-guenza, influenzano e cambiano i modi stessi del-l’esistenza degli umani, quanto quella dell’artista,che non vive in una campana di vetro. Gli artisti della comunicazione, ad esempio, nonsi preoccupano tanto di studiare ed analizzare leforme della comunicazione artistica o di tematiz-zarne i processi, quanto di usare gli strumentidella comunicazione messe a disposizione dallaricerca tecno-scientifica, che vanno dalle reti alvideotelefono, dai satelliti all’elettronica e alla tele-visione, per non parlare di tutte tecnologie appli-cate al corpo, del cyborg e del post-umano, consi-derato sempre di più come un habitat cognitivo esimbolico. Ciò avviene nel riconoscimento dellaimprescindiblità del nesso tecnologie-immaginarioche si sostanzia in più ragioni: sia per sperimenta-re forme nuove di comunicazione e di creazionedi nuovi linguaggi che possono dare vita a nuoveestetiche; sia per azzardare nuove provocazioniattraverso le quali denunciare le potenzialità,anche negative, nascoste; sia per generare luoghinuovi di interazione virtuali e immateriali che sem-pre di più la materialità preclude; sia per allargare

85
e sviluppare spazi inesplorati di comunicazione, discambio, di conoscenza ed anche di mercato, noncontaminati dalle logiche asfittiche e di controllodel potere e del sistema mediatico.L’estetica della comunicazione, secondo M.Costa, non solo ci apre al futuro a-venire, ma ciprepara e istruisce ad esso, essa lavora “per l’abo-lizione della distanza tra tecno-scienza e arte;essa tende a ricavare dalla scienza e dalla tecni-ca delle esperienze di tipo estetico, ciò che vale adun tempo come una estensione della sensibilità edelle sue possibilità di vissuti estetici, e come iltentativo estremo di spiritualizzazione della tec-nica che perde così ogni sua minacciosa terribi-lità” (M. COSTA, 1990, p. 29). Moltiplicazione, estensione, pluralizzazione, ibri-dano i canoni di una diversità artistica diffusa cheattraverso la multimedialità e multidimensionali-tà dei fenomeni artistici getta le basi per una nuovaantropologia, filosofia, etica, politica, economiae che forse stanno incominciando a descrive ancheuna nuova storia delle possibilità.
5. La moltiplicazione dell’aura magica oppu-re l’aura moltiplicata
Per W. Benjamin, come è noto, la rottura della con-tinuità tra l’arte antica e quella moderna è descrit-ta attraverso due criteri, quello della perdita del-l’aura, ossia dell’autenticità e originalità dellaprima, e quello dell’acquisizione della serialità oriproducibilità che caratterizza il prodotto artistico,della seconda, mediante le nuove tecniche diriproduzione che condizionano la produttività arti-stica a venire.Ma che cosa sarebbe dunque esattamente questa“aura” di cui le opere antiche disporrebbero e chela riproducibilità tecnica avrebbe distrutto? PerBenjamin è data dall’hic et nunc dell’opera d’arte,da quel significato misterioso e sacro che tradizio-nalmente sembrava costituirla, da quel precisoluogo in cui si trova nella sua esistenza unica e irri-petibile. La tecnica della riproduzione, pertanto,sottrae il riprodotto all’ambito della tradizione erimanda il suo significato al di là dell’ambito arti-stico. Moltiplicando la riproduzione essa pone al
posto di un evento unico una serie quantitativa dieventi che le fanno perdere la sua autenticità.Definendo la vulnerabilità dell’arte come prodot-to naturale, egli fissa il motivo del distacco tra l’unae l’altra arte e appare chiaro che cosa in realtàdebba ora intendersi per aura o meglio, da checosa scaturisca questa proprietà dell’origine nel-l’opera d’arte: essa scaturirebbe dal suo rapportonon tecnologicamente mediato tra la genesi dellaforma stilistica e la sua coesione con la naturacome forma.Anche Benjamin, dunque, stabilisce una cesuranetta tra l’arte tradizionale e quella moderna (econtemporanea) quando allude ai fenomeni arti-stici del passato che conserverebbero la loro uni-cità rispetto a quelli dell’epoca tecnologica pre-sente che sono, invece, riportati in non-luoghi,riprodotti su scale per altri fini e moltiplicati inmodo esponenziale, paragonabili a repliche e acloni. Secondo questa ben nota prospettiva l’arte,nel contesto contemporaneo perderebbe, dun-que, la sua fondamentale distinzione tra originalee copia. Resta, però, da chiarire e meglio approfondirequeste due concezioni distinte dell’oggetto artisti-co; l’una in cui il rapporto tra manipolazione tec-nica e opera si potrebbe definire naturale e l’altrache essendo mediato da tecnologie, che sarebbedunque artificiale, e il cui rapporto con la naturasi sarebbe irrimediabilmente spezzato. Poiché,questo assunto della modifica radicale del proces-so di creazione artica non può valere per alcunearti, per esempio, per la tecnica fotografica. Moltistorici dell’arte sanno bene, infatti, che nella storiadelle immagini esistono numerosi esempi in cui laconcezione dello spazio viene già prefigurata eanticipata con opere in cui il cosiddetto taglio foto-grafico si palesa evidente ben prima della nascitadella fotografia, anzi secondo alcuni proprio certeleggi prospettiche sono state il frutto di una auto-noma ricerca formale di alcuni artisti, poi successi-vamente assunte e fatte proprie dall’arte fotografi-ca. Noto è l’esempio delle vedute del Canaletto, ol’ordinamento prospettico che mostrano alcunestampe giapponesi. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda il rapportotra opera d’arte e sua riproducibilità o, come
Santa de Siena Verso la teoria della creatività

n.22 / 2009
86
sostiene Benjamin la serialità. In questa concezio-ne opera in Benjamin un pregiudizio di matriceidealistica secondo il quale la creatività sia, in ogniistante della sua manifestazione, ispirazione puracolta nella sua spontanea immediatezza e fruttodella mente singolare del genio. Ma tale principiorisulta difficilmente applicabile in modo generaliz-zato. Per quanto riguarda l’antichità, infatti, si tra-scura un particolare molto rilevante, ossia di comemolta parte dell’arte greca e orientale, sia quellaceramistica greca o cinese, che quella architettoni-ca, si pensi ai templi indiani, fosse anch’essaespressione di infinite riproduzioni seriali, fruttodi arcaismi ripetitivi e ridondanti, di perfetta tecni-ca riproduttiva, di rispetto della tradizione, grazieai quali i capolavori potevano essere stilisticamen-te riconosciuti e apprezzati. E, inoltre, come molteopere possedevano già, in forza della propria capa-cità di istoriare miti e leggende, quel carattere nar-rativo che le sequenze filmiche hanno sviluppatoin seguito nel cinema e in altri generi letterari.Bisogna allora rinunciare alla originalità delladimensione estetica perché questa non è in gradodi dar conto delle trasformazioni dell’arte contem-poranea? Quale è oggi la differenza tra l’arte e lanon-arte? Vi è, di fatto, una impossibilità di distin-guere ciò che può essere considerata un’operad’arte da ciò che non lo è affatto. Si pensi al ready-made di Duchamp, in cui di due oggetti l’uno èconsiderato opera d’arte, mentre l’altro sempliceoggetto d’uso. Secondo alcuni, come ad esempioArthur Danto, il critico d’arte statunitense, la lorodifferenza non è di natura estetica, ma teorica, inquanto vi è un’attribuzione teorica di qualità nondiscernibile. La differenza, in sintesi, non sarebbesensibile, ma è dovuta ad una trasfigurazioneretorica. Trasfigurazione generata dalla complessi-tà del contesto o ambiente, in quanto intornoall’opera d’arte ruota tutto un mondo dell’arte,con la sua affascinante atmosfera, le conoscenzesull’artista, le informazioni sull’oggetto, che larende tale e non già ciò che i sensi realmente per-cepiscono.Questa prospettiva teorica sembrerebbe far scivo-lare l’estetica nuovamente in una risoluzione filo-sofica se non ci aprisse anche ad altre componen-ti, altrettanto importanti, quali quelle del mercato
dell’arte, della comunicazione, del marketing cheoggi sono in grado di movimentare, creare, predi-sporre, dare vita ad ogni dimensione dell’arte tra-sformandola in evento.Si tratta allora di ripensare l’intera prospettiva teo-rico-pratica arricchita dalla teoria delle emozionigenerativa di una nuova sensibilità ecosistemicaespressa in termini post-storici, post-filosofici, post-estetici, e far ripartire il gioco attraverso l’erme-neutica. L’ermeneutica non è né un metodo, né una filoso-fia, ma appunto un’arte: l’arte del comprendere,dell’ascoltare, del creare, del saper vedere le reci-procità tra l’ambiente, il soggetto e l’opera, a par-tire dalla connessione tra soggetto e oggetto, nonpiù distinti e separati, ma in un gioco di relazionicomplesse che coinvolge le emozioni, non piùrelegate al corpo scisso dalla mente, ma nell’unitàdi mente-corpo. Poiché non già la mente scissa dal corpo sente,vede, ascolta, in astratto, ma la mente incarnatain un corpo; un corpo che percepisce nella e conla totalità dei suoi sensi. Non si da alcuna dimen-sione estetica senza sensibilità, senza il sentire, cheè azione di percezione corporea non intellettiva.Allora bisogna ripartire dalla dimensione emotiva ecognitiva per ritrovare l’estetica perduta, dalle sen-sazioni emotive che generano ogni forma di cono-scenza nel e con il corpo. Poiché il corpo risolto inidea è come un corpo senza vita. Se a pensare –scrive U. Galimberti – è solo la res cogitans “ siottiene un corpo quale è concepito dall’intellettoe non quale è vissuto dalla vita, un corpo in ideae non in carne e ossa, un corpo che ha un male enon che sente un dolore, un corpo anatomico enon un soggetto di vita ( 1999, p.130).Il sentire estetico è, dunque, un complesso di emo-zioni percettive che investono la totalità dei sensie della mente, e che si autocreano nell’unità dimente-corpo, nella totalità delle sensazioni emoti-ve sollecitate, stimolate dal contatto con l’opera,con la sua storia, col vissuto esperienziale, che atti-vano processi ricorsivi sempre situati, contestua-lizzati in un ambiente quale è la mente, imple-mentata nel corpo, che insieme dipingono ecolo-gie mentali. La comprensione perciò, secondo il costruttivismo

87
di Goodman che ha parlato di relativismo ontolo-gico, non esiste in un mondo indipendente dalleversioni e dai luoghi, in quanto non esistono pro-prietà intrinseche ai segni, ma è qualcosa che fun-ziona come segno in relazione ad un sistema sim-bolico capace di percepirlo e interpretarlo. (N.GOODMAN, 1985). E un sistema di segni da solonon costituisce nulla se non è interpretato, inquanto è nella interpretazione eco-simbolica edeco-sistemica che si genera la comprensione, nellospecifico la comprensione estetica. Perché comesostiene Wittgenstein un’immagine è un fatto, unfatto che sta per un altro fatto. E non esistono enti-tà o essenze universali indipendenti dai particola-ri sistemi simbolici; tali relazioni simboliche sonoarticolate in termini referenziali entro uno specifi-co ambiente o sistema mentale e cognitivo. In ungioco di continui rimandi e rinvii a relazioni traparola-mondo, nelle quali realtà e finzione sonounite fin dall’inizio. Un gioco che rovescia i notiassunti cartesiani e va oltre la semplice distinzionetra segni naturali e segni convenzionali, poichérinvia ad un complesso processo di funzionamen-to simbolico che è proprio del nostro percepire,dell’essere senzienti.Infatti, per fittizio o per finzione non ci si riferiscenecessariamente a qualcosa di reale, ad un ogget-to; non richiede l’esistenza del designato, ma lapossibilità di significazione del segno indipenden-temente dall’esistenza dell’oggetto. E noi viviamonella società dell’immagine, un mondo ricco disignificazioni, di riferimenti simbolici, di narrazionisenza i quali non ci sarebbe per noi nessuna com-prensione della realtà.Ne consegue, allora, che il problema estetico èanche un problema epistemologico perché rinvia aquello del conoscere e al come conosciamo. Perfar ciò non si può prescindere dagli esiti cui sonogiunte le cosiddette neuroscienze, la linguisticacognitiva, gli studi sulla percezione, nell’esaminarei processi interattivi ed intersistemici che hannoportato alla definizione della mente incorporata,per interrogarsi in termini più generali sulla cono-scenza della conoscenza.Secondo la prospettiva connessionistica delleneuroscienze non cartesiane il contributo delcorpo al cervello non si riduce al sostegno delle
funzioni vitali, ma comprende un contenuto che èparte integrante nel funzionamento della mentenell’elaborazione delle categorie che sono allabase del nostro decidere, agire e comunicare. Inquanto, le rappresentazioni o schemi mentali, chesi autoproducono nel nostro sistema cognitivo,costituiscono la materia dei concetti di base che,attraverso una serie di processi di trasformazione,quali frames, metafore, metonimie, ecc., diventa-no concetti di livello intermedio, che costituisconoa loro volta la materia per ottenere, attraverso imedesimi meccanismi trasformativi, concettiastratti capaci di fornire senso alle unità linguisti-che del lessico del discorso. Questo significa cheper le neuroscienze e per la linguistica cognitiva ilpensiero e il sistema concettuale sul quale essoopera, e senza il quale non si darebbe alcuna rap-presentazione, sono distinti e anteriori al linguag-gio ( G. LAKOFF, 1998).La distanza rispetto agli approcci della tradizioneseparatista è palpabile. Infatti, l’immagine schemafornitaci da Kant da significato ad un cervellointerno visto come una scatola nera che è quelladel cranio, ma che non ha alcuna relazione diret-ta con il mondo esterno, né con il sistema neuro-cognitivo. Sappiamo, invece, che la nostra comu-nicazione con l’esterno avviene attraverso la retenervosa a partire dai terminali sensoriali, anche senon conosciamo i procedimenti con cui la nostraretina traduce gli stimoli esterni nel codice che lirende comprensibili al cervello. E sappiamo ancheche non c’è alcuna efficace possibilità di distinzio-ne sul piano cognitivo, tra la visione, l’allucinazio-ne e la percezione. Poiché ogni percezione ha in séuna componente allucinatoria da cui si genera,si produce spontaneamente, poiesis, una concet-tualizzazione, una rappresentazione traducibile,una metafora. La visione è perciò un processocomplesso di interazione tra stimoli esterni, attivi-tà di impressione, trasmissione, capacità organiz-zative della mente-cervello arricchite e condeter-minate dalla soggettiva sensibilità. Un intreccio di interazioni tra l’ambiente esterno oecosistema e l’ambiente interno o ecosistemamentale emergente dalla differente emotività cor-porea di ogni soggetto. Si tratta di un complessoprocesso di codificazione-traduzione della mente
Santa de Siena Verso la teoria della creatività

n.22 / 2009
88
incarnata che co-organizza le strutture, renden-do intelligibile e coerente la percezione. Dal qualeemerge, come abbiamo visto, un irriducibile rap-porto di codeterminazione tra la mente-cervelloche struttura, connette, produce, computa, agiscee dunque governa il modo di rappresentare leimmagini della realtà. Ma non c’è alcun riflesso oriproduzione coerente e oggettivo tra questeimmagine e la realtà.Ciò che sappiamo è che le nostre sono “visioni”,narrazioni del mondo, sono cioè traduzioni, con-cettualizzazioni, rappresentazioni, astrazioniche attraverso strutture cognitive, frames, mappeconcettuali, schemi d’azione, modelli, concetti,assemblano entità differenziate di informazioni inunità gestaltiche diventando metafore concettuali,categorie radiali, concetti conflittuali, spazi men-tali, da cui si generano teorie, stili cognitivi, idee,sistemi noologici (G. LAKOFF, 1998). E la mentenon è altro che ciò che emerge dall’interazione trail nostro corpo e il suo mondo mentale che è costi-tuito da mappe di mappe, ad infinitum (G. BATE-SON, 1976).Secondo questo approccio, che viene definito conil termine enattivo, dall’inglese enaction termineche corrisponde al significato di generativo, è lamente implementata nel corpo che percepisce,esperisce le emozioni, ed è attraverso le emozioniche avviene l’interpretazione dei simboli linguisticida cui si genera la conoscenza. I simboli veicola-no ciò che nel corpo (unità) crea una ecologiamentale. (F. VARELA, 1997).Il metodo fenomenologico di Francisco Varela pre-vede oltre alla fase riduttiva, con la quale si stabi-lisce una sorta di intimità ed immediatezza con ilfenomeno, un’altra fase quella dell’intuizione.Con la quale si passa a prendere in considerazione,rendendoli virtuali nella nostra mente, una molte-plicità di possibilità e variazioni immaginarie.Sono queste variazioni, infatti, a rendere possibilela capacità di aumentare l’evidenza intuitiva, che laincarnano e modellano, dando così corpo a ciòche sperimentiamo in modo invariante (terzafase). C’è poi il passo successivo, il quarto del pro-cedimento, che è quello della stabilità. Ossia ilmomento in cui si determina un processo di stabi-lizzazione dell’abitudine. Si tratta dell’abitudine
all’esercizio del raddoppiamento riflessivo chenon può che rafforzare nel tempo un’attitudineall’analisi fenomenologia che non è, come dicegiustamente Varela, una semplice introspezione.In quanto non si tratta soltanto dell’atto di unguardarsi dentro, che ripristinerebbe il vecchiodualismo oggettivistico, ma una vera e propriaapertura attraverso la messa tra parentesi o inquestione di un campo di fenomeni, di flussi ener-getici, in cui diventa sempre meno ovvio distin-guere tra soggetto e oggetto. Senza interrompere nessun flusso di pensieri ma,al contrario, cercando di andare alla loro origine ilmetodo fenomenologico tratta la mente e ilmondo fuori di noi non come due entità separatee divise, ma come realtà che si sovrappongonoreciprocamente da cui solo può emergere unascienza cognitiva incarnata, situata o generativa,ed enactiva (F. VARELA, p. 37). Si delinea così una ecologia del senso che ci ponedinanzi all’opera d’arte come ad una molteplicitàdi sentieri, quasi una mappa del mondo, o anchead una porzione di esso. Perché un quadro nonriproduce, ma fa vedere, crea connessione: tieneinsieme.Questo dimostra come non sia più sufficiente laprospettiva classica per rappresentare e raffigura-re, e come abbia ormai fine l’idea sia dell’unicitàprospettica, sia dell’unità dell’osservatore. Unitàprospettica alla quale avevano già rinunciato i cubi-sti e le avanguardie artistiche del novecento, perlasciare il posto ad una molteplicità di punti divista in un trasformato rapporto tra spazio etempo.E non c’è posto neppure per quella formalizzazio-ne contro la quale P. Klee si era già espresso perproporre l’idea di uno sguardo miope attraverso ilquale non guardare un quadro, ma brucare i suoisegni.Per concludere né aura, né serialità possono esse-re alla base di una distinzione tra arte classica earte tecnologica contemporanea, semmai si trattadi esplorare proprio le potenzialità nuove, anchesconvolgenti, che dai nuovi linguaggi e dalla inte-grazione con le tecnologie possono emergere eche forse proprio a Benjamin appaiono esseredotate di una qualche magia particolare: di un

89
“aura” speciale.Intendendo la tecnologia come forma, meglio,come seconda natura, piuttosto che comemedium di un’arte nuova, forse chissà anchedemocratica. Una seconda natura generata nellapercezione dalla forza della tecnologia, come acca-de nel cinema e in tutti gli altri media visuali chepermettono allo spettatore di viaggiare in mondi epianeti sconosciuti, in temporalità inimmaginabilie creare dimensioni di virtualità assoluta, più fortie più intense rispetto al passato, dalle quali vengo-no a nascere appunto nuove ecologie.Non vi è dubbio che nell’epoca degli slittamenti edelle transizioni di codici, come l’ha definita AldoGargani (1995), la ricerca artistica è andata avanti,procedendo per proprio conto, con i suoi proprimezzi e i suoi propri linguaggi, basti pensare adalcuni artisti come Paul Klee e alla sua minuziosaanaliticità astratta; oppure, nel versante dell’e-spressionismo di Jackson Pollock, alla gestualitàmoderna che si incontra con l’attitudine alla medi-tazione degli antichi in un riallacciarsi tra tradizio-ne e attualità. A fronte di simili esperienze l’arteche si rifà alla natura biologica dell’uomo nonappare affatto morta, ma ricca di potenzialità anco-ra inesplorate e a ulteriori e molteplici possibilitàdi rinascita, solo se l’artista non decida di soggia-cere alla meraviglia e allo spavento che la divinitàtecnologica gli incute.
6. La demistificazione sublimata
L’arte è stata presa in esame, nel corso della nostraciviltà di pensiero, da più punti di vista, HelbertMarcuse l’ha esaminata da quello politico, quellopiù rivoluzionario. Per Marcuse, infatti, l’artecostituisce la premessa di una promessa, cioè nonla semplice presa di coscienza, ma la presa dicoscienza eversiva che solo può aprire alla possi-bilità di un futuro migliore.La prospettiva eversiva e trasformativa può essereconcepita, per lui, in due sensi: il primo, intesocome mutamento radicale di tecniche e stile, tipi-co appunto delle avanguardie quando riflettono oaddirittura anticipano mutamenti evolutivi dellarealtà e della società; il secondo, inteso come
denuncia critica di realtà oppressive da parte diforze tese a combatterle e a rappresentarne le assur-de condizioni di destino di singoli o più individui.Ciò ha valore sia per il presente che per il passato,poiché la capacità di rappresentazione dell’arte edelle sue effettive possibilità di sollecitare un rin-novamento radicale, se non di avvertenza o risve-glio delle coscienze, è – secondo Marcuse – unacaratteristica non solo dell’arte contemporanea,ma dell’arte di tutti i tempi, le cui differenze sonoriconducibili soltanto alla diversità delle strutturesociali con le quali ci si confronta. Dipende, in altritermini, solo dal modo in cui il peso dell’oppres-sione è distribuito nella società.In qualsiasi modo tali condizioni storiche e socialisi presentino nell’opera d’arte, sia come sfondo,che come linguaggio, orizzonte o scelta selettiva diimmagini, in ogni caso esse sono, per Marcuse, “lamanifestazione e l’espressione storica specifica diuna medesima essenza metastorica dell’arte: lasua dimensione di verità, d’accusa e di promes-sa” (H. MARCUSE, 1978, p. 15).Per recuperare la funzione sociale critica e positi-va dell’arte, è necessario però, per il francofortese,portare fino in fondo la critica alla civiltà del fintobenessere e dei consumi capitalistica per poterriapprendere a rivalutare, assieme alla sfera deidesideri e dell’Eros, anche quella dell’immagina-zione e della fantasia. Anche per Marcuse, comeper altri critici sociali, l’arte si configura come unosforzo teso a recuperare una dimensione esteticadell’esistenza in contrapposizione a quella mate-riale e commerciale; poiché essa permette di risco-prire l’importanza del suo valore d’uso, di ricerca-re una dimensione ricca di valori ed idealità auten-tici, opposta a quello di scambio, tipico di unasocietà che riduce tutto a merce.Ben diversa è la concezione heideggeriana nellaquale l’arte e, in particolare la poesia, è puramanifestazione dell’Essere (Hegel direbbe delloSpirito), per cui qualsiasi linguaggio è svelamento,manifestazione dell’Essere; pertanto la sua essenzadi verità non è né storica né metastorica, ma èpuramente ontologica.Il rapporto tra l’epoca storica e l’opera d’arte vienequi rovesciato, perché a differenza di ciò che affer-mava il marxismo e lo storicismo, l’arte non riflet-
Santa de Siena Verso la teoria della creatività

n.22 / 2009
90
te un ambiente storicamente determinato, nonesprime l’epoca nella quale ha avuto origine, bensìla costituisce, è lei che la determina attraverso illinguaggio. Non si deve, quindi, guardare all’epo-ca storica nella quale è stata prodotta l’opera d’ar-te per intenderne il suo senso, ma semmai è il con-trario: attraverso l’opera e, in special modo attra-verso il suo linguaggio, si può intendere l’epoca.Quanto, ad esempio, ci ha svelato la DivinaCommedia di Dante Alighieri del medioevo italia-no, dei suoi aspetti sociali, politici, etici, religiosi,simbolici e cosmologici? Che cosa saprebbero glistorici senza il complesso edificio architettonico esimbolico dantesco basato sulla teoria tolemaica?E’ proprio attraverso la poesia e il suo linguaggioche, secondo Heidegger, si può intendere l’epoca,poiché essa ha una portata ontologica. Essa è lamessa in opera della verità, in quanto produceuna nuova struttura d’esperienza, un linguaggio,un nuovo orizzonte di significato. Lo è grazia allasua durata, resa possibile dal linguaggio, soprat-tutto il linguaggio dei poeti. (1978).Prescindendo dal contesto e riprendendo le fila diun discorso politico, per Marcuse, l’opera d’arte èrivoluzionaria non in forza della sua forma sol-tanto, ma della forma data al contenuto. Anche diquel contenuto o realtà costitutiva che apparecome estraneazione e mediazione, poiché la veri-tà dell’arte consiste proprio nel fatto che “ilmondo è realmente così come appare nell’operad’arte”, in altri termini, l’arte crea, genera la verità.E’ essa stessa verità, nel senso che produce realtà,è costruttrice di realtà e, dunque, di senso (1978).Ed è nel contenuto che diventa forma che consisteil suo potenziale politico e, pertanto, essa è rivo-luzionaria in rapporto solo a se stessa. Proprionella sua capacità generatrice di forma che consi-ste, dunque, la sua dimensione estetica. Infatti, sel’arte fosse direttamente prassi o solo politica siridurrebbe quel suo potenziale di estraneamentoe di conseguenza si indebolirebbe la sua forza dirinnovamento radicale.Non vi è dubbio che sullo sfondo di questa teoriauna parte rilevante gioca la concezione, da partedei cosiddetti critici sociali, della funzione svoltadall’arte nel contesto del socialismo reale, entro ilquale essa assume un duplice ruolo: quello di
lasciarsi appiattire sulle posizione del potere domi-nante, facendosi strumentalizzare; e, quello difarsi a sua volta strumento di condizionamento neiconfronti delle masse, le cui menti sono influenza-te e inscritte nell’ecologia cognitiva totalitaria.Ora questa tesi può costituire una premessa indi-spensabile dalla quale prendere le mosse per avvia-re un ripensamento sul ruolo e sulla funzione del-l’arte nel nostro tempo. Un tempo nel quale lariproducibilità ha assunto grandezze e diffusioneincommensurabili rispetto ad altre dimensioni delpassato, ma anche nel quale ogni dimensione,soprattutto quella politica sembra scomparire edissolversi in un pluriverso indistinto e caotico.La tesi estetica di Marcuse ci spinge a concepirel’arte quale idea che prende forma per se stessa;contenuto che si autocrea e autodefinisce inforza della sua capacità creativa, indipendente-mente dal contesto che la genera e soprattutto dalmezzo o dallo strumento o dal linguaggio o dallostile che sceglie per manifestarsi ed autorappre-sentarsi. Arte è perciò, per il filosofo tedesco,autocreazione nel senso della poiesis, del darevita a ciò che prima non era, nell’idea, però, di unautos che si crea da se stesso, cioè dal nulla, sepa-ratamente dall’ambiente. Ora, questa idea di autos appare come una nozio-ne semplice, e non è la stessa idea di autonomiacreativa che ha elaborato il pensiero ecologico, peril quale nulla esiste per se stesso separatamentedal contesto o ambiente; esso non concepisce cipossa essere alcuna autonomia senza al tempostesso la dipendenza; perché nessuna soggettivitàè isolata e slegata dall’ambiente di formazione dalquale riceve il nutrimento alla propria vita, sottoforma di informazioni necessarie alla sua sopravvi-venza biologica, simbolica e cognitiva; quindi, nep-pure l’arte, può esistere senza avere una relazionedi interdipendenza con gli altri sistemi. Questa prospettiva ecologica è molto più com-plessa di quelle espressa dalle estetiche tradiziona-li, perchè non riconosce l’autos separato e distin-to dall’oikos, cioè dall’ambiente, dal contesto dop-piamente inteso sia come sistema biologico inter-no o ecosistema cognitivo, sia inteso come l’insie-me degli ecosistemi sociali esterni, che rendonotutti possibili le condizioni di pensabilità e, quin-

91
di, di creazione dell’idea. In altri termini, non può darsi alcuna produzioneo generazione dell’idea senza che vi sia un sistemaauto-eco-organizzato a tale fine, cioè in grado diprodurla e crearla. L’idea è sempre qualcosa pro-dotta da qualcuno, affermano Maturana e Varela,ove per qualcuno si intende un sistema biologicocognitivo organizzato, interrelato con altri sistemi,sempre situato in uno specifico contesto oambiente che la rende emergente, che rende pos-sibile la sua nascita sotto forma di una nuova orga-nizzazione. (H. MATURANA, F. VARELA, 1995).E in tal senso si può comprendere il significatodell’ auto-eco-organizzazione di cui parla Morin,quando afferma che ogni autos, ogni eco-sistemadeve essere concepito per se stesso, ma nello stes-so tempo deve essere tenuta presente la sua rela-zione; una relazione che è ecologica con gli altriindividui, con la società che lo costituiscono.Pertanto, giacchè l’eco-sistema è organizzazionee produzione di sé, deve anche essere definitocome eco-auto-organizzazione (E. MORIN, 2004,p. 78). Il principio che si fa strada è, dunque, quello auto-generativo delle idee, del loro venire a nascerenel quale la forma è intesa come il modello che ilcontenuto assume nel e attraverso il quale si auto-definisce, si costruisce e crea a partire da qualco-sa che non esiste prima se non nelle condizioni dipotenzialità. L’esempio più calzante è quello pro-posto da Maturana e Varela nel celebre L’Alberodella conoscenza, nel quale si descrive l’immaginedi una molecola all’atto della sua creazione a parti-re da un ambiente nel quale gli elementi chimicisono presenti ma in condizioni informi, separati eindistinti. Solo nel momento in cui si va a costitui-re, in modo spontaneo e autocreativo la membra-na, una sottile linea che perimetra e aggrega glielementi sparsi nello spazio, assumendo una parti-colare forma che viene a nascere e ad originarsila molecola (1995).Come la molecola allora anche l’idea non è altroche la possibilità di aggregazione di elementi noo-logici prima separati e confusi, i quali assumonoquella particolare forma in forza di quella partico-lare organizzazione del sistema che agisce e sicomporta in quel modo in quanto collocato in
quel particolare contesto e in quelle precise con-dizioni di possibilità ambientali e organizzaziona-li. Ogni creazione, come ogni nascita, è dunque unatto generativo, un atto in sé rivoluzionario, inquanto atto che trasforma, plasma la realtà presi-stente.Ogni creazione, infatti, rinvia ad un creatore, ad uninventore che in tutte le narrazioni messianiche èidentificato con Dio. E’ su questa libertà divina, odivina mania, che poeti e filosofi hanno definitola nozione di arte, con le sue forme espressive edinterpretative, stabilendo una equivalenza assolutacon il creatore. Senza le narrazioni poetiche, spe-cie le cosmogonie e mitologie, non ci sarebbe statastoria. “Ogni seria opera d’arte narra la genesidella propria creazione” si legge in un aforismadi Roman Jakobson. Ma perchè – si domanda G. Steiner – rievocandoun vecchio interrogativo di Leibniz, c’è bisognodella creazione, di ciò che prima non è, perché:non c’è il nulla? Tutto il pensiero occidentale,metafisiche, narrazioni mitologiche e scientifiche,religioni, invenzioni, creazioni artistiche, filosofie eteologie, fino al decostruzionismo, sono state unarisposta a questo inquietante interrogativo. Comemai l’occidente ha avuto tanto orrore del vuoto,ed ha avuto un bisogno assoluto di prefigurare ilpieno, di affermare l’essere, di creare e determina-re realtà, in un gioco di differenziazioni e sovrap-posizioni tra creazione e invenzione, nelle qualiogni discorso filosofico diventa musica del pensie-ro, e l’idea un atto di creazione sostitutivo di Dio? Non abbiamo miti o rappresentazioni di divinitànon creatrici, egli afferma, l’intelletto umano nonsi è mai misurato con questa dimensione del non-esordio. E un “Dio sterile che rifiuterebbe, perriprendere l’espressione hegeliana, di negare lanegazione, sarebbe peggio di una sinistra assur-dità: Egli sarebbe un’aporia definitiva, vale adire un non-senso, uno scandalo logico insolubi-le” (G. STEINER, 2003, p. 22). Questo bisogno diimitare Dio, che permane incontrastato, nonostan-te il tentativo heideggeriano di tenere a distanzal’elemento teologico, e che invece Levinas hariproposto segnandone la sua fusione.La teoria marxista ha elaborato la concezione del-l’arte come ideologia di classe. Ma, a ben guardare,
Santa de Siena Verso la teoria della creatività

n.22 / 2009
92
tutte le forme d’arte possono dirsi in un certo qualmodo ideologiche, in quanto ideali auto-produ-zioni: sia perché prodotte da un sistema cognitivocostituiti da schemi logici e mentali strutturatianche da forme ideali interiori (nessuna mente èlibera da schemi e ordini mentali preesitenti); siaperché tutte quelle che Marx ha definito sovra-strutture come la religione, la politica, la cultura,ecc., tendono a cristallizzarsi e ad ossificarsi tra-sformandosi in schemi rigidi di azione.Perciò, andando alla radice del significato di ideo-logia scopriamo l’idea da cui risalire, ancora unavolta, andando alla sua origine, il che ci riportainnanzi l’antico e sempre nuovo interrogativo: dadove nascono le idee? Morin nella sua teoria noo-logica, sostiene che la mente, implementata in uncorpo, dunque nell’unità di mente-corpo, con lasua organizzazione governa, agisce, trasforma, tra-duce, manipola i segni, i simboli. (E. MORIN,1993).Si tratta, dunque, di assumere l’idea che la strut-tura concettuale di ogni persona non è indipen-dente dalla corporeità che la caratterizza; poiché èla persona che la costituisce, che autoproduce eautoorganizza i propri concetti, le proprie rap-presentazioni mentali in relazione non solo a siste-mi simbolici dati, ma anche ai modi propri di sen-tirli, di percepirli emotivamente con il proprio vis-suto corporeo e nel rapporto di questo con l’am-biente. Ci basti pensare all’orecchio assoluto diMozart e alle particolari e specifiche condizioniambientali che ne hanno reso possibile l’espres-sione.La realtà, allora, deve essere vista come l’esito varie-gato e complesso di una colossale e collettiva atti-vità di trasformazione e manipolazione da parte diun numero esorbitante di intelligenze e menti ope-ranti, di sistemi cognitivi e di ecologie mentali, inse-riti in una molteplicità di sistemi di sistemi, ciascu-no dei quali interagisce e concorre, a suo modo,alla creazione dei differenti piani e livelli della pro-duzione culturale, a secondo delle sue possibilità ecapacità, ma anche dei suoi vincoli.
7. L’intelligenza emotiva e creativa
Emerge da ciò una nuova idea di soggetto ecosiste-mico dotato di un’intelligenza multipla e creati-va, che rende giustizia di quella che lo riduceva amero prodotto delle forze materiali di un sistema(economico-capitalistico), in quanto, come sostie-ne Edgar Morin, prodotto-produttore di industriaculturale (E. MORIN, 1963); ma, emerge anche l’i-dea di una nuova realtà ricca, molteplice e com-plessa che perde definitivamente i caratteri dellaunicità, durata, unitarietà, solidità, originalità ecompiutezza, per acquisire quelli della molteplici-tà, temporalità, processualità, fragilità e incer-tezza.Un soggetto non più espressivo di quelle forze sol-tanto materiali, che lo vogliono privo di coscienza,ma un altro soggetto, certamente risultato di mol-teplici forze, antagoniste e complementari, qualiaffettive, sociali, egoistiche, culturali, noologiche,istintive, emotive, economiche e ideologiche cherivalutano proprio quel complesso sovrastruttura-le, ideale e simbolico, quella natura altra, o secon-da natura che egli si autoprodoce, e con la qualeconcorre con gli altri a coprodurre. Una soggetti-vità insieme poetica, razionale, irrazionale, iste-rica, infantile e sensibile insieme, che vive, sente,percepisce, agisce e crea un mondo, nel portato diuna interiorità e immaginazione multiple, plurali,indefinite, ma sempre al tempo stesso eventica,unica, ricca, singolare e plurale, che mette ingioco tutto intero il mondo del suo grande sé: lasua condizione emozionale ed estetica, che èontologica.Ecco allora che possiamo incominciare a vederecome non esista una estestica, una semplice mani-festazione sensibile del sensibile o del razionale odel materiale, né la dimensione di un tempo, diun’epoca per intero, né la creatività espressione diun singolo genio o di una mente assoluta: non esi-steste la dimensione estetica, nella sua unicità eassolutezza, ma una molteplicità di dimensioniche contaminandosi si auto-producono, auto-crea-no, auto-ri-producono e autorigenerano recipro-camente, organizzandosi e ri-organizzandosi lungoi mille piani delle realtà fenomeniche ed espe-rienziale (G. DELEUZE, F. GUATTARI, 2003).

93
Ciò che entra veramente in gioco è l’emotivitàesclusa da tutto il pensiero metafisico occidentaleancor prima di Cartesio fino a Marx, il quale, comeè noto, anch’esso con il suo imperativo estetico,tracciava una netta linea di demarcazione tra labase materiale e quella sovrastrutturale, tra rescogitans e res exstensa, tra razionalità e immagi-nazione, tra razionalità ed emotività.Così facendo l’ideologia di dominio occidentale haoperato in due direzioni opposte, entrambe nega-trici del soggetto: o unicizzandolo e isolandolodagli individui della società, come ha fatto il pen-siero liberale; oppure, dissolvendolo nella coscien-za, in quella più ampia e indistinta qual è lacoscienza (o incoscienza) di classe, come ha fattoin particolare il pensiero marxista. In tal modo,quest’ultimo, ha ridotto proprio quel carattererivoluzionario che era implicito, invece, nella suateoria e che esigeva un soggetto non assoggettato,non atomizzato, ma anzi soggettivato, attivo e ope-rante del cambiamento storico. Rompendo la rela-zione vitale tra coscienza soggettiva ed esistenzasociale, sia la teoria marxista che quella liberale,hanno finito per soggiacere ad un determinismoche ha neutralizzato il contenuto specifico dellacoscienza individuale e con ciò il loro contenutolibertario e rivoluzionario stesso.Etichettando come borghese, l’arte romantica,come anche quella decadente, e con esse ogni sog-gettività espressiva di un’altra visione rispetto aquella realistica, portatrice di altri valori e senti-menti e fantasie, definendola come estraniazionee fuga dalla realtà, il marxismo ha finito con perde-re i contatti sia con la dimensione estetica che conquella politica. Proprio quella dimensione esteticache, secondo Marcuse, si è rivelata la vera via difuga nel tempo orribile dei totalitarismi e tuttequelle forme di socializzazione oppressive, e dun-que anche del socialismo reale, diventando veraforza eversiva e liberatrice (MARCUSE, 1978).Marcuse ha colto sapientemente, nel suo saggio Ladimensione estetica, proprio una nuova concezio-ne del soggetto, della sua soggettività liberatriceche non può darsi, né identificarsi, soltanto in unaunica e collettiva esistenza sociale, ma che sicostituisce a partire da una propria storia interiore,che scaturisce dall’insieme delle trame delle storie
che incontra, che si intrecciano con le vicende per-sonali vissute, con le esperienze provate, genera-trice di quella irriducibile sensibilità che lo rendeunico, poiché uguale e diverso; eventicità esisten-ziali che si intersecano con specifiche passioni, illu-sioni, tensioni, ossessioni, gioie, aspettative e desi-deri che nulla o poco hanno a che fare con la con-dizione di classe, quale essa sia, o che riducendolesoltanto ad essa non sarebbero comprensibili.Indubbiamente, egli afferma, le manifestazioniconcrete della storia degli individui sono determi-nate dalla loro appartenenza ad una classe, “matale appartenenza non è la ragione del lorodestino, delle loro vicende: soprattutto nei suoiaspetti non materiali infatti essa infrange la cor-nice sociale” (MARCUSE, 1978, p. 22-23).
8. Arte senza fine
La tesi di Marcuse si sviluppa dunque entro un asseteorico nel quale l’arte per essere rivoluzionaria edemancipatrice deve contemporaneamente tra-scendere la propria determinazione sociale e altempo stesso conservarne la sua presenza schiac-ciante.Ora, come abbiamo visto con Morin bisogna anda-re oltre ogni determinismo e riconoscere l’artecome il prodotto, ma anche la produttrice di cul-tura, di socialità, di emancipazione, di realtà con-nesse alle inscindibili relazioni tra individuo-spe-cie-società. Perché essa nasce sempre da una real-tà o contesto che la produce, ma nel contempoessa produce nuova realtà (E. MORIN, 1963).L’intero processo di costituzione della realtà mate-riale soggiace, dunque, ad una legge di creativitàoperante, di ricorsività permanente nella qualel’immaginazione, la razionalità e la fantasia si rige-nerano reciprocamente. Anche la condizione diesistenza dell’arte, pertanto, come tutto il vivente,è evolutiva nel senso che essa si evolve ed evol-vendosi trasforma la realtà che la trasforma.Ma, mentre Marcuse vede nell’arte ciò che da vitaal sovvertimento delle coscienze in contrapposi-zione alla realtà soffocante e distorta dalle forze didominio, Morin al contrario coglie con la sua dia-logica ricorsiva non soltanto il suo effetto sulle
Santa de Siena Verso la teoria della creatività

n.22 / 2009
94
coscienze, peraltro sempre imprevedibile e ambi-valente, quanto piuttosto l’interdipendenza e,dunque le sue conseguenze e complicazioni reci-proche, con tutti gli altri sistemi. L’arte cambia ilmodo di percepire la realtà, la sensibilità, la antici-pa, la svaluta, la reifica, partecipa dei grandi pro-cessi che coinvolgono l’economia, la cultura, lasocietà, la tecnica ma anche l’arte è cambiata dal-l’economia, dalla cultura, dalla società, dalla tecni-ca in una evoluzione permanente nella quale ilconfine tra il materiale e il simbolico si intreccianoindissolubilmente. Ora, la tesi che qui si vuole sostenere non è quellase l’arte nel suo complesso, come ogni tipo di pro-duzione artistica nella sua varietà di forme e con-tenuti, sia o non sia più dissenso, se abbia o noperso definitivamente la forza propulsiva del suocarattere ideologico-politico, o se abbia smesso diessere in buona parte rivoluzionaria, quanto diriconoscere che essa è in primo luogo, luogo ditrasformazione: creazione di creazioni.Ne consegue una nuova logica, non più intrinsecaall’opera d’arte stessa, dalla quale può emergereun’altra razionalità, un’altra sensibilità e creatività,che in qualche misura oltrepassa la dimensioneesistente quando si pone come sfida alla razionali-tà calcolante e alla sensibilità incorporata nelle isti-tuzioni e nelle maglie costrittive della culturadominante (H. MARCUSE 1978, p.24). Pertanto,quel che diventa interessante e significativo ècogliere oggi, nel tempo dell’aura moltiplicata,non più il suo effetto eversivo e rivoluzionario, inchiave politica, quanto la sua carica generativa etrasformativa.Con il termine trasformativo si vuole qui alludereal significato al quale rinvia l’antico pensiero cine-se, che va oltre il teorico, lo psicologico e il reli-gioso per fondersi in una aspirazione ideale con ilproprio essere, in quella unione spiritual capace dinutrire la vita. E’ quella condizione di intimità traanima e corpo espressa dall’immagine del falegna-me, il quale prima di creare la sua opera, non sce-glie l’albero, non lo taglia e non illustra alcuna tec-nica, ma ne contempla la sua natura celeste e “Conil cielo (aperto in lui ) egli si unisce al cielo (del-l’albero)”. (F. JULLIEN, 2006, p.53).Così, se per Benjamin l’arte ha perso, nell’epoca
della sua riproducibilità tecnica, la sua aura origi-naria, oggi possiamo dire di aver perduto anche ilsuo carattere ideologico, almeno in quel senso incui lo aveva inteso l’estetica marxista.Ma perde anche quel carattere da cui è stata sem-pre ossessionata, ossia l’originalità. Poiché cam-biando i simboli, cambiano i modi di rappresenta-zione simbolica della realtà; ma contemporanea-mente la realtà muta al mutare delle sue rappre-sentazioni simboliche. Accettare le trasformazionie il mutamento non significa rassegnarsi a ciò cheM. Weber aveva già pre-visto, ossia l’avvento di unepoca senza Dio e senza profeti (1977, p.17), maevolvere le nostre menti alla processualità ecolo-gica del vivente.
9. Oltre l’interpretazione sociologica vsecologica
A Marx spetta il merito di aver teorizzato la naturasociale dell’arte, quale prodotto della strutturaeconomica; una sovrastruttura che, però, ha in séi caratteri dell’astrazione, dell’estraneazione e deldisimpegno borghese quando non assume laforma del realismo.Questa prospettiva verrà rovesciata, in qualchemodo, da Marcuse il quale rende tributo adAdorno e alla sua teoria estetica, rivalutando pro-prio il carattere astratto dell’arte. Infatti, pur con-siderando l’arte come parte integrante della realtàstorica e, quindi, quale importante fattore sociale,per i dialettici negativi proprio in quanto estrania-zione l’arte può negare la realtà stessa; e proprioin quanto contraddizione essa progredisce e siconserva risolvendosi, secondo lo schema hege-liano, dell’Aufhebung, entro la forma estetica. Intal modo soltanto, essa può “portare alla luceuna nuova coscienza e un nuovo sentire”.Pertanto, per Marcuse, nel rapporto tra forma econtenuto non ci sarebbe quella scissione soste-nuta da Marx, in quanto la forma estetica “non sioppone al contenuto, neppure dialetticamente.Nell’opera d’arte la forma diviene contenuto eviceversa” (1978, p. 58).C’è, dunque, in Marcuse ancora la necessità discendere in campo in difesa della forma che solo

95
nell’opera d’arte è tutt’uno con il contenuto. E’nella forma che si sublima il contenuto, la materia.Attraverso la forma si connota l’opera d’arte, laquale privata della sua immediatezza crea un’altrarealtà, in modo qualitativamente diverso.Questa attività trasformativa della coscienza attra-verso l’opera d’arte, Marcuse suppone possa risol-versi nel rovesciamento della stessa realtà o addi-rittura nel suo contrario. Lo dimostra quando conBrecht difende quella che egli stesso definisce latirannia della forma, ossia la necessità di distin-guerla dalla distruzione provocata da processiautodistruttivi dell’arte come la banalizzazione,quella forma d’arte privata di qualcosa di nuovo,fatta di sola tecnica estranea al contenuto, di formasenza materia o di pura tecnica senza contenuto,di vuota autonomia. Questo dibattersi entro questioni rilevanti comeforma e contenuto o autenticità e in autenticità edi quale sia quella produttrice di coscienza criticaelude o non assume appieno l’ipotesi ermeneuti-ca, ossia il problema della interpretazione che èstato, invece, sapientemente posto da Gadamer eDerrida.Anche se non va dimenticato come il pensiero diAdorno sia stato ingiustamente relegato, dal dibat-tito interno alla revisione critica del marxismo,considerando le sue tesi teoretiche soltanto comesfondo delle analisi critiche della società tardo-capitalistica. In un saggio dal titolo Dell’immagineche non deve suturare il vuoto. Sul Mahler diAdorno, V. Cuomo analizza il testo dedicato daAdorno nel 1960 a Gustav Mahler, dandoci un pro-fondo contributo alla sistemazione teorica dei fran-cofortesi. Tale circostanza ha di fatto impedito unserio confronto tra la Scuola di Francoforte e lafilosofia francese degli anni ’60-’70 (Deleuze,Lyotard, Derrida, Foucault), i cui punti di contatto,tuttora inesplorati, possono essere rintracciati nelrischiaramento-Aufklärung (Foucault), nel nessotra dialettica negativa e utopia (Lyotard, Deleuze,Guattari), e, soprattutto, tra la “teoria critica” ador-niana e il decostruzionismo di Derrida (2006).L’istanza ermeneutica è alla base dello slittamentodalla prospettiva sociologica verso quella che oggipossiamo delineare come una ecologia esteticache è la naturale declinazione della teoria bateso-
niana dell’ecologia della mente.(G. BATESON,1974).In questa prospettiva il problema non si pone neitermini se l’arte sia o non sia liberatrice, ma se essaprovoca o non provoca riflessività attraverso l’in-terazione sistemica tra forma e contenuto, sogget-to e oggetto, con l’ambiente inteso nel senso eco-sistemico, in una più significativa e fondamentalerelazione tra arte e natura, ossia tra la creativitàintesa come processo biologico, come poiesis.Da questo complexus di componenti emerge comel’arte non appartenga a se stessa, a qualcosa di avul-so da ogni contesto, quanto sia invece relazionecircolare, e rinvii a quel circolo ermeneutico che siautogenera nell’interscambio tra oggetto, operad’arte, soggetto creatore e interprete con tutto illoro portato di vissuto esistenziale e mentale.Ciò non esclude che si possa parlare di autono-mia, ma inscritto in un processo complesso diinterdipendenze e ricorsività che vede coinvoltee in gioco ogni singola autonomia in una relazionesistemica, nel senso che ogni sistema o compo-nente di esso, quali il testo, il contesto, l’autore el’interprete tutte insieme generano qualità emer-genti che non sono mai la semplice somma delleparti, ma un gioco complesso di differenze e diver-sità, di ritorni e rimandi ogni volta creativi. Il creatore dell’opera è gettato-nel mondo, in unpreciso mondo e in un preciso tempo e la suaopera è la manifestazione del suo essere neltempo della sua esperienza vivente. Egli è, pertan-to il prodotto ma anche il produttore della realtànella quale è immerso, che con la sua sensibilitàcontribuisce a farla percepire in modo diverso, afarla comprendere trasformandola in nuovi oriz-zonti di senso.Ma anche nel fruitore, che parrebbe l’inerte e pas-sivo prodotto culturale dell’opera d’arte, opera lostesso processo auto-eco-produttivo, poiché attra-verso la sua interpretazione egli attiva processiriflessivi e creativi capaci di fare vivere l’opera, dirigenerarla e di comunicarla, concorrendo a farscoprire la grandezza del suo il creatore. Attraverso la fruizione di un’opera, anche quellaprodotta in un tempo e in un’epoca molto distan-te si ha lo svelamento dell’essere, in quanto fruiresignifica, costituire per sé un mondo, non sempli-
Santa de Siena Verso la teoria della creatività

n.22 / 2009
96
cemente riceverlo o rappresentarlo dentro di sè.Eseguire un testo musicale o rappresentare una tra-gedia vuol dire non soltanto fruirne il pathos, gode-re della sua creazione; apprezzarla, gustarla o ese-guirla, significa anche re-interpretarla, ri-metterla ingioco e farla rivivere nuovamente ogni volta, arric-chendola con lo sguardo e il gusto del propriotempo. Ciò non riduce, ma accresce e moltiplica isignificati, producendo uno sdoppiamento disenso sia sul piano della temporalità, la distanza,che sul piano della sensibilità. Poiché è evidenteche nell’ascolto dell’opera, dinanzi alla sua presen-za, ci si estranea da sè si prendono le distanze, perpoterla svelare nella essenza più propria, nella suapresenza, per poi ricondurla a sé, in un caleidosco-pio di giochi di prospettive e connessioni che siautoproducono nella mente, ma per farvi ritorno inmodo autonomo e autopoietico.Da ciò ne consegue che una volta creata, l’operanon appartenga più all’autore e non dipenda piùsoltanto dal contesto che l’ha originata, come nonappartiene neppure al fruitore una volta per tutte,ma - come osserva J. Derrida – ogni volta che essaviene ri-vista, ri-ascoltata, ri-letta e fruita, essa vienere-interpretata nuovamente, dunque ri-creata e ri-scritta (J. DERRIDA, 1971).Poiché il testo scritto è un ordito complesso, è unatela, la cui trama dissimula la tessitura. Un tessutoche rinasce, rivive e si ricrea ad ogni apparizione,ad ogni nuova lettura. Così sempre nuove, inattesee preziose sfumature emergono in un gioco erme-neutico infinito di imprevedibili emozioni cheaprono ad indizi, impressioni, intimi frattali. Leggere significa avviare questo processo circola-re, significa aprirsi alla pre-comprensione di mondisconosciuti, inesplorati; significa iniziare ogni voltaun’avventura che ci coinvolge e ci svela allo stessotempo, che ridisegna i nostri paesaggi mentali, inostri orizzonti di senso.C’è, dunque, una sorta di autonomia nella dipen-denza tra più momenti e soggettività dal cuiintreccio eco-logico si auto-producono quei lega-mi e quelle connessioni vitali che rendono qualsia-si opera non un immutabile archetipo, ma un’ope-ra vivente.In questa prospettiva acquista un senso diverso lateoria di Adorno che, invece, sostiene con l’auto-
nomia dell’arte il primato dell’oggetto. Ne LaTeoria estetica l’oggetto dell’arte, egli afferma, “ èla creazione da lei prodotta, che tanto contienein sé gli elementi della realtà empirica, quanto lisposta, li scioglie, li ricostruisce secondo la pro-pria legge. Unicamente attraverso tale trasforma-zione, non attraverso la fotografia, che in ognicaso è sempre falsificante, essa dà alla realtàempirica ciò che le spetta, l’epifania della suaassenza nascosta e il meritato orrore di essa,negazione dell’essenza. Il primato della realtàempirica ciò che le spetta, l’epifania della suaessenza nascosta dell’oggetto si afferma estetica-mente soltanto nel carattere che l’arte ha di esse-re storiografia inconscia, anamnesi di ciò che èstato sconfitto, rimosso, e che forse è possibile. Ilprimato dell’oggetto, come potenziale libertà diciò che è dal dominio, si manifesta nell’arte comelibertà di questa dagli oggetti” (T.W. ADORNO,1975, p. 364). Da queste affermazioni si evince una sorta di ridu-zione dell’arte a processo di sublimazione linearedi una dialettica negativa che va dal concreto all’a-stratto e che riconosce il primato dell’oggettosenza un soggetto. Tutto cambia se al posto della dialettica progressi-va si assume, invece, la dialogica ricorsa; in quan-to non solo si acquisisce un’altra prospettiva, maa cambiare è la stessa concezione della razionali-tà e della sensibilità non più semplici e lineari, macomplesse. Spingendo sempre più in avanti il processo di ri-pensamento critico delle categorie estetichemoderne si assiste alla mancanza di tenuta deiprincipali assiomi o canoni entro cui quella teoriasi teneva assieme. Questo non vuol dire che gio-cando a spostare lo sguardo, si demolisca tutto.Non crolla ad esempio, il mito della coerenzaintrinseca all’opera che deve indubbiamente sotto-stare al rigore della forma che la definisce tale, invirtù della sua organizzazione sistemica; ma crolla-no, invece, una serie di fissità canoniche, come adesempio, il canone della proibizione del brutto, ose volgiamo quello della polarità assonanza-disso-nanza, poiché estetico non è soltanto equilibrio earmonia, nè il bello dell’arte.Secondo la nota teoria hegeliana, infatti, la bellez-

97
za non inerisce solo all’equilibrio, cioè soltanto alrisultato, ma sempre e contemporaneamenteanche alla tensione, cui il risultato consegue; l’ar-monia che rinnega la tensione diventa elemento didisturbo, cioè falso e se si vuole dissonante.Ora tutti questi assunti teorici perdono la loroforza oppositiva e si liquidano le categorie esteti-che se il tutto è inserito in un quadro epistemicopiù articolato e complesso che assuma come unnuovo valore l’intrinseca ambivalenza cui sotten-de ogni realtà, e in particolare quella estetica, ogniidea, ogni senso non più visto in modo univoco eunilaterale, ma ecologizzato.
10. Altre estetiche
Nell’era del virtuale, dell’immateriale, della bitcomunication, della tele e video-scrittura, dellesculture viventi, dell’aura moltiplicata, della dis-soluzione della sensibilità tradizionalmente intesa,nel tempo delle emotività nascoste, dell’afasiaemotiva, come la definisce U. Galimberti ( 2007),del gusto differito, simulato, mediato, personaliz-zato, mescolato, ibridato, contaminato, perduto,ipersofisticato e uniformato nelle tonalità, neisapori e negli odori; nella post-modernità delle tra-sformazioni percettive, delle metamorfosi corpo-ree, del corpo tecnologico (P. CAPUCCI,1994), neltempo della manipolazione tecnologica, biogeneti-ca, biotecnologia, dell’ hi-tech, del cyborg (D. J.HARAWAY, 1991), della società dello spettacolo(G. DEBORD, 2002), della comunicazione senzainformazione (C. PERNIOLA, 2004), dell’amoreliquido (Z. BAUMAN, 2006), dei diritti senza diritti(S. ZIZEC, 2005), in cui tutto è informe, fuori squa-dro e fuori misura non può non porsi l’interrogati-vo se abbia ancora senso parlare di una e non dipiù dimensioni estetiche. Se non sia ormai giuntoil momento di smettere di ricondurre tutte le artiad una stessa visione estetica, di considerarle inmodo univoco e di tentare di fare uno sforzo perpluralizzarle, apprendendo ad evolvere il gusto,il piacevole, il bello, la differenza, la sensibilità, eparlare, come accade per le intelligenze, di sensi-bilità multiple, di molteplicità di significazioni,nella differenza non solo dei generi, delle tecniche
e dei linguaggi, ma anche di quelle stesse, ma neidiversi luoghi e contesti, negli spostamenti tempo-rali e spaziali che costituiscono le nostre infiniteecologie cognitive e creative, ciascuna con il pro-prio portato di libertà e umanità, ma anche didipendenze e dominio.Non si può negare una sorta di relativismo poichè,in tutti i tempi, ciò che ha avuto valore e significa-to estetico in una civiltà, in un popolo, poteva nonaverlo per altre; da sempre nei tempi lunghi dellaevoluzione della specie, il distacco generazionaleha cambiato il modo di percepire e valorizzare l’ar-te del passato, perché allora pretenderlo oggi pro-prio nell’epoca della mondializzazione, nellaquale tutto ciò che si può tradurre in un bit è tra-smissibile? E ancora, come si può pensare chenella società planetaria e dei consumi il consumodell’arte si sottragga alle dure leggi del mercato edella produzione? Bisognerebbe meravigliarsi sem-mai se non lo fosse; in quanto l’arte è in primoluogo al servizio di questa società consumistica, eal tempo stesso, essa si serve di essa e della suaorganizzazione.Più che invocare epoche d’oro nelle quali l’arte eraal servizio soltanto della verità e non già anchedella menzogna, occorre, invece, riconoscere lemultidimensionalità, le polisemanticità e polisemi-cità emergenti dall’incontro tra più dimensionicostituite dall’estensione e applicazione delle tec-niche e dei linguaggi, dall’incrocio tra differenticulture, epoche, per concepire sensibilità altre,che si accrescono ed espandono attraverso unainterconnessione tra diversi saperi prima distanti edistinti, con nuove derive e ibridazioni, mescolan-ze, intrecci e contaminazioni in un melting potche si accresce e si arricchisce nella relazione siste-mica con la varietà delle menti, con gli ambientimentali e cognitivi dei viventi. Riconoscerne latemporalità e al tempo stesso la transitorietà, ditutte le dimensioni umane ed esistenti, compren-sive di tutte di quelle condizioni di turbolenza edeventicità che sole possono creare quel brodo dicoltura dal quale dalla vita nasca la vita. Poiché la creazione, ogni creazione naturale,vuole la differenza, lo spreco, l’incontro e lo scon-tro, ma anche la congiunzione, la connessione, ilegami, la relazione, la libertà; libertà di sperimen-
Santa de Siena Verso la teoria della creatività

n.22 / 2009
98
tare, di cercare, esplorare, fallire, creare e ri-creare.Tentare, insomma, di comprendere se dal caosdelle suggestioni, dal fragore e dal rumore, daldeficit emozionale, che caratterizza la varietà dellanostra dimensione esistenziale, non possa aprirsi anoi un orizzonte scenico talmente inedito e anco-ra inimmaginabile che ci ponga di fronte all’altret-tanta inedita occasione di ripensare e ridefiniretutte le nostre categorie, comprese quelle esteti-che, dalle quali possa venire-a-nascere una formanuova di umanità, un altro modello di sviluppo econ essi un’altra storia possibile. Poiché anche dall’esperienza tragica dell’orrore edegli orrori del passato può generarsi il bello, inte-so come bellezza d’animo, come apertura e ascol-to dell’altro. Per altro si può intendere la prossi-mità di cui ha parlato Levinas, ma anche di tuttoquell’altro che la logica della separazione ha esclu-so, omesso, negato, distrutto: la natura, il prossi-mo, la corporeità, il diverso, ecc.; un’alterità inte-sa come una nuova relazione vitale tra l’umano eil naturale per scoprire, dopo gli eventi tragici delpassato un’altra etica, che è anche una nuova este-tica della convivenza. Il destino dell’arte è, dunque, ambiguo e ambiva-lente proprio come tutto l’umano. Non sempre èal servizio della verità, perché i suoi fini possonoessere eteronomi. Perché la grandezza e raffinatez-za del gusto estetico raggiunto dalla nostra civiltànon ha fino ad oggi evitato le grandi tragedie e glieventi terribili di cui la storia è stata protagonista. Ma può assumere ancora, invece, un grande ruoloetico e pedagogico quando riesce ad attivare pro-cessi riflessivi che diventano trasformativi.Soltanto quando la sua forza operante agisce sulleemozioni essa può diventa vera Erlebnis. Come staaccadendo con la diffusione e conoscenza delleimmagini di tutti gli olocausti, non solo dellaShoah, dei disastri ecologici, della devastazionedegli ambienti naturali, delle condizioni di malsvi-luppo, delle sempre più estese e diffuse condizio-ni di sofferenza umana e di aree di non-diritto allavita. Riprodurre e moltiplicare narrazioni, immagi-ni, simbolizzazioni, stilizzazioni attraverso l’artepuò generare il rifiuto della violenza dominatrice esfruttatrice e trasformare il modello dello sviluppoad ogni costo, da regressivo a coevolutivo, nel
rispetto per l’umanità e per la natura. Si pensi allacarica eversiva che ha per i giovani oggi la musica,con la sua forza di coinvolgimento e trascinamen-to emotivo collettivo. Oppure alla forza rigenera-trice di democrazia che ha sempre avuto neltempo delle crisi la satira politica, con la sua graf-fiante capacità di denuncia e demolizione degli ste-reotipi mentali e culturali. L’ermeneutica di Gadamer, riprendendo l’idea chel’esperienza artistica costituisca in ogni caso un’e-sperienza di verità, aveva già messo in questionela moderna distinzione kantiana fra arte, cono-scenza e morale, in quanto non si può concepirel’esperienza del bello come un’esperienza total-mente separata e distinta da ciò che intendiamoper vero e per bene. Pertanto, l’arte non è altroche uno dei molteplici modi d’essere dell’uomo,con cui egli esplora la realtà e s’interroga sull’esse-re. Essa ha quindi, una valenza speculativa ontolo-gica. Per questo neppure l’esperienza artistica puòcontinuare ad essere concepita come spontaneitàassoluta, bensì come una ricerca permanente diverità; una ricerca incessantemente mediata attra-verso e dalla tradizione culturale, dalla problema-ticità e contraddittorietà della realtà, dagli stru-menti e dalle modalità di comunicazione che coin-volgono contemporaneamente tre dimensioni: l’o-pera, l’artista, e la infinità dei fruitori, ciascuno conil proprio originale e unico sistema mentale, conla propria ecologia. Perché è nel sistema emotivoe cognitivo che si genera l’ascolto, la visione, lainterpretazione e, dunque, la comprensione. (L.BOELLA, 2006).Le condizioni che rendono possibile la creazionecognitiva, la poiesis non sono, quindi, soltantosocio-culturali, ma sono innanzitutto biologiche eantropologiche; poiché ogni teoria o sistema diidee ha in sé i caratteri dell’ideologia, costruitacon i nostri frams, con le strutture concettuali disoggetti neurocognitivi. Da quanto fino ad ora descritto possiamo assume-re senza timore il carattere naturale o bio-antro-po-socio-storico-economico della produzione arti-stica e non vederla più solo come un sofisticatoartificio produttore di realtà virtuali e innaturalifinalizzate al bello e all’utile; ma, creazione natu-rale di un essere biologico che vive nel tempo

99
della propria storia e in una precisa società che lotrascende culturalmente. Creatore e produttoresia in senso culturale e vitale, che simbolico emateriale; poiché da essa ne consegue la possibili-tà della sopravvivenza esistenziale, economica, cul-turale e dunque biologica della specie. In questa prospettica ecologica lo sguardo appren-de a spostarsi, a praticare la multilateralità, amuoversi in tutte le direzioni e ad agire le diffe-renze, come anche le distanze, i ritorni, i rimandi,le proiezioni, le sovrapposizioni. Per dirla con R.Rorty, c’è una irriducibile molteplicità di punti divista interpretativi che fa cadere la presunta uni-versalità, in una potenzialità di mondi sensibili,che permette il costituirsi di una varietà di espe-rienze possibili. E’ questa diversità che coinvolgetotalmente, nell’unità di mente-corpo, l’individuoche gli permette di interrogarsi in modo a autono-mo e autentico, di riflettere su di sé e sul propriomondo o destino, sull’autentico significato dellapropria esistenza. (R. RORTY, 1989).Così se pure l’opera è una, come unico può esse-re l’artista, ma di una unità complessa, tutti i frui-tori sono artisti, che con la loro creatività apronola loro fantasia e immaginazione a molteplici oriz-zonti di senso, a nuove ecologie. In questo sensoVita è arte, e arte è vita in quanto ogni ecosiste-ma biologico e mentale, ogni ambiente cognitivoindividuale accresce le potenzialità creative del suomondo nell’incontro sensibile con il mondo del-l’opera. E’ ciò ci rende tutti artisti nella nostraimmaginazione ed esistenza.Questa soggettivizzazione implica una moltiplica-zione dei punti di vista, una diversità che confermala impossibilità di giungere ad una visione unitaria,compiuta ed essenziale della realtà. Non essendo-ci più una centralità di visione ed interpretazionesull’intera realtà, anche le verità si pluralizzano enell’esperienza estetica entrano in gioco altrimondi, diversi e problematici, non tutti in grado diilluminare o esaltare il mondo. Al posto dellametafora illuministica e del rischiaramento dellementi, si è già fatta strada l’immagine scomposta diuna realtà fatta di chiari e scuri, di luci ed ombre,descrivibili con la metafora heideggeriana dellaradura. Ma a quelle metafore oggi fa seguito quel-la del labirinto della vita, di piani inclinati, di linee
ricurve, di differenti realtà non sempre e non tuttetessute insieme da relazioni, in un gioco comples-so e infinito di connessioni vitali, di ecologie men-tali e cognitive di creazioni di creazioni.Come crolla la visione unitaria e compatta delmondo sotto i colpi delle nuove teorie filosofichee scientifiche, che dilatano i confini e gli spazicognitivi, allo stesso modo le teorie esteticheespandono il loro potenziale creativo diventando,ancora una volta luoghi di apertura e di possibilitàaltre.E se da un lato, quello del fare, produrre, creare ericreare, la molteplice irriducibilità delle propostee prospettive estetiche contemporanee, painogenerare una sorta di relativismo nichilistico, ali-mentando punti di crisi e di rottura, ma anche dideclino e dissoluzione culturale, sbriciolandosi inuna miriade di estetiche specifiche che emergonodalla infinità dei mondi nati dai nuovi linguaggiespressivi, dalla loro ibridazione con le tecniche,dalle nuove teorie critiche che mettono tutto indiscussione; dall’altro, da questo caos magmaticoe indistinto, da questa rete virtuale e simbolica, daquesto laboratorio diffuso che costituisce un net-work planetario incontenibile, nascono nuoverealtà, ma anche nuovi modi di guardare e dun-que di percepirle. Una realtà non più unitaria, lineare ed omogenea,ma fatta di mille piani e differenze, con una varie-tà spettacolare di sfumature, tonalità, angolazioni,inquadrature, sovrapposizioni, attraverso le qualimolte esperienze si concretizzano ed assurgono adautentiche e significative creazioni, altre sonodestinate a disintegrarsi e morire, se non sono giàmorte prima ancora di nascere. In questo tempod’incertezza generalizzata non c’è nessuna mortedell’arte (altri sensi della fine e ossessioni crepu-scolari ci sono già state), semmai c’è l’infinitogioco della vita e della morte, come in tutto ciò cheè vivente.In questa storia naturale delle possibilità ci puòessere la vera sfida ai processi omologanti e uni-formanti della mondializzazione; da questi modi emondi creativi disordinati e caotici, senza senso,da questo pluriverso di infinite costruzioni e deco-struzioni, possono venire a nascere nuove visioniforiere di sogni, aspettative, utopie ancora possibi-
Santa de Siena Verso la teoria della creatività

n.22 / 2009
100
li, capaci di nutrire la speranza in una estetica, filo-sofia, società, politica ecologizzate, di un mondopacificato, di una riscoperta della bellezza dellanatura dimenticata. E’ proprio riflettendo sul gioco creativo della vitache è possibile leggere e interpretare ermeneuti-camente l’essere umano e il suo modo di essere edi vivere nel mondo, di tentare di comprendere lasua ontologica condizione e il suo incerto e sfu-mato destino. Non si tratta solo di porsi all’ascolto dell’essereche rischierebbe di tradursi in una sorta di immo-bilismo e di conservazione dell’esistente, quantodi riapprendere a coniugare i tempi al futuro, adallargare le nostre prospettive, a trasformare ilnostro modo di sentire e volere. Poiché non si trat-ta solo di registrare il mondo, ma anche di tra-sformarlo. Nel tempo in cui tutte le verità si disintegrano e sisbriciolano, può avere inizio l’irrinunciabile ricercadella verità, perché la ricerca, questa si, è ontologica.
11. Sulla originalità
Trasferire, trasformare, inventare, riprodurre, pro-durre, usare i colori per inventare nuovi colori, isuoni per far vivere luoghi e inventare nuove archi-tetture, applicare la musica ai testi spontanei, dif-fusi che ci circondano, usarla come forma, fartransitare codici, concepire un film come una scul-tura, scegliere storie e farle diventare sculture,metafore, creare pitture sonore, scambiare luoghiper simboli e simboli per luoghi, scoprire artinuove come la body art, strutturare e comporrenuovi materiali, reificare immagini, reinventare artie nuovi stili e artifici, tutto questo è vita: cinema,poesia, musica, pittura, danza, teatro, letteratura,scultura, fotografia, grafica, pubblicità, non sonopiù mondi separati e a sé stanti, ma linguaggi, sim-boli, codici senza canoni per trasformare ogget-ti e persone in simboli, luoghi e miti in icone. E’questa la partita che si sta giocando a livello plane-tario con tanti giocatori, ma senza un arbitro, o unallenatore che li diriga, senza che nessuno sappia ache gioco si sta giocando, o che possa dire questoè un gioco (G. BATESON, 1996), ma nel quale
migliaia di giovani, creativi, artisti, architetti, artdirector, mettono in gioco tutta la loro creatività efantasia, andando oltre l’arte nella sua accezioniclassica, mettendo in questione i suoi canoni, isuoi fondamenti estetici per andare oltre il sensibi-le, contro l’arte. Non è letteralmente possibile orientarsi e districar-si in questo pianeta fatto di miriadi di costellazioninel quale ogni contatto sinaptico costituisce unacreazione, nel quale tutto ciò che è creato è desti-nato a mescolarsi, a inventare linguaggi usati comemateriali, a riscoprire vecchie tecniche, a ibridarlealtri significati, dissolvendo canoni, delocalizzandoconoscenze, ampliando le scale, innestandomodelli, moltiplicando le abilità percettive, con-trapponendo o diversificando il vecchio con ilnuovo, interscambiando ruoli, combinando emediando più dimensioni artistiche, montando erimontando pezzi, storie, ritmi, sequenze filmiche,sovrapponendo stili, azzardando accostamenti ine-diti, proponendo ritorni impensabili, provocandoslittamenti tra codici, inventando nuove sintassi,nell’idea di distillare la creatività e di farla esplo-dere in un vortice di emozioni fuori dal controllodi una sola mente.Non esiste un mondo dell’arte, ma una galassiacostituita da piccoli e grandi mondi di creazioni,che si confrontano, scontrano, misurano, speri-mentano, imitano, copiano che usciti fuori dailaboratori assumono l’intero palcoscenico dellavita sociale, politica, culturale, economica, comeun megalaboratorio fatto di botteghe aperte, con-nesse in rete, dove tutto si espande ed entra inrelazione. Proprio come accade nella litografiaGalleria di stampe di M. C. Escher (1956), nellaquale lo spazio, non più unico e ad una soladimensione, si dilata sotto gli occhi dello spettato-re e si riorganizza in nuove prospettive che loincludono insieme agli altri spettatori. Si vengono a delineare così una molteplicità dipiani di realtà diverse e variegate, nelle quali ognisenso è perduto, e ogni cosa smarrisce la sua dire-zione, prospettiva e pretesa centralità; dove tutto èperiferizzato, come la nostra Terra, perduta nellospazio cosmico intergalattico, e sembra gridare:dimenticare l’arte.L’artista non è più solo e chiuso nel suo microco-

101
smo, ma costruisce il suo team insieme ad altri;team che, a sua volta, si allarga ed entra in relazio-ne con altri gruppi che possiedono altre compe-tenze e abilità, costituiti da ingegneri, architetti,scienziati, designer, editor, registi, coreografi, filo-sofi, musicisti, esteti, amministratori, managers.L’arte crea risorse ma ha bisogno di risorse perpoter creare. Non solo di risorse noologiche e sim-boliche, ma anche economiche. L’arte è business eil business è arte. Tutto il mondo dell’economiaruota intorno all’arte e funziona grazie alla comuni-cazione. Per questo l’arte ha bisogno di produttori,finanziatori, managers, sponsor, non c’è più l’artistastoicamente chiuso nel suo studio disposto a viveredi stenti, pronto a morire in miseria per esseremagari scoperto e valorizzato solo dopo la suamorte. C’è indubbiamente anche questo, perchél’incertezza del vivere è data dal successo, ma anchedall’insuccesso, dalla propria capacità di comunica-re, di soggiacere alle dure leggi del mercato. L’arte èvita nel senso che nutre la vita e si nutre di visibili-tà, immagine, pubblicità, mediazioni, successo, sianelle grandi che nelle piccole produzioni.Le opere d’arte viaggiano nello spazio reale comein quello virtuale; viaggiano le idee e gli artisti checon il proprio motore di ricerca mentale si muo-vono attraversando confini, continenti, spazi indi-stinti, tempi indefiniti.La parola chiave è post-produzione, ossia creareciò che non c’è, ma anche aggiungere, smaterializ-zare, manipolare, programmare, rielaborare, tra-sformare tutto ciò che può concretizzarsi in even-to, in prodotto culturale. Il che significa saper met-tere in relazione, creare nuovi processi intreccian-do culture, esperienze e linguaggi diversi, lascian-do che l’opera si autogeneri e si sviluppi in modospontaneo, imprevisto, non prestabilito. Senza fis-sare canoni, senza seguire schemi collaudati, senzauna traccia e un disegno definiti.Il nuovo di cui si ha incessantemente bisognocomporta l’estremizzazione, la radicalizzazione, lasperimentazione. E’ quel che accade nel mondodei pubblicitari, i cosiddetti creativi, come nelcinema, dove gli artisti coinvolti sono lasciati liberinelle loro energie di inventare quanto più è possi-bile. Creare non preoccupandosi a chi appartengail prodotto finito, né di quale sia l’estetica che ne
viene fuori. L’artista cambia, dunque, il suo ruolo,la sua funzione e le sue idee mutano nel confron-to con quelle degli altri, mutano in rapporto allerealtà che mutano nel mentre si fanno in progressle estetiche.Se nell’arte la visibilità è tutto, allora non basta piùsolo l’idea, l’intuizione, il concetto, perché nellasua attuazione c’è bisogno dei mezzi, degli stru-menti che la rendano visibile, delle diverse e dif-formi professionalità che partecipano e concorro-no alla sua realizzazione. Ogni momento del pro-cesso creativo può assumere un significato storicoe personale differente per chi la vive, e quel vissu-to professionale può assumere i toni dei colori eun montaggio assumere l’aspetto di una installa-zione architettonica.L’estetica a-venire, allora, sarà quella che verrà anascere, che emergerà alla fine di una serie disequenze operative, sarà l’esito di un lavoro nelquale si sono sovrapposti e contrapposti simbolo-gie, ruoli, funzioni e sensibilità diverse. Nella qualeentrano in gioco filosofie, discipline artistiche,mentalità, spazi architettonici, storie, fisicità, rap-presentazioni, aree di creatività che interagisconosenza che ci sia una volontà specifica a guidarle.L’arte, soprattutto quella non figurativa, è datempo entrata nella vita quotidiana, nella fruizionedi tutti i giorni, entrando a far parte pienamentenei sistemi socio-economico, divenendo produtti-vi non solo nel senso estetico, ma anche economi-co, simbolico, tecnico-industriale.L’arte non è più rinchiusa nei musei e nelle galle-rie, ma è dappertutto, è fuori, ovunque senza-luogo, ad inondare la visione quotidiana di miliar-di di individui, e il suo principale scopo è quello difarsi guardare, sugli schermi del cinema, sui car-telloni pubblicitari, nelle stazioni del metrò, nellevetrine dei fashion store, per affascinarci, persua-derci, imbonirci, irretirci, influenzarci, ammaliarci.Nessun artista ormai può dirsi un creatore, nelsenso classico del termine, ma come noi tutti, pos-siede soltanto particolari abilità di osservare, per-cepire, imitare, copiare, manipolare, riprodurre,trasformare ciò che percepisce; ispirato da operedi altri artisti, da altri prodotti culturali. Il flusso distimoli, immagini, suoni, che ogni giorno vieneproiettata, diffusa nelle mille forme della realtà
Santa de Siena Verso la teoria della creatività

n.22 / 2009
102
incontra la creatività e l’immaginazione di ciascunoe quelle immagini, suoni, parole, colori, entrano inun mondo interiore, in una ecologia ambientaledove si incontra con la propria sfera noologica,con altri paesaggi mentali fatti di ricordi, rimandi,simboli, connessioni, relazioni, mindscape e daiquali nuove creazioni si generano. Il geniale e creativo critico francese NicolasBourriaud nel suo saggio dal titoloPostproduction, Come l'arte riprogramma ilmondo, ha descritto il mondo della postprodu-zione alludendo al lavoro finale di una produzioneartistica, quale può essere una trasmissione televi-siva o cinematografica, ma che può essere estesa aqualsiasi prodotto culturale, nel quale alla pellicolagirata vengono successivamente aggiunti i suoni, isottotitoli, gli effetti speciali (2004). La sua idea èquella di dimostrare che oggi, in ogni genere d’ar-te e per ogni artista, accade ciò che avviene allaconsole di una discoteca quando l’abilità musicaledel dj viene amplificata e fatta interagire con suonigià registrati accompagnati da luci e ritmi preorga-nizzati. Una sorta di molteplici abilità che genera-no un’intelligenza collettiva come la definisce P.Levy, il quale crede profondamente nel suo poten-ziale di cambiamento epocale (2002), che mette adisposizione una quantità enorme di produzioni eprodotti culturali capaci di dare vita ad una infinitàdi postproduzioni, di meta-creazioni. Un esempio straordinario tra i tanti di postprodu-zione che può essere citato è quello del registatedesco Tobias Rehberger che ha realizzato OnOtto, un film-installazione in mostra allaFondazione Prada di Milano, ma già esposta allaBiennale di Berlino nel 1997, accompagnato dadue libri, On Otto e On Solo. L’idea guida o inizia-le è stata quella di partire dalla fine, e cioè dalManifesto, sul quale hanno lavorato i più impor-tanti e diversi artisti del mondo. Per realizzarla ha,infatti, richiesto il contributo di innumerevoli arti-sti e star di Hollywood, attori scelti per il loro valo-re simbolico ed iconico, oltre che per le loro spe-cifiche professionalità.Suggestiva è anche un’altra sua opera 7 Ends of theWorld , esposta a Venezia nel 2003, nella quale sivedono collegate 111 lampade sul soffitto delPadiglione Italia a sette punti principali del mondo,
tra cui la cima dell’Himalaya, con il Burger Kingabbandonato a Kyoto, e con un campo di zucchein Romania. Se oggi il download di forme fatte di sampling e diremake, sono così importanti è perché ci spinge aconsiderare la cultura globale come una scatola distrumenti, uno spazio narrativo aperto, piuttostoche un discorso univoco o una linea di prodottiindustriali. Invece di prostrarsi davanti alle operedel passato gli artisti se ne servono. Quello cui siassiste è un’arte che utilizza il mondo, in un’infini-ta negoziazione di punti di vista. Sta a noi spetta-tori mettere in evidenza queste relazioni, giudicarele opere d’arte in funzione dei rapporti che pro-ducono all’interno del contesto specifico nel qualesi manifestano. Perché l’arte è un’attività di rela-zione con il mondo, di materializzazione con lospazio e col tempo. Appare, quindi, evidente come l’idea di originali-tà, nel significato primario del termine e cioè diqualcosa che è all’origine, si dissolve prepotente-mente e non subisce una semplice trasformazione,ma ne è scardinata in modo profondamente radi-cale. Lo stesso accade al concetto di creazione, ilquale perde quel connotato tradizionale di qualco-sa che viene dal nulla e acquisisce quello più sem-plice di qualcosa che prima non c’era, oppureche non era proprio così. Allo stesso modo anche la nozione di genio nonregge alla critica immanente e, osserva M. Costa(2005), non può più essere concepito come undono di natura ma semplicemente come una for-tuita congiunzione tra attitudine e favorevoleposizione all’interno di una certa sequenza di pos-sibili soluzioni ad un problema formale.Viviamo immersi in flussi di immagini, parole ecolori, in un mondo nel quale tutto è nuovo, sem-pre più nuovo. Quel nuovo oggi sta per originale,appunto per indicare semplicemente ciò cheprima non esisteva, oppure era diverso. Tutta lavisione del progresso moderno, dello sviluppo tec-nologico applicato alle micro e macro tecnologiesembra concentrarsi nelle fogge delle migliaia dipiccoli oggetti che invadono le vite di miliardi diesseri umani, che diventano protesi permanenti,che definiscono il nostro stile di vita, il nostromodello comportamentale, il nostro grado di

103
benessere o malessere, tutti creati e riprodottiappositamente in una infinità di forme, modelli,colori, grandezze, materiali e al tempo stesso per-sonalizzati e diversificati. A creare questo universo di incessanti novità, diciò che prima non c’era, o anche di veri-falsi lavo-rano eserciti di esseri umani intenzionati a produr-re gli oggetti del nostro desiderio. Tonnellate dimerci e cose, soprattutto inutili, sono ideate quo-tidianamente per sollecitare i nostri bisogni, permoltiplicare i nostri acquisti, offerte proposte edesibite in ogni luogo e con ogni mezzo, veicolateda una comunicazione sempre più rapida che velo-cizza lo sguardo e abilita a scegliere con immedia-tezza. Ciò per permette al maggior numero di altriesseri umani di possederli e conquistarli a colpi difatica e di ore di lavoro stressanti. L’intero sistemaeconomico mondiale è ormai fondato sul principiodel consumare per produrre. E’ questa pare esse-re diventata la vera e forse unica condizione di feli-cità possibile. A questo fine non lavora solo l’arte,ma anche la ricerca, le imprese, l’industria, i desi-gner, i pubblicitari, gli architetti, i comunicatori.Perché si continui senza soluzione di continuità aconsumare occorre che tutto sia percepito costan-temente come totalmente sempre tutto nuovo edogni cosa, ad ogni ora del giorno e della notte, inqualsiasi luogo e a qualsiasi condizione e latitudinedel pianeta ci si trovi, occorre sapere che esiste,occorre esserne informati. Anche il genio della creatività si è, dunque, lique-fatto, diventando molecolare, diffuso in una miria-de di piccole e indefinibili realtà, fatte di studi elaboratori disseminati sull’intero globo che invado-no con le loro creazione ogni microrealtà siamateriale che virtuale. Un immenso e capillarelaboratorio che costituisce un unico sistema cheha reso il mondo ormai un unico only one world.Al totalitarismo consumistico ci lavorano i cosid-detti creativi, milioni di grafici che si autodefini-scono art, termine tecnico che sta per art direc-tor, grafici pubblicitari che ogni giorno hanno ilcompito di inventare ed edificare il nostro castellodi desideri. Copywriter, scrivani, pubblici espertinello scrivere sceneggiature per film di trentasecondi e slogan per manifesti. Al posto di sloganoggi si preferisce claim oppure headline, per indi-
care gli addetti che costruiscono messaggi per pro-porre novità sempre più nuove, per persuaderemigliaia di persone a desiderare quel che li rende-rà sempre più insoddisfatti, che faranno viveresempre nuove emozioni pronte a tradursi in senti-menti di frustrazione post-acquisto, come ci rac-conta in modo graffiante e brillante nel suopamphlet scandalo F. Beigbeder. In Lire 26.900, ilcritico letterario americano rivela e denuncia comeattraverso la persuasione pubblicitaria si sta com-piendo la più terribile e subdola forma di totalitari-smo, una versione molto più insidiosa e perfettarispetto a quelle del passato.Utilizzando i mezzi della rapidità, crudeltà, legge-rezza, glamour, la pubblicità ha scelto la lineamorbida, quella appunto della persuasione al con-sumo, per ridurre in schiavitù l’umanità. Viviamo,egli sostiene nel “primo sistema di dominio del-l’uomo sull’uomo contro il quale perfino la liber-tà è impotente. Anzi, questo sistema punta tuttosulla libertà, è questa la sua più importante tro-vata. Le critiche servono solo a dargli più risalto,i pamphlet a rafforzare l’illusione della sua mel-liflua tolleranza. Vi sottomette con eleganza.Tutto è permesso, nessuno viene a malmenarti sefai casino. Il sistema ha raggiunto il suo scopo:anche la disobbedienza è diventata una forma diobbedienza” (2005, p. 20). Si sta verificando una transizione dall’economiapesante all’economia leggere, al mondo dell’imma-teriale, come ci insegna J. Rifkin, ne L’era dell’ac-cesso (2001) che definisce così la nostra societàdella conoscenza, nella quale il sapere, intesocome know how, le conoscenze, l’informazionecostituiscono la materia prima del sistema pro-duttivo post-capitalistico. Per cui la genialità dellasocietà dello spettacolo consiste proprio nellacapacità di manipolare il desiderio umano in tuttele sue forme di curiosità ed eros, sfruttando pro-prio quell’insoddisfazione che per i pubblicitaricostituisce essa stessa una merce. (G. DEBORD,2002, p. 67).Di questo gigantesco unico sistema comunicativoorganizzato nessuno è responsabile, ma quel che ècerto è che ha un potere enorme; un potere cheimpedisce al cervello di funzionare, che trasformagli esseri umani in animaletti obbedienti, che fa
Santa de Siena Verso la teoria della creatività

n.22 / 2009
104
credere a tutti che il loro potere sta nella loro cartadi credito, che sa come impedire di scegliere e satrasformare gli atti gratuiti in atti di acquisto.Purtroppo questa immagine del mondo non èaffatto distante dall’organizzazione del potere teo-rizzata da Michel Foucault: una “micropolitica” cheriflette, dall’alto al basso della scala sociale, finzio-ni sociali che a loro volta prescrivono costumi etacitamente organizzano il sistema dominante. Eallora la sfida non può che essere quella di diven-tare interpreti critici di questi scenari, giocandocon altri scenari, costruendo nuove narrazioni cheandranno a sovrapporsi alle narrative che ci ven-gono imposte, per fare emergere altri scenariimpliciti e inventare quelli che ci renderanno piùliberi. Dopo aver creduto alla magia del progresso e allevirtù autoregolative del mercato, verifichiamo cheil mondo è retto unicamente dall’economia e nondalla politica che conta sempre meno e gli indivi-dui che credevano di scegliere la loro politica, diformarsi un’opinione, di ragionare e dialogare,sono diventati prodotti mediatici al pari dello spaz-zolino e del dentifricio. La democrazia come è statateorizzata dai filosofi politici e, solo in parte prati-cata, si è ormai autodistrutta; al suo posto c’èormai la democrazia commerciale. Nessuna arte è estranea a questo sistema di mer-cato, di consumo e di spettacolarizzazione; anzi neé parte integrante. L’arte, e in particolare l’artedella comunicazione è spettacolo nello spettacolo,come del resto ci aveva già anticipato quarant’annifa Guy Debord nel suo celeberrimo lavoro Lasocietà dello spettacolo, denunciando in anticipo ilfeticismo della forma-merce, il quale sosteneva cheogni elemento,“non importa la provenienza, puòservire a creare nuove combinazioni. […] Tuttopuò servire. Non c’è bisogno di dire che si puònon soltanto correggere un’opera o integrareframmenti diversi di vecchie opere in unanuova; si può anche alterare il senso di questiframmenti e modificare a piacimento ciò che gliimbecilli si ostinano a definire citazioni”. (2002,p. 60). Poiché ogni forma d’arte ha bisogno d’es-sere rappresentata, mostrata, esibita, sceneggia-ta, scritta, visualizzata, comunicata, percepita,liberata, ammirata, conosciuta, diffusa e tutto
questo oggi può accadere in modo più facile ecapillare che nel passato.Se tutto è arte, è poiesis allora come fare la diffe-renza? I pianeti dell’arte offrono, mostrano, sugge-riscono, evocano, illudono con i loro oggetti, mal’arte esige qualcosa in più, qualcosa che vada oltrela semplice suggestione, l’emotività rapida che siestingue nel volgere di un attimo. L’arte, la suafruizione richiede riflessione, attenzione, durata. L’attenzione va spostata, allora, sul soggetto, chedeve saperla poter interpretare, leggere, brucare;senza l’attivazione di processi trasformativi inte-riori, senza la auto-creazione d’esperienze emoti-ve e partecipative, non si da significato.Non dobbiamo dimenticare, infatti, che esiste tuttauna letteratura di consumo di apparente imme-diatezza spalmata in molte forme pubblicitarie,nell'uso della parola e frasi celebri, nei testi pub-blicitari o nelle canzoni di consumo. In uno deisuoi aforismi Franco Fortini ha osservato che se siscrivono o si leggono dei versi senza una qualchecoscienza critica o storica della tradizione letterariae della loro destinazione, della loro collocazionenella realtà di oggi, si fa una strada falsa. Il secolo del post si apre all’insegna del riconosci-mento della pluralità e multidimensionalità del-l’arte e delle estetiche, ma anche del soggetto chedeve saperla comprendere e vivere, al di là dei cla-mori e dei mezzi capaci di veicolarla e divulgarla.Un soggetto a più dimensioni che vive creandoogni giorno la sua arte di vivere, con la sua sensi-bilità, gusto, azione. Poichè indubbiamente nontutto è arte e non è affatto semplice orientarsi nellamolteplicità ed eterogeneità delle dimensioni este-tiche costituite da galassie di pianeti sconosciuti,nelle quali c’è di tutto anche tanta inutilità, falsità espazzatura. Ma è in questo complesso sistemico nelquale si manifestano in modo antagonista e com-plementare, allo stesso tempo, le istanze di libera-zione, imitazione, riproduzione, invenzione, orga-nizzazione, relazione, denuncia, conservazione,dominio, educazione, sfruttamento, che l’artedeve poter costituire occasione per quelle espe-rienze transizionali capaci di farci muovere da unpiano all’altro della realtà, da quelle tragiche deldolore a quelle più dolci e poetiche del piacere,costituendo singolari e vitali Erlebnis.

Santa de Siena Verso la teoria della creatività
105
12. Contro l’estetica
E’ difficile, dunque, non riconoscere che la pubbli-cità, la comunicazione, il cinema tutto ciò che rien-tra nello spettacolo non sia arte e dunque nondebba rientrare nel novero di ciò che si intendeper dimensione estetica.Certo gli Schiller, i Kant e gli Adorno, ci hannoeducato alla distinzione tra il bello e piacevole, enon vi è dubbio che tutto quello che viene pro-dotto non possa dirsi estetico. Ma potremmo ten-tare di definire cosa oggi si debba intendere perbello nel senso del duraturo, universale, origina-le, o dire quale sia la funzione dell’arte nella socie-tà planetaria? Quel che abbiamo esplorato è la possibilità di con-cepire la bellezza non come un concetto assoluto,ma evolutivo e l’arte, nella varietà offerta dal siste-ma globale, come co-evolutiva alla vita, come ognisistema vivente, in ambienti fatti di scambi, comu-nicazione, interazione e reciprocità che non solovive e si nutre di informazioni, ma organizza e pro-duce informazioni vitali che modificano ed evolvo-no i nostri gusti.C’è quindi un principio coevolutivo che coinvolgetutte le componenti del nostro sistema simbolico,che si relazione con altri gusti, poiché anche ilbrutto fa la sua parte, con la diversificazione deigeneri, degli stili.Al centro di ogni possibile concezione estetica c’èallora una pluralità di soggetti o sistemi viventi cia-scuno con la propria organizzazione autonoma esistemica, con la propria emotività e il proprioimmaginario. Emozioni che possono essere mol-tiplicate, pluralizzate, affievolite per effetto dellaquantità che implica una riduzione della qualità.L’incanto, la gioia, la paura, il desiderio, l’attesa,sono occasioni molto rare, e non è affatto la spet-tacolarità che le suscita, ma il nostro sistema per-cettivo con il quale esse entrano in relazione. E’nel corpo e nell’unità di soggetto-oggetto cheavviene il sentire e dove si generano le emozioniche solo l’arte sa far venir-fuori. Già Kant spostan-do lo sguardo dall’oggetto al soggetto sostenevache la bellezza non è nelle cose, ma in noi.E’ il corpo, dunque, in quanto teatro delle emo-zioni, ad assumere un ruolo primario nella diffe-
rente scelta e definizione dei concetti, nella lorodiversità di accezioni, sfumature, tonalità, che defi-nisce ciò che è arte per noi. Il corpo come diffe-renza della differenza. Credo, afferma a tale pro-posito A. Damasio, nella interrelazione di mente-corpo, di mente-cervello, e credo anche che inmolti casi “il cervello impari a metter insieme lafievole immagine di uno stato <<emotivo>> delcorpo, senza doverla ripromulgare nel corpo”(1999, p. 223). Una sorta di indelebile memoriaemotiva, che come tutte le memorie lascia le suetracce nel tempo.La prospettiva ecologica va oltre le insufficienzedella prospettiva classica della rappresentazione eraffigurazione, in quanto pone fine all’idea che visia o ci debba essere una unicità prospettica, cosìcome una l’unità dell’osservatore. Essa implicauno sguardo sistemico e multidimensionale capa-ce di cogliere la tridimensionalità che implical’oggetto, il soggetto e l’ambiente.Viene così introdotto nello studio delle scienzecognitive un principio di circolarità caro alle tra-dizioni orientali, per cui lo studio di ogni fenome-no creativo e mentale è sempre quello di una per-sona che fa una esperienza vissuta, il che esclu-de la concezione di una oggettività o di perfettacorrispondenza tra le idee dentro di noi e le cosefuori di noi, tra soggetto e oggetto, poiché siamonoi con le nostre diversità cognitive - osservaMorin - che “imponiamo al mondo le categorieche ci consentono di cogliere l’universo dei feno-meni. In questo modo, noi conosciamo delle real-tà, ma nessuno può pretendere di conoscere laRealtà con la “R” maiuscola” (1992, p. 501).Comprendere la multidimensionalità della rela-zione con il mondo significa scoprire anche la suanatura metaforica e ci permette di abbandonare ilsogno dell’oggettività del mondo che sta là fuori edi comprendere meglio come il nostro sentire sialegato all’esperienza, alla conoscenza fenomenicadel nostro modo di percepire e comprendere noistessi, da dove derivano le nostre scelte politiche,religiose, ideologiche, estetiche, la fiducia neglialtri. Ci fa comprendere come essa sia indissolubil-mente legata alla nostra struttura poietica, poichénoi non vediamo lo spazio del mondo ma lo vivia-mo, viviamo il nostro campo visivo. Noi non vedia-

n.22 / 2009
106
mo i colori ma viviamo il nostro spazio cromatico. La corporeità è lo strumento privilegiato del con-tatto con le cose, costituisce la dimensione origi-naria percettiva che è il primo livello, antecedentea qualsiasi altro livello di donazione di senso, dicostruzione del mondo. Percepire me stessocome corpo capace di relazione con le altre cosedel mondo e con gli altri corpi, mi permettere dicomprendere e sentire per entropia come e quan-to anche gli altri corpi, come il mio, sentono e pro-vano. L’oggettività del mondo, come dicevaHusserl, è strettamente connessa dunque al rico-noscimento dell’intersoggettività, ma in questoincontro con l’altro, con l’alterità incontro mestesso a partire dalla mia corporeità.La comprensione di questa diversa prospettiva teo-rica ci pone, quindi, dinanzi alla possibilità di svi-luppare e promuovere la pratica della consapevo-lezza, rigettando ogni concezione astratta e irri-flessiva della mente e dell’arte, il che significa porrenon pochi problemi all’ordine sociale costituito,perché mette in discussione assunti della vita quo-tidiana e sui quali si sono fondati, per secoli, istitu-zioni e sistemi di valori e di poteri dominanti.Contrariamente a quanto esigerebbe il sensocomune, l’idea di persona strutturalmente connes-sa con l’intero mondo vitale apre ad un soggettoconoscente molto più frammentato e niente affat-to unitario, né coerente perché frammentari enon-compatti sono i nostri sistemi cognitivi, lenozioni linguistiche che utilizziamo. Il procedimento destrutturante del soggetto nonci riconsegna una immagine più unitaria e piùcompleta, ma al contrario ci delinea una personaneurocognitiva più problematica e complessa,che non vive più la scissione fra mente e corpo, mache al tempo stesso non ha “né una singola loca-lizzazione della coscienza, né una percezioneattendibile, né una ragione trascendente, né unavisione del mondo coerente e compatta, né unalibertà radicale, né una naturale tendenza amassimizzare i propri interessi, né una conce-zione obiettiva della realtà, né una concezioneletterale della verità” (G. LAKOFF e M. JOHN-SON, 1998, p.145 ). Immagine questa che ci prepara ad assumere innoi la logica del vivente che è indubbiamente più
transitoria, imprecisa e incerta ma che può farcicogliere le infinite possibilità di essere capace disuperare la scissione tra natura e cultura e farciscoprire l’umanità nella bellezza della vita: lo spet-tacolo più emozionante che sia possibile provare.Occorre il coraggio di interrogare la crisi epocaleche stiamo vivendo per apprendere ad attraversa-re lo smarrimento generato dalla moltiplicazionedei significati e dei sensi, a vivere il relativismo,insieme a nuove pratiche e politiche di pensierofondate sul rispetto della diversità e della diffe-renza. Per andare oltre l’antico senso di colpa di nonessere una conoscenza vera, l’estetica deve saperaffrontare l’incertezza generata da questa comples-sità fenomenica e muovere dalla dissociazionepsico-culturale alla relazione antropologica e bio-logica per iniziare ad associare e ricontestualizza-re. Accettare la metamorfosi corporea significaanche oltrepassare la dissociazione planetariacon la natura e gli altri popoli e civiltà ed assume-re l’irriducibile multilateralità del mondo, sosti-tuendo la linearità alla circolarità o, meglio, la spi-ralità e aprirsi alla creatività dei nostri mindpla-yers, alle singolarità libere e sconnesse, ma altempo stesso alle pluralità nell’unicità della enella differenza. Soltanto così la post-modernità può costituire untributo alla ri-generazione di senso a-venire.
BIBLIOGRAFIAADORNO, T.W, 1975, Asthetische Theorie,Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1970; trad.it.: La Teoria estetica, Einaudi, Torino; BATESON,G.1976, Steps to an ecology of Mind, ChandlerPublishing Company1972; trad. it.: Verso un'ecolo-gia della mente, Adelphi, Milano;BATESON, G.,1996, The Message “This is a Play”,Josiah Macy Jr. Foundation, 1956; trad.it.: “Questoè un gioco”. Perché non si può dire a qualcuno“gioca”, Cortina, Milano; BAUMAN Z., 2006, Liquid Love. On the Frailty ofHuman Bonds, Polity Press, Cambridge, 2003;trad. it.: L’amore liquido, Laterza, Bari-Roma;BEIGBEDER, F., 2005, 99 Francs, Ed. Grasset &Fasquelle, 2000; trad. it.: Lire 26.900, Feltrinelli,Milano;

107
BOELLA, L., 2006, Sentire L’altro. Conoscere e pra-ticare l’empatia, Cortina, Milano;BOURRIAUD, N. 2004, Postproduction: Culture asScreenplay: How Art Reprograms the World. NewYork: Lukas & Sternberg, 2002; trad. it.:Postproduction. Come l'arte riprogramma ilmondo; Postmedia Books, Milano;CAPUCCI, P. 1994 , Il corpo tecnologico,Baskerville, Bologna;CHOW R., 2007, The Age of the World Targhet,Duke University Press, 2006; trad. It.: Il mondo nelmirino, Meltemi, Roma; COSTA, M., 1990 L’estetica dei media(Tecnologiee produzione artistica), Capone Editore, Lecce; COSTA, M., 2005, Dimenticare l’arte. Nuoviorientamenti nella teoria e nella sperimentazio-ne estetica, Milano, Franco Angeli; CUOMO, V., (a cura di), 2006, L’origine è la meta,Morgana Edizioni, Firenze;DAMASIO, A. 1999, Descartes’Error, 1994, trad.it.:L’Errore di Cartesio, Adelphi, Milano; DEBORD, G., 2002, La société du spectacle,Buchet/Chastel, Paris, 1967; trad. it.: La societàdello spettacolo, Massari Editore, Bolsena (VT);DELEUZE, G. GUATTARI, F., 2003, Mille plateaux .Capitalisme et schizophrénie 1980; trad.it.: MillePiani. Capitalismo e schizofrenia, Cooper &Castelvecchi, Roma;DERRIDA, J. 1971, L'écriture et la différence, 1967;trad. it. di G. Pozzi, La scrittura e la differenza,Einaudi, Torino;DE SIENA, S., 2002, La Sfida Globale di EdgarMorin, Besa ed, Lecce;GADAMER, G., 1986, Verità e metodo, Bompiani,Milano; GALIMBERTI, U. 1999, Psiche e teche, Feltrinelli,Milano;GALIMBERTI, U., 2007, L’ospite inquietante. Ilnichilismo e I giovani, Feltrinelli, Milano;GARGANI, A, 1995, Transizioni tra codici e intrec-ci testuali, in “Pluriverso”, n.1, Etas Libri, Milano;GOODMAN, N., 1985, The structures ofAppearance, harvard University Press, 1951;trad.it.: La struttura dell’apparenza, Il Mulino,Bologna;HEIDEGGER, M., 1968, Sull’origine dell’operad’arte, in Sentieri interrotti, La Nuova Italia,
Firenze;HEIDEGGER, M. 1976, Scienza e Meditazione, inM. Heidegger, Saggi e discorsi, Mursia, Milano;JULLIEN, F., 2006, Nourrir sa vie à l’ècart du bon-heur, Editions du Seuil, Paris, 2005; trad.it.:Nutrire la vita. Senza aspirare alla felicità,Cortina, Milano; KRAUS, K.,1972, Aphorismen. Sprüche undWidersprüche. Pro domo et mundo. Nachts, 1986,Suhrkamp; trad.it.: Detti e Contraddetti, a cura diRoberto Calasso, Adelphi Milano;LAKOFF G., JOHNSON M. 1998, Elementi di lin-guistica cognitive, Ed. Quattroventi, Urbino;LEVY, P,, 2002, L’intelligence collective. Pour uneanthropologie du Cybersoace, Ed. La Découverte,Paris, 1994; trad. it.: L’intelligenza collettiva. Peruna antropologia del cyberspazio, Feltrinelli,Milano;LYOTARD, J.F., 1985, La condition postmoderne,Les Editions de Minuti, Paris 1979; trad. it. : La con-dizione postmoderna, Feltrinelli, Milano; HARAWAY, D. J., 1991, A Manifesto for Cyborgs:Science, Tchonology and Socialist Feminism inthe 1980’s, in “Australian Feminist Studies”,1987;trad. it.:, Manifesto Cyborg. Donne tecnologie ebiopolitiche del corpo, Feltrinelli, Milano;MANGHI, S. 1997, Ecopiesis, in <<Pluriverso>>n. 4 ed. Etas Libri, Milano; MARCUSE, H., 1978, TheAesthetic Dimension, Carl Hausen Verlag,München-Wien, 1977; trad. it.: La dimensione este-tica, Mondatori, Milano;MATURANA H.- VARELA F., 1995, El àrbol delconocimiento, H. Maturana e F. Varela, 1984; trad.it., L’albero della conoscenza, Garzanti, Milano; MORIN, E.,1963, L’esprit du temps, Gallimard,Paris 1962; trad. It.: L’industria culturale, IlMulino, Bologna,MORIN, E. 1983. La Mèthode. La nature de lanature, Editions du Seuil, Paris 1977. trad. it.:Ilmetodo. Ordine, disordine organizzazione,Feltrinelli, Milano;MORIN, E. 1992 Epistemologia e sfida della com-plessità, in Evoluzione e conoscenza, a cura di M.Ceruti, Lubrina Editrice, Bergamo;MORIN E., 1993, La Mèthode IV. Les idèes. Leurhabitat, leur vie, leurs moeurs, leur organisation,Editions du Seuil, Paris, 1991; trad. it., Le idee.
Santa de Siena Verso la teoria della creatività

n.22 / 2009
108
Habitat, vita organizzazione usi e costumi,Feltrinelli, Milano; MORIN E., 2004,La Mèthode II. La Vie de la vie,Editions du Seuil, Paris, trad. it., 1980; trad.it.: Lavita della vita, Cortina, Milano;MORIN, E., 2005, La Mèthode 6. Etique, Editionsdu Seuil, Paris, 2004; trad.it.: Etica, Cortina ed.,Milano; NIETZSCHE , F., 1978, La Nascita della tragedia,a cura di P.Chiarini, Laterza, Roma-Bari;NIETZSCHE, F., 1979, Umano troppo umano,voll.1,2 , Adelphi, Milano;PERNIOLA, M., 2004, Contro la Comunicazione,Einaudi, Torino;RIFKIN , J., 2001, The Age of Access, PenguinPutnam Inc, 2000; trad. it., L’era dell’accesso,Milano, Mondadori; RORTY, R., 1989, La filosofia dopo la filosofia:contingenza, ironia e solidarietà, Laterza, Bari-
Roma; STEINER G., 2003, Grammars of Creation, 2001;trad. it.: Grammatica della creazione, Garzanti,Milano;VARELA, F. THOMPSON, E. ROCH, E. 1992,TheEmbodied Mind. Cognitive science and Humanexperience, Massachusetts Institute of Tecnology,1991 trad.it.: La via di mezzo della conoscenza,Feltrinelli, Milano;VARELA, F. 1997, Neurofenomenologia in“Pluriverso”, n. 3, Etas Libri, MilanoWEBER M., 1977, Il lavoro intellettuale come pro-fessione (La scienza come professione) Einaudi,Torino; ZIZEK, S., 2005, Against Human Rights, New LeftReview; trad. it.: 2005, Contro i Diritti Umani,Saggiatore, Milano;

109

n.22 / 2009
110
Il 18 gennaio 1923 fu approvato il Regio decreton.115 col quale sulla proposta del Ministro delleterre liberate, di concerto con quello dell’interno,Presidente del Consiglio dei ministri, fu eretto inente morale l’Istituto autonomo per la lotta anti-malarica nelle Venezie, con sede a Venezia, e siapprovò il relativo statuto deliberato dal Consiglioprovvisorio il 29 gennaio 1922.Ne dà notizia la Gazzetta ufficiale del Regno d’Italiadel 28 marzo 1923, n.73.Il 30 dicembre dello stesso anno fu approvato ildecreto n. 3256 che approvava il Testo unico delleleggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terrenipaludosi (Gazzetta ufficiale, 24 marzo 1924, n.71).In esso il titolo quarto è dedicato alla piccola boni-fica di cui si identificano le opere in “quelle chetendono alla soppressione delle condizioni disuolo, favorevoli alla moltiplicazione degli insettipropagatori della malaria, nei pressi dell’abitato”.Esse sono a carico dei proprietari fondiari.Quello della bonifica e della lotta contro la malariafu uno dei settori della vita nazionale nei quali ilgoverno fascista dimostrò di impegnarsi fin dall’i-nizio della sua attività (Snowden 2000, Nolte1966).È quindi comprensibile che in epoca fascista fossesparito nelle pubblicazioni ufficiali qualsiasi riferi-mento a coloro che erano stati i promotori dellanascita dell’istituto (Sepulcri 1936).Firmatario del decreto istitutivo dell’istituto auto-nomo per la lotta antimalarica fu il nuovo presi-dente del consiglio dei ministri nonché ministrodell’interno Benito Mussolini.
L’estensore dello statuto del nuovo istituto erastato Silvio Trentin, originario di San Donà diPiave, già eletto deputato alla Camera dei deputatiper la Democrazia sociale nelle elezioni del 1919,docente universitario a Ca’ Foscari, il quale nelfebbraio 1926 emigrerà per ragioni politiche inFrancia, pubblicherà numerose opere di storia e difilosofia del diritto, sarà uno dei dirigenti dellaResistenza francese prima e di quella italiana poi(Rosengarten 1980; Guerrato 1981).Quelle di Trentin e di Mussolini nel gennaio 1923sono dunque due personalità contrapposte sulpiano politico ma il capo del fascismo vittorioso el’antifascista sconfitto dalla marcia su Roma, perun momento convergono sullo scopo di creareuna nuova istituzione per le Venezie, non ancorabattezzate barbaramente come Nord Est.L’Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelleVenezie è una istituzione che è nata da quello cheGiuseppe Gangemi ha definito come federalismoantropologico, una cultura diffusa e praticata nelVeneto, sia in ambienti laici che in quelli cattolici, lecui origini si possono individuare già durante laRepubblica di Venezia (Gangemi 1994; Gangemi2000).Probabilmente l’istituzione più antica del federali-smo antropologico veneto sono proprio i consorzidi bonifica la cui assenza nel Mezzogiorno e nelleisole fu denunciata dagli uomini politici e dagli stu-diosi che si impegnarono nella lotta contro la mala-ria (Campos 1937; Ministero dell’agricoltura e delleforeste 1974). La malaria è una malattia di diffusione plurisecolare
Elio Franzin
Silvio Trentin e la nascita dell’Istituto autonomoper la lotta antimalarica nelle Venezie
Il sestante

Elio Franzin Silvio Trentin e la nascita dell’Istituto autonomo
111
nelle paludi situate lungo la laguna veneta data lapresenza ai loro margini di acquitrini e di piccoliristagni d’acqua (Corti 1984).Numerosi docenti dell’Università di Padova emedici del Veneto hanno dedicato ad essa alcunidei loro studi e delle loro ricerche ( BenvegnùMerzagora 2000; Comparetti 1795; Scortegagna1822; AA.VV. 1824; Fratini 1889; Paluello 1900;Remondini 1785; Vivante 1902; Omizzolo 1904;Peserico 1905; Carazzi 1912; Milioni 1921). La rilevazione della sua diffusione e dei costi eco-nomici che essa comporta è avvenuta in Italia inoccasione della prima inchiesta sulla costruzionedelle ferrovie (Torelli 1882). La gestione delle ferrovie è stata una delle ragioniprincipali della caduta della Destra storica e dellaformazione del primo governo della Sinistra stori-ca inaugurato da Agostino De Pretis il 25 marzo1876 (Carocci 1956).Le legge ferroviaria fu pubblicata sulla Gazzettaufficiale 10 luglio 1878 , n.161. All’articolo 1 essaprevede la formazione di una Giunta oCommissione parlamentare ferroviaria che deveprocedere ad una inchiesta per riconoscere inquale misura i sistemi di esercizio delle ferrovie sti-pulati rispondano all’interesse dello Stato. E qualisiano i metodi da preferirsi per le concessioni del-l’esercizio medesimo alla industria privata.La Commissione deve essere composta da 15membri, sei senatori, sei deputati e tre nominaticon decreto reale.La relazione deve essere consegnata entro il primosemestre 1879.La commissione percorse tutta l’Italia e rivolse lasua particolare attenzione alle condizioni sanitariedel personale ferroviario. Di essa fece parte ilconte Luigi Torelli di Sondrio, partecipe alle lotteper l’unità d’Italia, deputato, senatore, prefetto invarie città fra le quali Palermo e Venezia.Due anni dopo l’inizio delle indagini della com-missione, il giugno 1880, Torelli presentò inSenato un progetto di legge per il bonificamentodelle regioni di malaria lungo le ferrovie. Per esa-minare la legge il Senato costituì una commissio-ne, presieduta da Torelli e composta dagli altri duesenatori Pier Luigi Salomon Bembo, Carlo Verga edai due medici J. Moleschott e D. Pantaleoni.
Bembo era stato uno dei protagonisti della vitaamministrativa a Venezia prima e dopo la cadutadel dominio austriaco (Franzina 1986).La commissione rivolse una circolare ai Consiglisanitari delle province e il 30 giugno 1882 presen-tò la sua relazione che accompagnava la Carta dellamalaria, “il vero primo passo perché si generi inItalia una convinzione dell’estensione del male edella necessità del rimedio”. Torelli è autore di varie pubblicazioni relative allamalaria ma la più organica è la sua “Carta della mala-ria dell’Italia illustrata” (Torelli 1882).Egli è un critico particolarmente acuto della leggeBaccarini sulla bonifica del 25 giugno 1882. Sullabase della sua esperienza veneziana conosceva beneil ruolo dei consorzi di bonifica. Ne ha colto il ruolodeterminante ai fini della applicazione di tale legge.A proposito della composizione dei consorzi egliscrive: “la gran massa de’ possidenti fu ed è favore-vole tanto più che piccolo è il peso nei singoli comevedesi dai rispettivi redditi” documentati dalla pub-blicazione di Luigi Soriani Moretti “La Provincia diVenezia. Monografia statistica-economica-ammini-strativa. Raccolta e coordinata” (1880-1881). Torelli sottolinea la radicale diversità delle condi-zioni del Mezzogiorno: ”Da parte dell’uomo trovia-mo che vi domina di frequenza la grande proprie-tà, i latifondi. Noi ci troviamo di fronte a condizio-ni opposte e per questa ragione nulla di quello chesi verificò nel Veneto, avvenne nel Mezzogiorno.Lungi dall’esservi società o Consorzi che rimonta-no a secoli passati pochi assai se ne conosconoanche di recente data; questo fatto venne consta-tato da deputati meridionali durante la discussionedella legge delle bonificazioni: ma che havvi di piùnaturale ? Mancò la spinta ad associarsi.” (Torelli1882).Torelli ritiene che la legge Baccarini non darà deirisultati nel Mezzogiorno perché i grandi latifondi-sti non si uniranno affatto nei consorzi di bonifica.La legge al contrario darà ottimi risultati al Nord , esolo al Nord. Egli inoltre sottolinea che nella leggeBaccarini manca completamente qualsiasi riferi-mento alle somme da stanziare per la bonifica.Torelli non si limitò a criticare la legge Baccarinima presentò una sua proposta di legge che con-cedeva ai proprietari di superfici su vasta scala

n.22 / 2009
112
(non minori di tremila ettari) o su piccola scala(minori di tremila ettari) una serie di facilitazioni :il trasporto gratuito giornaliero dei lavoratori, l’e-senzione da ogni dazio di importazione delle mac-chine per la bonifica, l’esenzione della tassa di regi-stro per i contratti di acquisto, l’esenzione dalleimposte per i terreni, l’esenzione dalle imposteerariali per le abitazioni, ecc. Si tratta di una vera e propria legge speciale per ilMezzogiorno, per i latifondisti del Mezzogiornodisposti a bonificare i loro latifondi (Torelli 1882).Durante il periodo bellico 1915-18 i lavori di manu-tenzione delle bonifiche sul territorio friulano eveneto coinvolto nella guerra furono sospesi e leopere della bonifica per larga parte furono distrutte.Gran parte dei miglioramenti effettuati andaronoperduti. I terreni ridiventarono paludosi e si estese-ro le condizioni di paludismo cioè quel complessodi elementi morbigeni che costituivano la ragiond’essere dell’anofele, agente ordinario del trasportodell’infezione malarica e creavano condizioni anti-igieniche generali speciali che diminuivano la resi-stenza organica degli abitanti.La Commissione di studio per la ricostituzioneagraria delle terre invase ancora prima della finedella guerra, in previsione della diffusione dellamalaria, programmò una serie di interventi, con-templati nell’ordine del giorno Caratti, Feruglio,Mazzotto, Piotti, Satin, Del Negro, quest’ultimorelatore (Commissione di studio per la ricostitu-zione agraria delle terre invase 1919).Nel corso delle operazioni belliche erano confluitinei Comuni dell’estuario numerosi soldati amma-lati di malaria provenienti dal Carso, dallaMacedonia e dall’Albania che si aggiunsero agli abi-tanti già colpiti dalla malattia. Dopo l’armistizio del1918 nei paesi si aggiunsero i soldati congedatimalarici.Nel Veneto la provincia più coinvolta era quella diVenezia (Ministero dell’interno 1906). Agli inizi del 1920 il vicepresidente della Provinciadi Venezia, il medico Luigi Picchini cominciò inConsiglio provinciale la sua azione di denunciasulla gravità della diffusione della malaria in 17comuni del Veneziano: Burano, Cavazuccherina -ora Jesolo - , Concordia, Ceggia, Caorle, Fossalta diPortograruaro, Grisolera, Gruaro, Marcon, Meolo,
Musile, Portogruaro, S. Donà di Piave, S. Stino, S.Michele del Quarto, S. Michele al Tagliamento,Torre di Mosto (Quaderno mensile Istituto federa-le di credito per il risorgimento delle Venezie1922).Picchini confrontò la situazione verificatasi nel 1919-20 con quella del biennio 1914-15.Nel biennio 1919-20 i casi di malaria erano passati daun totale di 12.520 a 64.820 casi. E poiché gli abitantierano 91.520 la percentuale degli ammalati di mala-ria era aumentata dal 13,6 al 70,8. Il Comune con lapiù estesa morbilità era quello di Burano. A SanDonà di Piave, il Comune di appartenenza di SilvioTrentin, i 610 casi del 1914 e i 590 casi del 1915erano diventati 2.500 nel 1919 e 2.600 nel 1920.Nel 1919 e ancor più nel 1920 la malaria, per ilnumero di casi e gravità di infezione, assunse pro-porzioni rilevanti in comuni dove prima o non eraesistita o era eccezionale.Le forme malariche diffuse nel biennio 1919-20appartenevano alle febbri estive-autunnali (da mag-gio a novembre) ed erano dette maligne.Nel biennio 1914-15 i morti per malaria furono 4ma nel 1919-20 diventarono 115.La forma predominante della malattia era quelladella malaria “inveterata” che, se guarita, lasciavanell’organismo delle lesioni profonde.Già nel febbraio 1920 Picchini denunciò inConsiglio provinciale, trovando scarse adesioni, lamancanza di quel complesso di misure curative,igieniche e profilattiche, che erano richieste dalladiffusione del male in previsione di quanto sareb-be successo nei mesi da maggio a novembre.Nel gennaio 1921 si recarono in visita a Venezial’on. Luigi Luzzatti e l’on. Giovanni Raineri, mini-stro delle Terre Liberate e nell’assemblea estesa aisenatori, ai deputati, ai rappresentanti dei Comunie dei Consorzi di bonifica, Picchini risollevò conforza il problema della malaria in chiave molto cri-tica nei confronti del ministero ricevendo l’appro-vazione del ministro. Forte di tale consenso,Picchini, il 31 marzo 1921, in consiglio provinciale,svolse una relazione documentata ed organica sullaquestione della malaria chiedendo, con urgenza,dei provvedimenti in previsione della diffusionedella malaria nei mesi da maggio a novembre.Secondo Picchini, nel 1919 e specialmente nel

Elio Franzin Silvio Trentin e la nascita dell’Istituto autonomo
113
1920 era avvenuto che, anche in località dove lamalaria non era mai esistita o era stata eccezionale,essa aveva assunto proporzioni rilevanti per nume-ro di casi e per gravità di infezione. Per esempio,San Donà di Piave centro non aveva avuto malariae così gran parte del suo territorio posto più aponente; ebbene non soltanto tutto il Comunedivenne malarico, ma precisamente in quella parteove la malaria era rara o importata nel 1920 il 40per cento della popolazione era stata colpita dallamalattia. San Donà aveva avuto 20 morti.Nella grande maggioranza dei casi si trattava di feb-bri estive-autunnali dette maligne.Picchini chiese il soggiorno dei bambini in asili, lalimitazione dell’impiego nei mesi da maggio anovembre degli operai indenni da infezione palu-stre e provenienti da paesi non malarici, la diffu-sione di propaganda antimalarica mediante i par-roci, i maestri, le autorità comunali, l’istituzione diun servizio sanitario comunale.Il discorso di Picchini non si limitò a chiedere unmaggiore e più articolato intervento in materia dilotta antimalarica. Esso conteneva degli elementimolto critici nei confronti della politica antimalari-ca tradizionale. La legislazione sulla bonifica cheprevedeva dei finanziamenti pubblici, statali e loca-li, molto favorevoli ai proprietari terrieri avevamotivato le opere di bonificazione di prima cate-goria con il “grande miglioramento igienico” o il“rilevante vantaggio igienico”.Questo era l’obbiettivo dichiarato già della leggeBaccarini del 25 giugno 1882 n. 869 (Gazzetta uffi-ciale 21 luglio 1882, n. 170).Ma le grandi bonifiche finanziate soprattutto dalloStato e dagli enti locali si sono dimostrate insuffi-cienti rispetto a tale scopo.Picchini mise in luce che il miglioramento o van-taggio igienico dipendeva anche dalle opere dellapiccola bonifica e cioè da quelle di seconda cate-goria. La bonifica idraulica o agraria non avevacomportato automaticamente la bonifica igienica. Iproprietari terrieri non si curavano di far funziona-re le macchine idrovore specialmente durante imesi da maggio a novembre in modo da provoca-re il movimento e il ricambio dell’acqua nei canalicollettori. Da ciò la diffusione delle zanzareAnopheles causa della malattia.
La piccola bonifica era stata ed era completamentetrascurata o non mantenuta.Nel caso che i proprietari terrieri non provvedes-sero ad essa, Picchini chiese l’intervento di squa-dre di operai alle dipendenze dei Comuni, delleProvince, del Genio civile o del Magistrato delleacque.Egli sottolineò la diversità della bonifica idraulica eagraria da quella igienica mettendo in discussionela coerenza della legislazione sulla bonifica rispet-to al suo obbiettivo dichiarato, la bonifica igienica,e quindi criticando il comportamento dei proprie-tari terrieri rispetto ai fittavoli e ai braccianti.Elemento centrale della condizione dei fittavoli odei salariati erano le abitazioni che si trovavanoancora in pessime condizioni. A San Donà di Piave,per esempio, la maggior parte della popolazioneviveva in baracche che non consentivano la prote-zione meccanica contro l’anofele.Molto grave era anche la situazione in materia diacqua potabile. Picchini chiese la realizzazione dinuovi acquedotti.Dopo il dibattito svoltosi nel Consiglio provincialeveneziano il 31 marzo 1921 e coerentemente conl’orientamento da esso approvato, in seguito aduna successiva assemblea aperta a tutte le autoritàlocali, fu creato un comitato istitutivo di un enteantimalarico autonomo rispetto agli organi statali.La linea emergente era quella del federalismoantropologico o interattivo che non si opponefrontalmente agli organi statali ma, constatate leloro carenze, individua istituzioni e comportamen-ti alternativi.Secondo Trentin, l’istituzione dell’Ente autonomoper la lotta antimalarica nelle Venezie sarebbe statadovuta “alla geniale idea di Luigi Luzzatti, al tenaceapostolato di Luigi Picchini ed alla illuminata muni-ficenza del ministro Raineri” (Trentin 1984).Nell’ambito del comitato Silvio Trentin formulò lostatuto dell’erigendo ente locale antimalarico chefu inviato al ministro delle Terre liberate, GiovanniRaineri.Immediatamente arrivarono i contributi finanziaridella Cassa di Risparmio di Venezia, dell’Istitutofederale di credito per il risorgimento delleVenezie, dell’Opera pia Bonomelli, dell’Ente diricostruzione e rinascita agraria di Treviso, della

n.22 / 2009
114
Provincia di Venezia, della Federazione dei consor-zi di bonifica (Quaderno mensile Istituto federaledi credito per il risorgimento delle Venezie 1922);Zalin 1993)Il 22 gennaio 1922, alla presenza del ministroRaineri, si svolse una riunione del comitato pro-motore in cui fu approvato lo statuto proposto daSilvio Trentin. Gli scopi del nuovo ente sono labonifica umana, idraulica, forestale, agraria e la pic-cola bonifica accanto al miglioramento economi-co-sociale.Picchini fu eletto presidente e vicepresidenti risulta-rono Max Ravà come rappresentante dell’Istitutofederale di credito per il risorgimento delle Venezie eSilvio Trentin come rappresentante dell’Ente di rina-scita agraria di Treviso. Il consiglio direttivo era for-mato da rappresentanti delle istituzioni locali fra lequali la Federazione dei consorzi di bonifica e ilMagistrato alle acque. La maggior parte dei Comuniveneziani aderì al nuovo ente antimalarico.Una nuova riunione si svolse il 25 febbraio del1922. Trentin intervenne affermando l’inopportu-nità di un contributo unico di iscrizione per tuttele province delle Venezie, importante era ottenerela loro adesione. Egli riteneva che dovessero par-tecipare i Comuni, gli istituti di credito, i consorzidi bonifica, gli agricoltori privati. Inoltre informòsulle quote già ottenute dai vari enti locali pubbli-ci e privati.Nei giorni dal 23 al 25 marzo del 1922, su iniziativadell’Istituto federale di credito per il risorgimentodelle Venezie, si svolse a San Donà di Piave ilCongresso regionale veneto delle bonifiche.Secondo Picchini, esso “fu una delle prime manife-stazioni delle iniziative” del nuovo istituto antima-larico.La relazione di Trentin ebbe come titolo “La boni-fica umana scopo essenziale della bonifica idrauli-ca ed indispensabile della bonifica agraria”(Trentin 1984).Il titolo riassume la tesi in essa sostenuta daTrentin della priorità della bonifica igienica rispet-to a quella idraulica ed agraria.La denuncia espressa da Picchini già il 31 marzo1921 nel Consiglio provinciale veneziano vieneripresa e sostenuta da Trentin in modo molto piùampio ed organico.
Fin dall’inizio Trentin rileva come ai bonificatorifosse mancata una informazione adeguata sullaefficacia dei loro interventi rispetto al migliora-mento o al vantaggio igienico che era l’obbiettivoprimario della legge Baccarini del 25 giugno 1882(Gazzetta ufficiale 21 luglio 1882, n.170).Egli si pone la domanda se il legislatore abbiaavuto nel giugno 1882 la conoscenza degli ele-menti dai quali dipendeva la realizzazione dell’ob-biettivo.E risponde che la legge Baccarini aveva avuto unapercezione esatta dei bisogni ma soltanto “da unpunto di vista astratto e programmatico”.Secondo Trentin il pubblico interesse era coinvol-to soltanto quando l’obbiettivo era quello del risa-namento igienico. Il problema della bonifica eraconcepito giustamente dalla legge Baccarini comeproblema di risanamento igienico.Ma sulla base dell’esperienza delle operazioni dibonifica eseguite, è accertato che si sono ottenutedelle conduzioni agrarie “anche là dove tristi epericolose continuano a sussistere le condizioniigieniche”.Nella pratica dei proprietari terrieri si è verificatauna dissociazione fra la bonifica agraria e quellaigienica.Retoricamente Trentin si rivolge ai proprietari ter-rieri affermando di ritenere che nessuno di lorovoglia attribuire la qualifica di opere di bonifica aquella che “sacrifica la sacrosanta tutela della salu-te del lavoratore, costretto a scontare con le malat-tie o anche la morte la incoscienza o la malvagitàdi tecnici ignoranti o di avidi speculatori”.Egli antepone il risanamento igienico alla bonificaagraria. Ed aggiunge che se la bonifica agraria voles-se prescindere dal risanamento igienico “essadovrebbe conseguirsi a troppo caro prezzo: qualchevolta a prezzo del sangue”.La storia del litorale veneziano è stata tragica. Essaè un vero e proprio martirologio. Egli cita il casoraccontatogli dal parroco di Cesarolo, una frazionedel comune di S. Michele al Tagliamento dove iregistri parrocchiali documentavano la morte pre-matura dei contadini dovuta alla malaria.L’obbiettivo della legge Baccarini il “grande miglio-ramento o rilevante vantaggio” igienico è statoattribuito alle opere di bonifica di prima categoria.

Elio Franzin Silvio Trentin e la nascita dell’Istituto autonomo
115
E per quelle di seconda categoria? Trentin rispon-de che, sulla base degli artt. 1 e 2 del Testo unico22 marzo 1900 (Gazzetta ufficiale 18 giugno 1900,n. 141), la tutela sulle opere di bonifica affidata alloStato riguarda ambienti non igienici.Lo scopo igienico è inseparabile da qualsiasi opera dibonifica di prima o di seconda categoria.Il giudizio di Trentin sui principi generali della legisla-zione di bonifica è sostanzialmente positivo.Indubbiamente si tratta di un giudizio molto inge-nuo di un uomo politico e di uno studioso che hauna immagine eccessivamente positiva dello statounitario prefascista cosiddetto liberale, molto menorealistica di quella di Torelli.Lo salva la sua esperienza di vita a San Donà doveera difficile non vedere i risultati reali di tanti finan-ziamenti pubblici concessi ai proprietari terrieridelle bonifiche e quindi i costi enormi pagati daicontadini dovuti alla diffusione della malaria.Ma nella seconda parte della sua relazione egliaffronta realisticamente la questione delle “prati-che garanzie” con le quali si sarebbe dovuto assi-curare la piena efficacia dei principi igienici affer-mati nelle leggi sulla bonifica.Il giudizio negativo è esplicito. “È bene dire subitoche alla bontà delle intenzioni, che alla chiaracoscienza dei bisogni e dei doveri, non corrispose-ro in pratica i risultati che era legittimo attendere”(Trentin 1984)Trentin è un uomo vissuto in un territorio di paludi edi laguna, dove evidentemente non si è limitato adandare a caccia in barca (Ronchi 1975).Quali sono le ragioni dell’inefficienza della legisla-zione sulla bonifica secondo Trentin?Il Governo ha escluso qualsiasi tutela ed ispezio-ne, qualsiasi ingerenza della pubblica autorità nellearee delle bonifiche private. Si tratta delle bonifi-che non classificate. Quindi non esiste nessun con-trollo sui proprietari terrieri che non ricevonofinanziamenti pubblici.Inoltre il controllo da parte dello Stato viene giu-stificato non in rapporto agli scopi generali dellalegislazione ma al concorso finanziario dello Stato.In pratica “Il proprietario privato che è lasciatoarbitro, quando ne sopporti completamente ilcosto, di regolare la trasformazione a coltura deipropri fondi paludosi, può facilmente essere trat-
to, come l’esperienza insegna, ad anteporre adogni suo dovere l’appagamento egoistico del desi-derio di derivare dalla propria terra, col minor pos-sibile dispendio, i maggiori possibili profitti”.Il proprietario terriero “resterà spesso indifferente aibisogni che si manifestano sotto l’aspetto igienico”. All’obbiezione che al raggiungimento dell’obbietti-vo igienico è funzionale la legislazione sanitaria,Trentin obbietta che: “e’ anche vero che l’organiz-zazione dei servizi all’uopo predisposti dalla leggeè ancora incompleta e inadeguata allo scopo”.In conclusione Trentin crede: ”che sia assoluta-mente necessario di reclamare su questo puntouna riforma della legislazione (sulla bonifica e sani-taria, n.d.r.) per la quale venga imposto, a chiun-que intende eseguire sui propri fondi un’opera dibonifica, l’obbligo di presentare preventivamenteai competenti uffici, il progetto dei lavori”.Il progetto sarà approvato solo dopo l’emanazionedell’ordine di un controllo tecnico rigoroso duran-te l’esecuzione dei lavori e anche durante il loroesercizio in funzione dell’obbiettivo igienico.Questa riforma legislativa presuppone la riorganiz-zazione dei servizi. La tutela della pubblica salute èuna gelosa prerogativa dello Stato.Sullo sfondo vi è “la figura ripugnante dell’affaristaavido ed incompetente, di null’altro sollecito chedi sfruttare a proprio vantaggio la tolleranza delleleggi e la remissività o i bisogni dei coltivatori”.Trentin prende in esame poi le bonifiche classifi-cate cioè quelle realizzate con il concorso deifinanziamenti pubblici.Il sistema deve essere rinnovato in molte delle sueparti.Dato il livello della scienza medica nel 1882 “il com-pito dell’igienista venne a perdere, nell’ordinamen-to creato dalla legge, ogni sostanziale importanza”.Si esclusero speciali provvidenze oltre all’operaidraulica considerata sufficiente per realizzare ilmiglioramento o il vantaggio igienico. Si trattava diun criterio ispiratore molto grossolano.Non è prevista la partecipazione di nessun tecnicoigienico alla elaborazione dei progetti di bonifica. La vigilanza tecnica sulla esecuzione e sulla con-servazione delle opere consorziali si esercita dalloStato esclusivamente mediante gli uffici del Geniocivile.

n.22 / 2009
116
Il principio direttivo fissato per la redazione deiprogetti di bonifica si fonda sul concetto che leopere devono raggiungere lo scopo della bonificacon la spesa minima.Ai promotori di un consorzio di bonifica vieneattribuita la facoltà di tener conto, nei progetti tec-nici, delle opere relative alla provvista di acquapotabile “ma nello stesso tempo viene fatto lorodivieto di comprendere la spesa conseguente allaesecuzione di queste nel preventivo generale”.Lo Stato non aveva previsto che i lavoratori agricolibevessero acqua potabile di acquedotto!La prima legislazione sull’approvvigionamentoidrico è del 1911 (Trentin 1984).Secondo Trentin, “l’erroneo apprezzamento deimezzi richiesti “ dalla bonifica igienica ha portatoalla realizzazione di opere che “spesso si appalesa-rono elementi perturbatori e peggioratori delle con-dizioni igieniche preesistenti”.Egli cita il giudizio di un insigne malariologo comeSella sui canali come paludi rettilinee in sostituzionedi quelle naturali ma con gli stessi effetti negativisulla salute dei lavoratori agricoli.Afferma che uno dei compiti dello Stato è quello didifendere la salute di tutti i cittadini.Trentin esalta il contributo di insigni malariologicome Giovanni Battista Grassi, Amico Bignami,Giuseppe Bastianelli, Guido Baccelli, EttoreMarchiafava, Vittorio Ascoli, Angelo Celli, CamilloGolgi (premio Nobel per la medicina).E aggiunge :”bisogna confessare che la conoscenzadelle preziose verità disvelate da questi studipazienti e geniali non servì a determinare un suffi-ciente rinnovamento nei mezzi impiegati dallo Statoper assolvere in questa materia ai propri compiti enell’indirizzo della legislazione”. La critica allo Statocentralista è netta.Egli non considera esaurienti i provvedimenti pre-visti nelle leggi del 23 dicembre 1900, del 2 novem-bre 1901, del 22 giugno 1902.E rileva: ”che nessun coordinamento essi si sonopreoccupati di garantire fra i servizi per loro mezzoistituiti e le attività dirette a creare la grande opera dibonifica. Non solo ma essi hanno avuto anche ilgrave difetto di restringere quasi in forma esclusivaogni azione dello Stato al compito di eccitare, di aiu-tare, di imporre la cura dell’uomo, trascurando in
sostanza il metodico e rigoroso risanamento del-l’ambiente. Questo difetto appariva poi, aggravatodalla scarsezza dei mezzi, dalla insufficienza dell’or-ganizzazione, dalla rigidezza delle direttive adottateper raggiungere lo scopo”.Trentin chiede di abbandonare “il vecchio malaugu-rato sistema delle timide esperienze, delle caute diffi-denze, delle prudenti economie”.Egli invoca la necessaria autonomia dei tecnici.Cita le esperienze antimalariologiche di AntoninoPais e della stazione radioterapia di San Donà diPiave e di Portogruaro.La legislazione antimalarica “pur sotto tanti aspetticommendevole” non ha raggiunto i risultati attesi.Trentin guarda alla “pratica organizzazione “ deiservizi molto carente.Le leggi contro la malaria “risultarono completa-mente inefficaci” nei riguardi del risanamento del-l’ambiente. Le opere di piccola bonifica previste inmodo obbligatorio sono rimaste lettera morta. Leopere di grande bonifica continuano ad esserecostruite prescindendo dall’obbiettivo igienico.Il legislatore dimostrò sempre la più completaindifferenza riguardo all’obbiettivo igienico.Trentin elenca dettagliatamente le norme darispettare: tenere lontani dai centri abitati i collet-tori; attuare il prosciugamento delle zone limitrofedell’abitato; rimuovere gli ostacoli al deflusso delleacque stagnanti; attivare il movimento delle acque;sistemare le sponde dei bacini marini, lacustri, flu-viali e palustri; abbassare le falde delle acque sot-terranee dove arrivino troppo vicine al suolo.Ribadisce la “necessità di urgenti profonde trasfor-mazioni nell’ordinamento” legislativo.Egli cita la relazione di Giuseppe Badaloni del 1910al Consiglio superiore di sanità; nella quale relazio-ne, questi aveva invitato a guardare alle condizionidi vita delle popolazioni. Nel marzo 1922 Trentin è ancora un borghese, un“bourgeois” di campagna, un proprietario terriero,che ritiene inattuabile l’obbligo dello Stato “ di prov-vedere in forma diretta al miglioramento del regimedi vita proprio dei lavoratori quotidianamente operiodicamente esposti agli assalti della malaria”.Ma nello stesso tempo afferma, come “citoyen”,con forza, “il diritto di questi lavoratori stessi a tro-vare nella legge la garanzia che a nessun patto, per

Elio Franzin Silvio Trentin e la nascita dell’Istituto autonomo
117
qualsiasi ragione, possano essere violate le esigen-ze elementari della loro salute”.Questo è un principio che ha valore assoluto.Non si accontenta affatto dei sussidi statali per lecucine economiche e per gli asili antimalarici.Denuncia la non organicità di questo tipo di inter-vento il quale “non ha attinenza con le attività piùessenziali che in questo campo occorre svolgere”.Lo Stato ha il dovere di assumere una forza impe-rativa nell’accertamento delle condizioni minimeper la regolarità della vita dell’uomo, per la soddi-sfazione dei suoi bisogni fondamentali.E fra i bisogni fondamentali delle popolazioni vi èquello della fornitura di acqua potabile.La legge in vigore esclude espressamente la possi-bilità di comprendere, nel contributo statale pre-visto per il progetto di bonifica, le opere per l’ali-mentazione idrica.Contro questa norma vi sono delle autorevoli pro-teste. È “uno dei vizi fondamentali della legge”.Egli cita l’esempio del Consorzio Ongaro inferioreche ha potuto realizzare l’acquedotto grazie allacollaborazione di molti comuni e dei consorzi dibonifica del Basso Piave. Un altro acquedotto staper essere finanziato grazie al Comune di SanDonà di Piave.Infine egli chiede ai partecipanti al congresso diapprovare un voto al governo di Roma dove si stasvolgendo l’istruttoria del progetto “con la tradi-zionale esasperante lentezza”.Avviandosi alla conclusione della sua relazioneTrentin enuncia i tre elementi della riforma richiesta:- la riorganizzazione su base regionale degli ufficitecnici statali competenti per la bonifica con l’at-tribuzione di larghi poteri delegati. Si tenga pre-sente che a quell’epoca Trentin era ancora ostilenei confronti della creazione delle regioni sostenu-ta per esempio da Oliviero Zuccarini sulla rivista“Critica politica”. Egli sostiene la necessità del decen-tramento mediante l’istituzione di enti autonomi;- l’attribuzione all’igienista di funzioni importantinelle operazioni di collaudo delle opere di bonifi-ca nella quale bisogna comprendere la fornitura diacqua potabile. I consorzi devono avere il compitodella esecuzione della piccola bonifica. Trentin citaun disegno di legge preparato dal Gabinetto di I.Bonomi, un politico per il quale ha sempre mante-
nuto una speciale venerazione;- il coordinamento della lotta antimalarica deveessere garantito mediante l’istituzione di appositienti regionali.Trentin conclude la relazione citando FilippoTurati e presentando un organico ordine del gior-no articolato in sette punti.La relazione non era fatta certo per piacere ai pro-prietari terrieri come Angelo Sullam che immedia-tamente la attaccò nel suo intervento. Sullam sidichiarò contrario a “quella autorità che ora l’on.Trentin vorrebbe porci tra i piedi”. Egli dichiarò lasua netta opposizione agli articoli 3 e 7 dell’ordinedel giorno Trentin nei quali era richiesto: all’arti-colo 3 ”che la tutela e l’ispezione del Governo dicui all’art.1 del T.U. 22 marzo 1900 sia estesa anchealle bonifiche private la cui esecuzione dovrà esse-re subordinata alla approvazione preventiva del-l’apposito progetto ed il cui esercizio e la cuimanutenzione dovranno essere costantementecontrollati; all’articolo 7 che la malaria sia conside-rata a tutti gli effetti di legge come infortunio sullavoro e che i proprietari terrieri siano chiamatiresponsabili per le febbri contratte dai propri lavo-ratori quando risultino inadempienti a determina-te misure profilattiche” (Trentin 1984).Secondo Sullam, Trentin stava infierendo sui boni-ficatori (Lazzarini 1995).Alle tesi sostenute da Trentin aderì il rappresen-tante dell’Istituto antimalarico di Roma. Il deputa-to socialista di Monselice Angelo Galeno affermò:”I possessori privati, sieno essi soli od uniti in con-sorzio, hanno naturalmente approfittato dellaaccondiscendenza delle leggi e del Governo perottenere bensì la bonificazione, ma anche e più unbeneficio a se stessi”.Intervenne anche Luigi Picchini, allora presidentedel Consiglio provinciale di Venezia, sostenendo leesigenze della bonifica igienica presentando unordine del giorno a favore dell’acquedotto per iComuni del Basso Piave.Camillo Valle, presidente della Federazione nazio-nale delle bonifiche, che diventò poi podestà fasci-sta di Portogruaro, intervenne in difesa del gover-no. Egli, tuttavia, al convegno sostenne la necessi-tà della costruzione degli acquedotti nelle zone dibonifica. E chiese la modifica degli articoli 1, 3 e 7

n.22 / 2009
118
dell’ordine del giorno di Trentin.Infine intervenne Giuseppe Cecchetti delSindacato agricolo industriale di Padova che invitòi lavoratori della terra a considerare i bonificatoricome amici e alleati.Nella replica Trentin rivendicò il suo interesse“non da oggi soltanto” ai problemi della bonifica. Erispose punto per punto, in modo documentato econvincente, alle critiche rivoltegli anche sul pianopersonale da Angelo Sullam.Intervenne Attilio Mazzotto presidente deiConsorzi di bonifica riuniti del Basso Piave. Almomento della votazione, l’articolo 3 dell’ordinedel giorno relativo alla tutela e alla ispezione delGoverno sulle bonifiche private fu respinto. Laseconda parte dell’articolo 7 relativa alla responsa-bilità dei proprietari per la malaria contratta dailavoratori quando essi risultavano inadempienti allaadozione delle misure profilattiche fu stralciata.I risultati del congresso del marzo 1922 non furo-no particolarmente favorevoli a Trentin. Anzi. Ilcongresso regionale sulle bonifiche del marzo1922 fu un momento importante nella storia dellebonifiche. Fra i suoi relatori vi fu Arrigo Serpierifuturo ministro dell’agricoltura di Mussolini e fra ipartecipanti anche don Luigi Sturzo, il segretariodel Partito popolare italiano.Successivamente al congresso, Trentin, come vice-presidente dell’istituto, partecipò alle ispezioniche si svolsero a Cavarzere-Chioggia e a Burano,Treporti, Mesole.In una riunione dell’Istituto antimalarico che sisvolse il 22 luglio 1922, Trentin intervenne sottoli-neando che lo Stato svolgeva una azione antimala-rica ma che essa era fiancheggiata dagli enti pubbli-ci dove la malattia era più sviluppata. Egli si dimo-strò preoccupato che il nuovo ente ottenesse ade-sioni nelle province di Udine, di Verona, di Venezia,di Rovigo. Inoltre propose lo scambio dei piani diazione fra i vari comitati provinciali dell’Ente.Nel 1922 lo squadrismo agrario come fenomeno dimassa aveva completamente egemonizzato il fasci-smo urbano piccolo borghese di ispirazione radi-caleggiante (Franzinelli 2003).La marcia su Roma e la formazione del governoMussolini crearono delle condizioni in cui l’eserci-zio dell’insegnamento diventò impossibile per
Trentin.Nel febbraio 1926 Trentin emigrò con la sua fami-glia in Francia. Trentin rimase legato anche in Francia al temadella bonifica. Dal settembre 1938 al marzo 1939egli ha pubblicato su “Giustizia e libertà” un saggiomolto documentato sulla bonifica integrale e sullapolitica agraria fascista in cui ha ricordato il con-gresso di San Donà del marzo 1922 e l’ostruzioni-smo svolto nei confronti delle sue proposte da“una grossa pattuglia di fascisti”.Il suo pensiero politico ha avuto una notevole evo-luzione rispetto alle posizioni liberali degli anniprecedenti l’avvento del fascismo e anche delprimo periodo della emigrazione ma già nel marzo1922 Trentin ha espresso una posizione solidale neiconfronti dei lavoratori agricoli che si distinguevanettamente per la radicalità della sua affermazionee della sua difesa dei diritti della persona umana.Con la relazione del marzo 1922 Trentin esponeuna critica positiva, umanistica e realistica di unodei rapporti sociali della società borghese, quellofra i proprietari terrieri o gli agrari e i lavoratoriagricoli.Alla base del saggio del 1933 Antifascismo e rivolu-zione, con il quale Trentin ha espresso la sua criti-ca sia al capitalismo che al sistema sovietico e la suaconversione al federalismo, vi è la nozione dell’au-tonomia dell’essere umano e la convinzione chel’autonomia può attuarsi attraverso l’emancipazio-ne specificamente economica. Una emancipazioneper la quale Trentin aveva espresso la sua forte sen-sibilità assumendo già nel marzo 1922 la difesa deilavoratori agricoli contro i proprietari terrieri.
Riferimenti bibliografici
AA.VV. (1824), Risultamenti dall’amministrazio-ne di una china ricolorata per la cura delle feb-bri accessionali anco d’indole perniciosa,Padova.BENVEGNU’ Francesca e Lorenza MERZAGORA(2000), Mal aere e acque meschizze, Mazzanti &editori, Mestre Venezia. CAMPOS, Elsa (1937), I Consorzi di bonifica nellaRepubblica veneta, Padova, Cedam. CARAZZI, Domenico (1912), I problemi della

Elio Franzin Silvio Trentin e la nascita dell’Istituto autonomo
119
malaria, Milano.CAROCCI Giampiero (1956), Agostino Depretis ela politica interna italiana dal 1876 al 1887,Torino, Einaudi.COMPARETTI, Francesco (1793), Riscontri medicidelle febbri larvate perniciose, Padova; COMPARETTI, Francesco (1795), Annotazionidirette ai lettori dei riscontri medici delle febbrilarvate periodiche perniciose, PadovaCORTI, Paola (1984), “Malaria e società contadinanel Mezzogiorno”, Storia d’Italia, Annali 7,Einaudi, Torino.FRANZINA, Emilio (1986), Venezia, Bari, EditoriLaterza. FRATINI, Fortunato (1899), La profilassi telluricadella malaria, Feltre.GANGEMI, Giuseppe (1994), La questione federa-lista Zanardelli, Cattaneo e i cattolici bresciani,Torino, Liviana. GANGEMI, Giuseppe (2000), La linea veneta delfederalismo, Roma, Gangemi editore. GUERRATO, Moreno ( 1981), Silvio Trentin undemocratico all’opposizione, Milano.LAZZARINI, Antonio (1995), Fra terra e acqua.L’azienda risicola di una famiglia veneziana neldelta del Po, Edizioni di storia e letteratura, Roma. MILLIONI, Luigi (1921), Le iniezioni endovenosedi chinino nella cura della malaria, Padova.MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORE-STE (1974), Bonifica e programmazione nelVeneto, Venezia.MINISTERO DELL’INTERNO, Direzione generaledella sanità pubblica (1906), Elenco delle zonemalariche delimitate a tutto il febbraio 1906,Roma.NOLTE, Ernst (1966), I tre volti del fascismo,Azzarate, Sugar editore, pp. 376-377.
OMIZZOLO, Antonio (1904), Osservazioni sullaprofilassi e la terapia della malaria nel comunedi Camisano Vicentino, Roma.PALUELLO, Carlo (1900), Note igieniche sul pro-gettato ponte lagunare con particolare riguardoalla malaria, Venezia.PESERICO, Luigi (1905), Intorno ad alcune formamediche di malaria,Venezia.ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO PER IL RISOR-GIMENTO DELLE VENEZIE (1922), Quaderno n.11, novembre.REMONDINI, Giuseppe (1785), Istruzioni medi-che per le genti di campagna, Venezia-Padova,1785, p. 32.RONCHI, Vittorio ( 1975), Silvio Trentin ricordi epensieri 1911-1926, Edizioni Canova, Treviso, p. 5. ROSENGARTEN, Franck (1980), Silvio Trentin dal-l’interventismo alla Resistenza, Milano, Feltrinelli.SCORTEGAGNA, F. Orazio (1822), Storia medicariguardante un caso singolare d’una febbre lar-vata perniciosa letargica osservata, Padova.SNOWDEN, Frank M. (2000), La conquista dellamalaria, Torino, EinaudiTORELLI, Luigi (1882), Carta della malariadell’Italia illustrata, FirenzeTRENTIN, Silvio (1984), Politica e amministrazio-ne, Venezia, Marsilio editori.TORELLI, Luigi (1882), Carta della malaria illu-strata, Firenze; TORELLI, Luigi (1883), La malaria d’ItaliaMemoria popolare, RomaVIVANTE, Renato (1902), La malaria in Venezia,Venezia.ZALIN, Giuseppe (1993), “L’Istituto federale di cre-dito per il risorgimento delle Venezie nel primodopoguerra”, Archivio Veneto, s.V, a. CXXIV, n.176, Venezia 1993, pp, 109 – 136.

n.22 / 2009
120
Ventennio post-Unità: “tempi di prova” per laChiesa. I toni elevati della voce intransigente con-tro l’invadenza dello Stato liberale coprono il lavo-rio sommesso delle chiese locali. Si sta costruendoquella “filigrana secolare e complessa” su cui, qual-che tempo dopo, si adagerà l’apparato di un parti-to cattolico di massa (Scalco, 2007). Per lo studiodi questo argomento il giornale La Fede, pubblica-to a Chioggia dal 30 gennaio 1876 (anno I, n. 1) al25 gennaio 1880 (anno V, n. 4) e di recente ristam-pato in copia anastatica, rappresenta un’importan-te fonte di documentazione del formarsi di quelmodello identitario e organizzativo aderente alladefinizione di “ subcultura politica territoriale” uti-lizzata per spiegare lo stesso processo anche inaltre realtà territoriali (Scalco, 2007). Pertanto,dopo una rapida carrellata sui contenuti principalidel giornale, focalizzeremo in sequenza tre ele-menti strutturali del modello in considerazione:relazioni, rappresentanza, appartenenza.
La Fede, una visione d’insieme
La Fede uscì a quattro pagine per iniziativa della“Società per la Santificazione delle feste”, un soda-lizio fondato con l’approvazione del vescovo il 30agosto 1872, in seguito agli orientamenti emanatidall’ “Opera dei Congressi e dei Comitati cattolici”.Il vescovo Domenico Agostini, che guidò la dioce-si dal 1871 al 1877 per passare poi alla sede patriar-cale di Venezia, favorì direttamente la pubblicazionedel settimanale che già nel “Programma”, reso notoil 1° dicembre del 1875, si proponeva di “ravvivare la
fede cattolica negli animi cristiani, onde resistanoall’urto della moderna incredulità”. Una prospettiva, quindi, chiaramente sulla lineadel cattolicesimo cosiddetto intransigente, chemirava prima di tutto all’“istruzione religiosa”. Ilperiodico veniva redatto nell’ambito del Seminariovescovile di Chioggia, che offriva una base cultura-le di notevole spessore, e in quello dellaCongregazione dei padri Filippini, presenti aChioggia fin dal 1752, punto di riferimento perl’ortodossia della fede e per l’incisività della vitaspirituale (Aldrighetti, 2008). La Fede, che nelprimo anno – diretta dal padre filippino AndreaTobia Voltolina mantenne un’impronta essenzial-mente religiosa, si aprì poi anche in seguito allasuccessione del neodirettore della stessa congre-gazione padre Emilio Venturini, già collaboratore– ad una attenta ed efficace discussione sui pro-blemi sociopolitici locali e nazionali. Di fatto, finoal 21 gennaio 1877 il giornale uscì – come riferito– con la qualifica di “periodico settimanale pro-mosso dalla Società per la santificazione dellefeste”; da allora assunse il sottotitolo più essenzia-le, ma anche più globale e più ambizioso, di “perio-dico religioso, scientifico e politico” che mantennefino al 28 dicembre 1878, per assumere infine quel-lo ancora più esplicito di “periodico cattolico poli-tico”.In occasione delle elezioni politiche del 1877 il
settimanale cattolico chioggiotto appoggiò il “nonexpedit” (cioè il rifiuto al coinvolgimento politicodei cattolici in seguito alla presa di Roma) procla-mato da Pio IX ed invitò esplicitamente i lettori a
Gina Duse
Stampa intransigente e nascita di un modelloidentitario. L’esempio del giornale “La Fede” a Chioggia
Il sestante

Gina Duse Stampa intransigente e nascita di un modello identitario
121
disertare le urne: il che provocò – caso che fecescalpore anche a livello nazionale – il sequestrodel numero che conteneva il trafiletto intitolato“Viva Pio IX”. Il settimanale, tuttavia, come accen-nato, si dimostrò maggiormente aperto al dialogoe al coinvolgimento in occasione delle successiveelezioni amministrative, auspicando e promuoven-do la presenza dei cattolici nella vita pubblicachioggiotta. Il foglio così andò acquistando sem-pre più autorevolezza in città e nel territorio,soprattutto per la sua capacità di proposizionedecisa dei propri ideali e di penetrazione efficacenelle questioni quotidiane della gente, diventando,oltre che strumento di propagazione della dottrinacattolica, in difesa del papa e dell’ortodossia, fogliodi rivendicazione dei diritti dei più deboli controgli abusi o le inadempienze della pubblica ammini-strazione.Quel che si coglie in modo speciale in questo set-
timanale chioggiotto, anche al di là della tipicaposizione “intransigente” (che, comunque, ritene-va di avere le sue buone ragioni) è la qualità del-l’approccio, riflessivo e operativo insieme, la capa-cità di trasmettere ai lettori e alla cittadinanza l’im-portanza di relazioni e legami comunitari da ricer-carsi e costruirsi a beneficio della crescita civile. Latestata cattolica riesce ad integrare in modo effica-ce e apprezzato l’informazione con la formazione,obbedendo, del resto, al diffuso principio dellamissione educativa della stampa, ma allo stessotempo costituendosi come strumento di comuni-cazione a più largo raggio. Nella vasta raccolta, cheassomma a circa ottocento pagine, si intreccianoinsieme il tema dell’identità della città e quellodella preparazione della classe dirigente cittadinaad affrontare le difficoltà della politica, quello dellacritica allo Stato centralizzato e quello dell’efficaciadi un’azione di rete tra Stato e corpi particolari vici-ni alla vita della gente quale risultava la Chiesa, benradicata nel territorio.Emerge dal foglio la realtà di uno Stato – appan-naggio del pensiero liberale, contrario alla veralibertà che sta vessando la Chiesa, la quale, a suavolta, si va ritemprando in una sorta di resistenzache assicura l’unità tra i cattolici. La penna è sfer-zante contro la mediocrità e la pochezza dei mini-stri e dei politicanti liberali, ma non manca di stig-
matizzare anche l’atteggiamento dei cattolici-libera-li (i “conciliatoristi”) che vorrebbero accettare supi-namente la realtà; mentre occorrono un’etica eun’informazione chiaramente contrapposte a quel-le dominanti, contro la complicità instauratasi trastampa e governo e contro anche certa stamparinunciataria, che indulge illusoriamente solo sulletematiche letterarie o scientifiche, restando avulsadai problemi della gente.La Fede parte dalla convinzione che la gente – non-ostante la pressione del regime e nonostante i ten-tativi liberali di imporre un’egemonia culturale èrimasta profondamente cattolica e la cittadinanzalocale sia ancora vicina alla Chiesa; né l’ossequioleale tributato alla monarchia si deve ritenereincompatibile con una devozione autentica al papa.La Chiesa ha al suo interno energie e capacità perrendersi presente anche a livello culturale e stimo-lare una partecipazione efficace alla vita amministra-tiva. Il giornale risponde proprio a questa convin-zione e a questa sfida con una chiara distinzione chenon ammette tentennamenti: assoluta intransigen-za nelle cose religiose, cordiale collaborazione nellequestioni della città con quanti ne ricercano since-ramente la prosperità. Lo stretto rapporto tra il vescovo diocesanoAgostini, ispiratore ideale, e la Società per la santi-ficazione delle feste, promotrice del giornale, assi-cura – insieme al patrimonio culturale garantitodalla gloriosa e solida scuola del Seminario – unfuturo all’iniziativa editoriale varata nel 1875. Il rap-porto con Agostini rimarrà emblematico e profi-cuo anche dopo il passaggio del vescovo alla sedepatriarcale di Venezia avvenuto nel 1878; ma il suc-cessore Ludovico Marangoni non fu da meno nelsostenere, fin dalla sua elezione, il settimanale, checontinuò a dimostrare in modo convincente lospessore anche culturale del clero locale, rivendi-cando alla chiesa il diritto e la capacità di offrireorientamenti, di proporre obiettivi e di promuove-re interventi.Di fatto, il giornale interviene direttamente sullequestioni riguardanti la vita cittadina (come, adesempio, l’ingombrante estuario del Brenta inlaguna e la mancanza di collegamenti ferroviari),dedicando grande attenzione ai bisogni dellagente, difendendo l’immagine della città dalla

n.22 / 2009
122
denigrazione di certa stampa, individuando nellacomponente cattolica culturalmente e socialmentepiù motivata il soggetto più adatto per migliorarela situazione. Per essere sempre più incisivo edefficace il giornale stesso punta ad un migliora-mento progressivo e constata la propria incidenzasull’opinione pubblica anche in base alle frequentireazioni degli avversari (Mantovani, AnnoAccademico 1972/73). Se destinatario del giornale è esplicitamente il lai-cato cattolico, esso sa bene che la cerchia dei letto-ri è ben più vasta ed anche a questi si rivolge senzatimori e in modo propositivo. Una svolta significati-va si ha con la scelta di trattare in modo più esplici-to la politica nazionale e soprattutto quella cittadi-na, smentendo quanti vorrebbero che un foglio cat-tolico si limitasse alle preghiere e alle prediche. Ma,contro le reiterate accuse e insinuazioni di cedi-menti, il giornale ribadisce di non avere partiti:esso, giornale esplicitamente “cattolico-papale”,resta assolutamente fedele al papa, senza tuttaviadisdegnare di riconoscere e appoggiare propostevalide per il bene della città, a prescindere dallaparte da cui provengano.Libertà d’informazione unita alla libertà di azionenel territorio è quanto rivendica per sé il settima-nale che si pone come protagonista anche alle ele-zioni amministrative pubblicando la lista dei proprifavoriti. E sarà sulla breccia nell’auspicare che sistringa tra le varie forze un patto sugli obiettivi piùimportanti per il futuro della città, come l’espul-sione del Brenta dalla Laguna per impedirne l’in-sabbiamento e il necessario collegamento ferrovia-rio con l’entroterra per superare l’isolamento.Religione, cultura e politica sono, secondo il gior-nale, i veri pilastri che possono costruire su basisolide un futuro condiviso e prospero. E sarà pro-prio alla storia e alla cultura della città che La Fedededicherà ulteriori attenzioni, non in modo acca-demico ma nella prospettiva di ricavarne frutto einsegnamento per l’oggi.Emblematica e preziosa la serie di biografie che ilgiornale pubblica per presentare i “grandi” diChioggia: a partire dai noti “naturalisti”, passandoper esempi di valida collaborazione tra religiosi elaici e culminando in personaggi esemplari del-l’impegno politico, nel dichiarato disegno di edifi-
care una sorta di pantheon cittadino, che ne onorila memoria e insieme ne evochi l’impegno. È moti-vo per mettere in evidenza e in stretta dipendenzaalcuni elementi comuni, che offrono una prospet-tiva sicura anche al presente: una cultura che nonescluda la dimensione religiosa, una attitudine allerelazioni con tutti, la disponibilità al rafforzamentodelle istituzioni civili che non contrasta con la soli-dità di quelle religiose. Un particolare sguardo di privilegio il giornale riser-va alla classe dei medici, nella cui competenza e dis-ponibilità, a livello locale, riscontra una leva effica-ce per la promozione della gente, specie di quellapiù povera. Ma non dimentica di affrontare temati-che scottanti della sanità pubblica che appare spes-so inadeguata: per portarla all’altezza dei tempioccorre una maggiore efficienza delle strutture euna modernizzazione della professione medicafacilitandone l’aggiornamento e la specializzazione.Parimenti La Fede tratta con fermezza e con chia-rezza della questione educativa. Nel periodo in cuilo Stato andava imponendo l’istruzione obbligato-ria “liberale”, emarginando l’insegnamento religio-so e mortificando le numerose scuole non statali,il giornale chioggiotto difendeva, contro il mono-polio statale, il fondamentale principio della “liber-tà di insegnamento” sottolineando il ruolo prima-rio dei genitori e il valore delle istituzioni non sta-tali: non un’arida opposizione all’istruzione obbli-gatoria, ma una ragionata proposta di efficienza edi una sorta di leale concorrenza per il bene dellapopolazione. Non sarà infatti la “statalizzazione”del sistema scolastico a garantire la qualità del ser-vizio, ma la capacità intellettuale e organizzativa dichi si prende cura della gravosa questione educati-va: non mancano in loco esempi significativi(come l’efficiente Pia Casa d’Industria), di cui ilgiornale si fa portavoce. In particolare, per l’istru-zione al popolo, occorre saper andare incontro airagazzi anche quando sono abbrutiti dalla miseria,saper adattare conoscenze e metodologie alle esi-genze dell’età e, soprattutto, mettere insieme l’i-struzione scolastica con la formazione al lavoro,senza mai trascurare però l’educazione religiosache aiuta a formare le coscienze e a trasmettere ivalori più necessari alla convivenza civile. Propriosulla petizione per la “libertà d’insegnamento” –

Gina Duse Stampa intransigente e nascita di un modello identitario
123
come in altre occasioni, ritenute vitali dal punto divista sociale e religioso il giornale si spende nellaraccolta di firme promossa a livello nazionale.Il settimanale, che viene edito proprio da una asso-ciazione cattolica, ha ben chiaro il ruolo pubblicodelle associazioni e non manca di evidenziare lanecessità e il valore di un’organizzazione capillareche sappia mettere in raccordo le diverse poten-zialità: coscienza della propria identità e autenticospirito di appartenenza sono le leve su cui poggia-re per un maggiore coordinamento e per una piùefficace incisività. Ne sono garanzia e strumento,da una parte, il riferimento costante al papa in sin-cero spirito di obbedienza, dall’altra proprio lastampa cattolica che s’incarica di motivare scelte einiziative valorizzando il contributo di tutti. Il livel-lo di partecipazione al sociale con forme più strut-turate di interventi solidali va crescendo propriograzie alla maturazione dell’associazionismo catto-lico, come si ebbe modo di constatare in occasio-ne della disastrosa alluvione del Po nel 1879. Quello della collaborazione tra Chiesa e Istituzionipubbliche è un principio al quale La Fede s’ispirasoprattutto a livello locale, mantenendo nei riguar-di dell’amministrazione e dei politici un atteggia-mento critico ma insieme uno spirito costruttivo,pronto anche a riconoscere la buona volontà e imeriti di rappresentanti non espressamente catto-lici o di sinistra.Tanto di tutto ciò – di questa capacità di penetra-zione nelle problematiche culturali e sociopoliti-che come anche di una sorprendente attitudine aldialogo propositivo per il bene della città – si devealla personalità di Padre Emilio Venturini, collabo-ratore e, dopo la fase iniziale, anche direttore deLa Fede (Pierobon, 2008). Succedendo, infatti, alprecedente direttore padre Andrea Tobia Voltolinaalla morte di questi, verso la metà del secondoanno di vita del giornale –, il Venturini imprimeuno stile nuovo al foglio e lo rende effettivamentestrumento di comunicazione e di crescita non soloper l’ambiente cattolico ma tendenzialmente perl’intera città.La personalità e lo stile del Venturini negli articoli enei pezzi anche non firmati sono identificabili gra-zie al raffronto con un’operetta del padre oratoria-no, edita parecchi anni dopo: quella Guida religio-
sa di Chioggia. Una visita a Chioggia e ai Santuaridella città e Diocesi, che egli “offre” al vescovoMarangoni, nella quale si ritrovano le tematichedominanti dello stesso Venturini giornalista.Impostata in un singolare e istruttivo dialogo tra unnobile Forestiero, un giovane Abate che ha dimesti-chezza con il Seminario e un Professore di storia allocale Istituto tecnico, si pone già come palestra didialogo mettendo comunque, evidentemente, inforte rilievo il ruolo insostituibile della religionenella cultura, nell’arte e nella storia della città comein quella della nazione. Interessante la rassegna deisantuari cittadini da cui emerge la bellezza e la forzadi una testimonianza intrepida come intendeappunto essere quella dei cattolici contemporanei,schierati in difesa del papa e della religione.Era con questo spirito che il Venturini si era sapu-to immergere nella realtà chioggiotta dell’epoca(Barcariolo, 2008) ed era con queste convinzioniche aveva introdotto nel suo giornale anche larubrica “Cronaca politica” quale sguardo intelli-gente (non preconcetto, ma mai accomodante)alla situazione nazionale. Nonostante l’incisività e ilragionevole consenso suscitato da La Fede, saràperò la precarietà dei mezzi – com’era avvenutoper molti altri fogli locali con vita ancor più breve– a decretare la fine delle pubblicazioni del setti-manale nel primo mese del 1880. E si dovrà atten-dere il 1897 – curiosamente proprio l’anno in cuiil Venturini pubblicava la sua Guida religiosa – pervedere uscire a Chioggia un altro periodico dall’a-rea del cattolicesimo intransigente, La Gioventù,“organo della Sezione Giovani del Comitato dioce-sano”.Soprattutto nella seconda fase del giornale si notache concetti quali la sovranità popolare, il parla-mentarismo e il suffragio universale non sono rifiu-tati in assoluto, ma si procede all’elaborazione diuna partecipazione e collaborazione in ambito loca-le che sembra preludere alle alleanze clerico-liberal-moderate che si stringeranno nelle amministrativedel 1895 a Venezia, a loro volta palestra per il suc-cessivo Patto Gentiloni che nel 1913 renderà possi-bile la partecipazione dei cattolici anche alle elezio-ni politiche.

n.22 / 2009
124
Reticolo relazionale
Questa a grandi linee la presentazione dell’operada cui prende avvio la storia dei giornali diocesanifino al presente (Tosello, 2005 e 2008). Andiamoora a scremare dalla massa di notizie, commenti eopinioni, materiali significativi della trama relazio-nale che si andava tessendo. Si è visto che il gior-nale non soffriva d’isolamento. Anche la criticaaspra, ma sempre nei limiti del confronto dialetti-co, da parte della stampa cittadina avversaria va abeneficio della sua visibilità. È importante rimarca-re come il Venturini, in nome dell’indipendenza delgiornale, non manchi né di elogiare la Giunta muni-cipale quando riscontra un buongoverno né dirichiamarla in caso di lentezza e inefficienza. In unasituazione difficoltosa per la popolazione in cui,data l’entità, il problema non è certo risolvibile conla spontanea iniziativa dei soggetti interessati sinota come il Venturini abbia ben chiaro il principioordinatore della pluralità di istanze di competenzadell’istituzione pubblica e ne richieda l’applicazio-ne. Così, si deve sfogliare un giornale della diocesi,per giunta intransigente, per trovare una coraggio-sa, e ancora oggi solitaria, critica alla consistente(sul piano economico) quanto sfuggente (sul pianosociale) categoria dei commercianti di pesce chiog-giotti e un appello alla Giunta perché intervenga,pur nel rispetto del libero mercato, a regolamenta-re le esportazioni eccessive del pescato che creanoaumenti del prezzo locale: “si raduni dunque inconsiglio i principali commercianti di pesce, e dicomune accordo si venga ad un provvedimento uti-lissimo al nostro paese” (La Fede, p. 504). Dove però emerge il tratto saliente di una vera e pro-pria cultura politica quel riconoscimento dell’avver-sario facilitatore del dialogo e di possibili accordi – ènella relazione che il Venturini intrattiene dalle pagi-ne del giornale con l’onorevole Giuseppe Micheli.Scetticismo all’inizio poi prudenza ed infine plauso econsenso, senza alcuna remora: esemplare è l’ap-proccio che il giornale assume e modifica nel segui-re l’operato del deputato progressista eletto nel col-legio di Chioggia e Cavarzere nel gennaio 1877. Néquesta apertura si deve solo all’aspetto caratterialedel Venturini se anche il parroco di PettorazzaPapafava esterna la propria riconoscenza “pel valido
ed efficacissimo appoggio prestato ai miei sforzi ealle pratiche da me avviate col R. Governo per otte-nere a carico dello Stato l’assunzione della spesa perl’andamento e l’esercizio del passo natantesull’Adige a Pettorazza Papafava” (La Fede, p. 623).L’apertura è simmetrica all’attenzione bipartisancon cui il Micheli impara a gestire i rapporti nel suocollegio. Nelle sue visite, infatti, veniamo a saperedal giornale che lo tallona – che, dopo banchetti abase di “maccheroni al sughino nicoteriano” e divini “progressisti”, come era successo all’indomanidella vittoria elettorale (La Fede, p. 412), egli evitamanifestazioni di appartenenza politica troppovistose preferendo un profilo moderato e quindirappresentativo di una pluralità di istanze. Significativi dell’evoluzione da parte del giornaleun articolo del maggio 1877 (La Fede, p. 309) e unaltro del giugno 1879 (La Fede, p. 812), nel mezzole premure del Micheli perché a Roma si concedal’exequatur al vescovo di Chioggia e al patriarca diVenezia, entrambi privi del riconoscimento gover-nativo dopo la nomina pontificia. Nel primo pezzo– fonte è il giornale Fanfulla – non si risparmia l’i-ronia nel raccontare il debutto del Micheli inParlamento quando interviene nel dibattito sullecostruzioni marittime. Bersaglio è il suo dire “elo-quente ma poetico e un po’ po’ anche ridicolo”,quasi un’abitudine per il Micheli visto che una let-tera da lui inviata al sindaco di Chioggia è nellostesso stile. L’eloquio non è più così ridicolo dueanni più tardi. Anzi. Questa volta il discorso del“nostro” deputato Micheli è quello pronunciatoalla Camera in favore del collegamento ferroviario,di vitale importanza per la città. Questa volta, lostesso Micheli ha spedito “gentilmente” alla dire-zione del giornale copia del suo intervento e ilVenturini ricambia riportandone ampi passagginon senza prima averlo definito “ottimo nel suogenere, così ben costruito per rendersi benevola laGiunta parlamentare”. Nessuna “adulazione”,quindi, nell’annoverare tra i cittadini chioggiottianche il Micheli, “che tale è certamente di senti-mento e di affezione”. Quando poi la figlia dell’o-norevole convola a nozze con un giovane avvocatoliberale chioggiotto, molto stimato dalla Fede e pergiunta suo abbonato, il giornale si unisce al corodelle felicitazioni (La Fede, p. 652).

Gina Duse Stampa intransigente e nascita di un modello identitario
125
Rappresentanza
Il collegamento con il Micheli introduce quello cheforse è il risultato storiografico più interessantedello studio della Fede. Alcuni elementi consento-no infatti di problematizzare quell’antiparlamentari-smo che è stato attribuito alla Chiesa di quel perio-do (Licata, 1966). La parete che separa l’ambitodella politica nazionale, a cui i cattolici in obbedien-za al non expedit non partecipavano, dall’ambitodella politica municipale, che al contrario vedevacoinvolti i cattolici , è una parete permeabile.Sicuramente il Micheli non è stato eletto con i votidei cattolici intransigenti ma è ben chiaro anche acostoro il vantaggio che deriva dalla rappresentanzain Parlamento degli interessi locali. Tant’è che quan-do il Crispi, ministro dell’Interno nel secondo mini-stero Depretis, mostra l’intenzione di introdurre nelsenato l’elemento elettivo, il cronista politico dellaFede, dietro cui sospettiamo si celi il Venturini, nonesita a scrivere: “io non veggo l’ora che questa rifor-ma sia messa in esecuzione perché Chioggia possaavere nel Palazzo Madama chi perori pe’ suoi inte-ressi come nel baraccone di Montecitorio e perchéla volontà del paese possa entrare anche là dentro aporte spalancate mentre ora che i senatori vengonoeletti dai ministri, la vi passa appena pel buco dellatoppa” (La Fede, p. 450).Che cosa allora potrebbe alimentare il sospetto diantiparlamentarismo? La descrizione puntigliosadell’uso sconsiderato dell’istituzione parlamentareda parte delle forze politiche liberali non va confu-sa con il rifiuto del principio di rappresentanza.Prima di inoltrarci nella trattazione di questo puntoconviene spendere qualche parola sul cronista poli-tico che fa da interfaccia tra nazionale e locale.Nella veste di “ menestrello” (La Fede, p. 543) il cro-nista politico sfrutta appieno la libertà di stampa e,impastando settimanalmente il meglio dell’ infor-mazione nazionale – spesso attinge pareri confor-mi alle proprie tesi anche dalle testate liberali – conl’aggiunta di una robusta dose di “sale e pepe”,sforna pezzi critici meritevoli di attenzione. Difatto, che l’esercizio del parlamentarismo richiedacultura politica, responsabilità e senso delle istitu-zioni – di cui difetta la classe dirigente liberalemessa alla prova – balza agli occhi ad ogni crisi
ministeriale, così frequente anche con la Sinistra algoverno. Dall’opposizione dove si trova, il cronista politicoha gioco facile nello stigmatizzare l’occupazionedelle istituzioni da parte delle varie consorterie;ma basta ascoltare lo stesso Garibaldi, citato in unfondo dal titolo “Confessioni italianissime” (LaFede, p. 503) per avere un quadro della situazione.L’eroe del Risorgimento, in una lettera del 1874,notava “più e meglio di tutti”: “Fu detto in pubbli-co Parlamento, fu lanciato contro gli onesti che ilgoverno non è un principio ma un partito. Da queldì corruzione nei plebisciti, nei collegi elettorali,nella Camera, nei ministri, negli impiegati, nell’e-sercito, nella marina, corruzione nell’imprese,nelle banche, nei contratti, in ogni ramo, in ognidicastero”. E’ in base a questa logica perversa cheun Depretis, spregiudicatamente, per evitare ledimissioni può tendere allo spasmo l’istituzioneparlamentare ed “evocare lo spettro di una scissu-ra tra Camera e Senato volendo togliere a questo laprerogativa di rivedere le leggi finanziarie” (LaFede, p. 821). “Come stupirsi allora se anche i piùcordiali amici del Parlamento si impensieriscono?”(La Fede, p. 860). Ma la critica potrebbe sconfinarenel facile moralismo se dalla pagine del giornalenon si raccogliessero proposte per un’alternativa.La questione della rappresentanza si intreccia conquella più complessa della sovranità popolare nelmomento in cui, dietro l’angolo, si profila il suffra-gio universale.Se appare evidente l’inadeguatezza della classedirigente sia nazionale che locale – la Giunta muni-cipale chioggiotta condivide con il governo la stes-sa tendenza all’instabilità – come evitare di “misti-ficare il popolo sovrano” (La Fede, p. 685)?L’atteggiamento del giornale nei confronti dellasovranità popolare merita un approfondimento: lafranchezza nel considerare l’impatto sul sistemapolitico della sovranità popolare, amplificato dalsuffragio universale, non comporta automatica-mente la sua cancellazione. L’analisi è oggettiva: ora come ora si oscilla tra dueestremi, fatalismo e rivoluzione. Gli effetti possonoessere o del tutto ininfluenti sulla qualità dell’azio-ne politica come sta succedendo è il foglio delCrispi, la Riforma, a meravigliarsi della pazienza

n.22 / 2009
126
del popolo italiano “che senza Governo si mantie-ne docile e tranquillo” (La Fede, p. 717), o incon-trollabili e quindi destabilizzanti per l’ordine costi-tuito, come potrebbe succedere. Il popolo nonpuò essere autenticamente sovrano se è soggettoa pressioni – a Chioggia capita di vedere innanzi alseggio il padrone che passa all’operaio la lista davotarsi (La Fede, p. 590) o se è lasciato in balia dise stesso.Di fatto, ad orecchie attente “ il fremito è genera-le” perché…“il popolo è un logico inesorabile egettatigli in seno dal liberalismo i principi dissol-venti ora ne trae le ultime conseguenze” (La Fede,p. 676 ). Il liberalismo, avendo sottratto ogni sfera,pubblica e privata, al senso del dovere, non esclu-de che “la larva della sovranità popolare possascacciare ad ogni momento qualsiasi sovrano daipropri Stati, sol perché non piace, calpestandoqualunque diritto” (La Fede, p. 585). Ecco perchéi governi sono presi da “un panico che li fa trema-re”, ecco perchè “il parlamentarismo è un’istitu-zione la quale ogni giorno va scemando nella stimadegli uomini savi” (Ivi, p.860); ma rispondere conleggi repressive come si vorrebbe fare è contro-producente, “rimarrebbe intatta la radice” ad ali-mentare una cospirazione ben più pericolosa per-ché occulta (La Fede, p. 669) .A ricordare la somma dei doveri verso lo Stato everso i fratelli ci pensa la Chiesa. Diversamente daquanto pensa il ministro Nicotera (La Fede, p.557), il cattolico è un buon cittadino italiano per-ché non per timore ma per coscienza rispetta eobbedisce alle pubbliche autorità e soddisfa idoveri civili. La Chiesa quindi con il catechismosalverà re, popoli e nazioni: essa non condannanessuna forma di governo, anzi, potrebbe adattar-si alla monarchia o alla repubblica purchè sia rico-nosciuto il suo prestigio (La Fede, p. 879).Formata attraverso l’educazione religiosa, unanuova forza sociale costruttiva e operante nellalegalità saprebbe elevarsi ad argine di tanto “tor-rente di distruzione” (La Fede, p. 632) come giàsuccede nella realtà del proprio Municipio, dellapropria Diocesi.Ma se, come nota qualche giornale avversario, iclericali mostrano d’avere molta fiducia nel suffra-gio universale, a che giova resistere ora che libera-
li e cattolici-liberali insistono per avere deputatipapali a Montecitorio, che “soli potrebbero farecessare la babele di tanti gruppi”(La Fede, p. 658)?Al centro della diatriba tra lo Stato e la Chiesa, rap-presentata sulle pagine del giornale dal confrontorispettivamente tra l’Ollivier e il Balan, l’interpreta-zione e la pratica del principio di libertà. Perché“singolarissimo è il concetto che i liberali hannodella libertà e alla fine tutto si riduce nella libertàdello Stato di costringere i cittadini, famiglie, muni-cipii, Chiesa a pensare ed operare come vuole loStato”. Dunque conciliare la Chiesa con lo Statosignifica, a queste condizioni, negare libertà diopere e libertà d’insegnamento (La Fede, p. 868).Quali opere sta preparando la Chiesa? Se “lo Statostima i cittadini come tante molecole dello Statocome i panteisti considerano l’universo, distrug-gendo quasi tutta la vita dei singoli per tutta fon-derla nella vita dello Stato” (La Fede, p. 871), diver-samente la Chiesa privilegia l’associazionismo.
Appartenenza
Come organizzare il popolo cattolico numerica-mente maggioritario? Dopo la costituzione delcomitato diocesano nel marzo del 1877, diventanooperativi nelle varie parrocchie della Diocesi icomitati parrocchiali i quali mostrano subito laloro efficienza nel raccogliere firme, e sono oltreun migliaio, per la petizione al Senato sulla prece-denza obbligatoria delle formalità civili alla cele-brazione del matrimonio. A Chioggia, come nelresto del paese, si costituisce una rete di comitati adiversa scala territoriale che trova nell’Opera deicongressi e, appunto, dei comitati cattolici la suastruttura di riferimento (La Fede, p. 819). NelVeneto, l’ambiente chioggiotto è un terreno parti-colarmente fertile per l’attivismo cattolico: da unlato il mondo della pesca, predominante per tuttol’Ottocento – fino a che non subentrerà la moto-rizzazione –, risente della precarietà del vivere equindi spesso chiede assistenza e solidarietà; dal-l’altro la presenza di una piccola e media borghe-sia acculturata – grazie anche alle ricchezze stori-che della città, rappresentata da medici, insegnan-ti, impiegati, artigiani, negozianti è disponibile allapartecipazione civile e alla cooperazione.

Gina Duse Stampa intransigente e nascita di un modello identitario
127
Il primo banco di prova è naturalmente il sociale equi è interessante osservare come il giornalesostenga fin dal primo numero la necessità di pas-sare dalla filantropia episodica ed elitaria alla caritàcome forma di intervento continuato e diffuso nelterritorio. Una presenza assidua nei luoghi che neltempo sviluppa in chi la pratica: conoscenza diret-ta dei problemi, attenta distribuzione delle risorse,capacità di mediazione con gli enti locali cointeres-sati alle emergenze. Ben presto, con soddisfazione,il giornale nota come le associazioni siano diventa-te numerose e occupino sempre più spazio inCattedrale in occasione di cerimonie solenni. Traqueste la Società per la santificazione delle feste,cui faceva riferimento il giornale, aveva una suaimportanza particolare perché, sostenendo la stret-ta osservanza delle festività religiose e quindi lasospensione dell’attività lavorativa, si scontrava nonsolo con le posizioni liberali anticlericali ma anchecon gli interessi delle categorie economiche. Èchiaro però che il lavoratore autonomo che inter-rompeva la propria occupazione, sfidando anche leintimidazioni degli “spessi” liberali che passeggia-vano lungo il corso cittadino, condivideva con ilgruppo di appartenenza dei valori, rafforzava il pro-prio senso di identità. La coesione attraverso vinco-li comunitari è il principale amalgama per il partitocattolico che si va formando. Così quando il giornale pubblica l’“Elenco diCalzolai, Barbieri, Falegnami, Calderaj, Merciai,Sarti che santificano le Feste, e di quali si devonoservire gli ascritti d’ambo i sessi alla Pia Opera dellasantificazione delle Feste, nonché tutti i buoni cat-tolici, che bramano sia posto un argine allo scan-dalo di coloro, che profanano i giorni del Signore”(La Fede, p. 649), e auspica che sempre i buoni cat-tolici devono essere “tutti d’un sol partito, d’unasola lega” (La Fede, p. 652), è naturale che si solle-vino commenti vivaci. “Partito vuò esso essere,altro che elenchi” si accusa; e il giornale, per tuttarisposta, imperturbabile: “C’entra in vero unpochino d’invidia?” (La Fede, p. 656).Del resto, che tutto sia fatto nella trasparenza loprova la pubblicazione del “Regolamento dei comi-tati parrocchiani esecutivi dell’Opera deiCongressi cattolici”, il quale prevede alla voce“Mezzi” che i comitati dipendano dal comitato
diocesano e lo aiutino in quelle opere (elezioni,proteste, petizioni ecc.) per le quali riceverà appo-sito invito (La Fede, p. 826 e p. 830 ); ma anche lapubblicazione della risposta – datata 25 luglio 1879e firmata La Presidenza del Comit. Dioc. peiCongressi cattolici - ad una lettera apparsa sul gior-nale cittadino concorrente, non firmata e ritenutaingiuriosa e menzognera. Il contrasto nasce dall’e-sclusione – a detta dell’anonimo accusatore, ingiu-stificata – di un noto avvocato chioggiotto dallalista dei Consiglieri comunali e provinciali propo-sta dal comitato diocesano per le elezioni ammini-strative previste la domenica dopo. Che cosa si lamenta? Che la rosa dei nomi non siastata decisa collegialmente in seno al comitato masia stata opera di un solo monsignore, in sede ester-na e per giunta d’accordo con un gruppo politicoestraneo. Nel comunicato naturalmente si respingo-no le accuse e nel ribadire l’osservanza delle regolesi ripercorre l’iter seguito. Dal che si è informati del-l’attenzione con cui ciascun comitato parrocchialeindividuava i candidati, per poi – uniti in un comi-zio – procedere alla formazione di un’unica lista dasottoporsi al vaglio del comitato diocesano, il qualea sua volta ne presentava una da confrontarsi conquella. Nessun intrigo, quindi, bensì “matura pon-derazione e retta coscienza, prefiggendosi ad unicofine la gloria di Dio ed il vero bene della Patria” (LaFede, p. 834); patria, per il momento – fino allasospensione del non expedit – ancora solo la città.La lista viene pubblicata in prima pagina la dome-nica dopo, giorno delle elezioni; dal punto di vistadel censo l’elenco è vario, trasversale. Ed è un suc-cesso. Si constata che, su trenta nominativi,“diciassette candidati della nostra lista perConsiglieri comunali furono eletti ed abbiamo lacompiacenza che ben quindici di essi riportaronopiù voti di tutti” (La Fede, p. 840). Che cosa racco-manda la Fede agli eletti? Concretezza e flessibilità:se l’obiettivo è fare uscire l’azienda Municipio dalleincertezze di un andamento provvisorio e anorma-le, si accolga la proposta più ragionevole e più faci-le da realizzare messa sul tavolo da chi è mossodallo stesso spirito, senza badare alla provenienza.Il background del politico cattolico è così sintetiz-zato: “il decampare qualche volta dalle proprieconvinzioni non avvilisce anzi procura la fama di

n.22 / 2009
128
saggio calcolatore del vero bene e della vera utili-tà” (La Fede, p. 841).
Riferimenti bibliografici
DUSE, Gina (a cura di), Siamo in tempi di prova.Padre Emilio Venturini e l’esperienza de La Fede(1876-1880). Ristampa anastatica di un giornalecattolico, Taglio di Po (Ro) 2008. Interventi intro-duttivi di: PIEROBON, Lorenzina, Scheda biografi-ca e opere di Padre Emilio Venturini; BARCARIO-LO, Paola, Padre Emilio Venturini, pastore tra lasua gente; ALDRIGHETTI, Giorgio, Gli stemmiServitano e Oratoriano e l’emblema delle Serve diMaria Addolorata di Chioggia; TOSELLO,Vincenzo, La stampa cattolica a Chioggia; DUSEGina, Padre Emilio Venturini, direttore del gior-nale La Fede.
L’originale si trova presso la Biblioteca civica diChioggia“ C. Sabbadino”, coll.12 L 38; e presso laBiblioteca Nazionale Centrale di Firenze, coll. Gi1.113LICATA, Giovanni, Il giornalismo cattolico italia-no nel decennio1860-1870, in: “Atti del V congres-so dell’Istituto Nazionale per la Storia del giorna-lismo”, Torino 1966MANTOVANI, Verbena, I periodici di Chioggia nelI ventennio dell’Unità italiana e la cultura loca-le contemporanea, Tesi di Laurea, A.A. 1972/73,Univ. di Padova, Rel. Prof. L. LazzariniSCALCO, Lino, Consenso, declino e mutamento diun modello identitario. Il “sistema democristia-no” nell’Alto padovano, in: Foedus n. 19/2007TOSELLO, Vincenzo, Vent’anni di storia nellepagine della diocesi di Chioggia, “NuovaScintilla” (1945-1965), Conselve (Pd) 2005