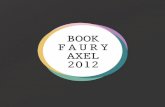Apparecchiature e studi sperimentali sulla segregazione dei … · 2011-09-29 · A. CAQUOT et J....
Transcript of Apparecchiature e studi sperimentali sulla segregazione dei … · 2011-09-29 · A. CAQUOT et J....
VILLEY, Granulométrie rationelle du béton: le néobéton -Génie Civil, 15 marzo e 1° ottobre 1946.
RAFFAELE ARIANO, Studio di miscele per calcestruzzi asciutti- « Le strade », ottobre e novembre 1946.
BR. BUKOWSKI, Technologja Retonów i Zapraw - InstytutBadawezy Budownictwa, Gdansk, 1947.
A. R. COLIINS, Effect of batching errors on the uniformityof concrete - Road Research Laboratory, n. 3, 1947.
ROBERT L'HERMITE et GIOVANNI TOURNON, La vibration du
béton frais - Annales de l'Institut Technique du Bati-ment et des Travaux Publics, béton, béton Armé n. 1,febbraio 1948.
R. H. H. KIRKHAM, The analysis of fresh concrete - RoadResearch Laboratory, aprile 1948.
J. BOLOMEY, La granulation des ballasts et son influence surles caracteristiques des bétons fabriqués avec ceux-ciLa Technique des Travaux, giugno 1948.
GIOVANNI TOURNON, Nuove granulometrie per conglomerati
cementizi - Atti e Rassegna Tecnica degli Ingegneri edegli Architetti in Torino, agosto 1948.
RAFFAELE ARIANO, Sulle pavimentazioni stradali in calce-struzzo - L'industria Italiana del Cemento, febbraio, lu-glio-agosto e settembre 1949.
R. VALLETTE, Composition des bétons - Mise au point de laquestion - Annales de l'Institut Technique du Batimentet des Travaux Publics, béton, béton Armé, n. 6, marzo-aprile 1949.
ALBERT JOISEL, L'homogénéité du béton et les bétonnières -
Annales de l'Institut Technique du Batiment et des Tra-vaux Publics - Matériel de Chantier, n, 3, marzo-aprile1949.
ROBERT L'HERMITE, Fabrication et mise en oeuvre du béton -Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Bati-ment, avril 1949.
SVEN G. BERGSTRÖM et SVEN LINDERHOLM, La vibration du
béton - Recherches expérimentales - Meddelanden,n. 18 - Svenska Forskningsinstitutet för Cement ochBétong, Stockholm 1949.
ANDERS G. ERIKSSON, Development of fluidity and mobility
meters for concrete consistency tests - Handlingar,n. 12 - Svenska Forskningsinstitutet för Cement ochbétong, Stockholm 1949.
JOHS. ANDERSEN, PER BREDSDORFF, NIELS H. KRARUP, K.
MALMSTEDT-ANDERSEN, POUI. NERENST and NIELS M.
P L U M , Testing of eleven danish concrete mixers - TheDanish National Institute of Building Research, Copen-hagen 1951.
R. DUTRON, Comment composer les bétons - Granulometriecontinue ou discontinue - Rétons à haute résistence -Bulletin Tech. n. 46, Groupement Professionel des Fa-bricants de Ciment Portland Artificiel de Belgique, Bru-xelles 1952.
R. ARIANO, Granulometria e rapporto a/c nei calcestruzzicementizi - « L'Industria Italiana del Cemento », novem-bre e dicembre 1952 e gennaio 1953.
Apparecchiature e studi sperimentali sulla segregazione dei calcestruzziL'A. descrive un apparecchio per la misura dello stato di segregazione per sedimentazione forzata dei cal-cestruzzi e riporta i risultati di ricerche sperimentali con esso effettuate sulla segregazione dei calcestruzziin funzione del tempo di vibrazione, della quantità d'acqua d'impasto, e dell'impiego di sostanze plastifi-
canti ed aeranti.
1) Richiami.Nel precedente studio « Sulla segregazione delle
miscele incoerenti e dei calcestruzzi », parlando deifenomeni di segregazione dei calcestruzzi che è datoriscontrare nei cantieri di costruzione, si è dettocome di particolare gravita e frequenza siano quellicaratterizzati da un processo di sedimentazione for-zata.
Si tratta di fenomeni che si verificano ogni qualvolta il calcestruzzo viene sottoposto a t ra t tamentidinamici a carattere alternativo, aventi per effettodi fluidificare il calcestruzzo stesso per diminuzionestatistica del suo attrito interno, consentendo il mo-vimento relativo dei vari componenti di diversamassa specifica.
Nello studio sopra citato si è assunto ad indiceglobale S dello stato di segregazione per sedimen-tazione forzata di un calcestruzzo l'espressione :
dove ΔhG è l ' abbassamento subito per effetto dellasegregazione dal baricentro di un volume cilindricoad asse verticale di calcestruzzo di altezza hc, γc
è il peso specifico del calcestruzzo e γ i il pesospecifico degli inerti che lo compongono.
Nelle pagine seguenti descriviamo un apparecchioper la misura degli indici di segregazione per sedi-mentazione forzata secondo l'espressione (1). Que-sto apparecchio è stato realizzato in un pr imo tempocome prototipo (1949) (fig. 1) e sperimentato pressoil Laboratorio di Costruzioni in Legno, Ferro e Ce-mento Armato del Politecnico di Torino e pressoil Laboratorio Prove Materiali della SIP (SocietàIdroelettrica Piemonte) , in seguito, introdotti alcu-ni perfezionamenti consigliati dall 'esperienza, essoè stato costruito nella sua forma definitiva (1951)
(fig. 2) in alcuni esemplari ed utilizzato da ormaiquasi due anni ancora presso il Laboratorio in Le-gno, Ferro e Cemento Armato del Politecnico diTorino, presso il Laboratorio Prove Materiali dellaSIP, e presso il Gabinetto di Scienza delle Costru-zioni e Ponti della Scuola di Applicazione del-l 'Arma del Genio.
Ci è grato in questa sede porgere l'espressionedella nostra gratitudine al Professore Giuseppe Al-benga, Direttore del Laboratorio di Costruzioni inLegno Ferro e Cemento Armato del Politecnico diTorino e all ' Ingegnere Giulio Gentile, Direttore delServizio Costruzioni Idraul iche della SIP, che cifurono larghi di aiuto nella realizzazione di questostudio sperimentale.
2) Descrizione dell 'apparecchio e delle modal i tàsperimentali per la misura della segregazioneper sedimentazione forzata dei calcestruzzi .
In figura 3 r iport iamo di questo apparecchio glischemi costruttivi con sezioni parziali atte a ren-derne più efficace la rapppresentazione.
L'apparecchio è formato da un recipiente cilin-drico (1) di 50 cm. di altezza, dotato internamentedi una leggera conicità allo scopo di facilitare losversamento del calcestruzzo dopo la prova. Il vo-lume utile del recipiente è di circa 20 dcm3 .
La chiusura del recipiente è realizzata a mezzodi un coperchio speciale (2) munito di fondo a su-perficie interna leggermente concava (3) e sfiato diaria assiale (4). Un manicotto esterno (5), mobilerispetto al coperchio vero e proprio ne assicura latenuta ermetica, venendo a premere su di un anelloin gomma (6) infilato sulla superficie cilindricaesterna del coperchio e da esso trat tenuto grazie adun apposito risalto del fondo. Detta chiusura erme-tica si ottiene avvitando i dadi ad aletta di sei aste
BIBLIOGRAFIA
W. B. FULLER and S. E. THOMPSON, The laws of proportion-
ing concrete - Transactions of American Society of CivilEngineers, aprile 1907.
ABRAMS, Design of concrete mixtures - Bull. n. 1 - Structu-ral Materiale» Research Laboratory - Lewis Institute1918.
FERET, Recherche sur la meilleure composition des mortiers .et bétons hydrauliques - Revue de l'Ingénieur, Settem-bre 1923.
J. BOLOMEY, Résistance à la compression des mortiers et desbétons - Bulletin Technique de la Suisse Romande,n. 11-14-15-17, anno 1925.
R. DUTRON, Dosage rationnel des mortiers et des bétons -Revue des Materiaux de Construction, settembre-marzo1927; giugno-agosto 1928.
IMBRECHTS, La composition granulométrique idéale des béton- Congrès International du Béton et du Béton armé,Liège 1930.
W. M. DUNACAN, A method of determining the costituents offresh concrete - Proceedings American Concrete Institute- vol. 26, 1930, pag. 202.
R. L. BERTIN, C. A. HUGUES, H. C. ROSS, G. J. GRIESE-
NAUER, W. I. FREEL - Discussion of a method of deter-
mining the costituents of fresh concrete - ProceedingsAmerican Concrete Institute - vol. 26, 1930, pag. 670.
WALSH, Aggregate grading in relation to concrete mixturesdesign - The Institution of Civil Engineer of Ireland,Aprile 1936.
KURT WALZ, Die Nachprüfung der Körnung des Zuschlags
im Frischbéton - béton und Eisen, 5 giugno 1936.
L. H. TUTHILL, Handling of concrete and aggregates - Engi-neering News Record, 31 dicembre 1936.
FAURY et LAMARE, Méthode nouvelle pour la mesure de laplasticité de mise en oeuvre du béton - Annales de l'Ins-titut Technique du Batiment et des Travaux Publics,gennaio-febbraio 1937.
A. CAQUOT et J. FAURY, Plasticité de mise en oeuvre du bétonen construction de béton armé - Influence des princi-paux facteurs en jeu - Annales de l'Institut Techinquedu Batiment et des Travaux Publics, settembre-ottobre1937.
A. CAQUOT, Le rôle des materiaux inertes dans le béton -Memoires de la Société des Ingénieurs Civils de France,fascicolo 4, 1937.
W. H. GLANVILLE and A. R. COLLINS, The grading of ag-
gregates and workability of concrete - Road ResearchTechnical Paper, n. 5, 1938.
A. M. GAITDIN, Principles of Minerai Dressing • Ed. McGraw-Hill Book Company, 1939.
ROBERT L'HERMITE, Contribution à l'étude de la mécanique
interne du béton -Annales de l'Institut du Batiment etdes Travaux Publics, série F., n. 2, 1941.
316 ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE - A. 7 - N. 9 - SETTEMBRE 1953 ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE -A. 7 - N. 9 - SETTEMBRE 1953 317
dove I è il momento d'inerzia del l ' intero sistemaoscillante rispetto all 'asse di oscillazione, e P il suopeso.
Onde disporre in ogni condizione di impiego(differenze di r iempimento e di peso specifico delcalcestruzzo, differenze del peso dei cursori di equi-l ibramento utilizzali) dei valori più convenienti disensibilità e di prontezza, è stato previsto un rego-latore di sensibilità, costituito da un cilindro di ac-ciaio (23) che può essere avvicinato ed allontanatodall'asse di oscillazione per avvitamento su di unaasta filettata (24), in modo da poter realizzare lenecessarie variazioni di altezza del baricentro del-l ' intero sistema oscillante. Uno speciale controdadozigrinato (25) vale a bloccare il cilindro (23) nellaposizione voluta.
Il regolatore di sensibilità è fissato al cilindro incorrispondenza dell ' intersezione della sua genera-trice inferiore col piano passante per l'asse di oscil-lazione e normale all'asse del cil indro, a mezzo diuno speciale attacco rapido a baionetta (26) munitodi molla di reazione a lamina (27).
L'asta filettata del regolatore si prolunga infe-riormente in un indice (28) mobile lungo una scalagraduata di oscillazione (29) con lo zero sul pianoverticale passante per l'asse di oscillazione.
L 'equi l ibramento del sistema oscillante viene ot-tenuto a mezzo di tre cursori di forma cubica (30)(31) e (32) rispettivamente del peso di 0,5, di 1, edi 2 Kg. , spostabili lungo una guida (33) dispostain corrispondenza della generatrice superiore delci l indro; i cursori presentano in mezzeria di unodegli spigoli inferiori un indice (34) atto alla de-terminazione della posizione dei cursori stessi perlettura su di una scala millimetrica (35), fissata afianco del profilato di guida a mezzo di un sup-porto (36) ed avente essa pure lo zero nel pianopassante per l'asse di oscillazione e normale all 'assedel cilindro.
Il t ra t tamento dinamico di segregazione può es-sere ottenuto fissando il cilindro in posizione verti-cale su di una apparecchiatura atta ad imprimerglisollecitazioni di caratteristiche oppor tune.
A questo scopo è stata realizzata una specialetavola a scosse ad altezza di caduta variabile da 0ad un valore massimo di 18 m m . (fig. 4).
Riport iamo in fig. 5 gli schemi costruttivi diquesta apparecchiatura.
Essa è costituita essenzialmente da un basamento(1) e da un piatto mobile (2) in acciaio fuso. Il ba-
318 ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE - A. 7 - N. 9 - SETTEMBRE 1953
struzzo in prova e dalle caratteristiche del tratta-mento dinamico. Converrà che la durata della vi-brazione o il numero delle scosse relativi al l 'ul t imaoperazione di r iempimento siano doppi di quellirelativi agli altri strati.
Si determina quindi l'altezza hc del calcestruzzomisurando in quattro punt i a 90º la distanza tra lasua superficie ed il bordo e mediando questi valori.Note le dimensioni del recipiente, questa misuraconsente la determinazione del volume Vc di calce-struzzo. Quindi si pesa il cilindro onde determinare,facendo la tara, il peso Pc del calcestruzzo.
2) Si procede quindi alla chiusura del reci-piente con l 'apposito coperchio a stantuffo (2); perquesto, aperto il rubinet to di sfiato (4), si introduceil coperchio nel cilindro ed avvitando i galletti (9)delle tre aste (8) si porta il coperchio a premerecontro la superficie del calcestruzzo finchè si vedafuoriuscire dallo sfiato un p o ' di acqua e cemento,si chiude allora il rubinet to di sfiato e si serrano icontrogalletti (11) bloccando il coperchio nella po-sizione raggiunta. Quindi avvitando i galletti (13)delle aste (12) si determina l 'abbassamento dell 'a-nello di tenuta (5) sino a portarlo a premere forte-mente col suo bordo inferiore sull 'anello di gomma(6), che, espandendosi, reagisce lateralmente sullepareti e realizza la tenuta ermetica. L'anello di te-nuta (5) viene allora bloccato nella posizione rag-giunta avvitando i controdadi (14).
3) II cilindro viene quindi disposto sul basa-mento (21) (fig. 2) in modo che prenda appoggiocon le ali (15) sull 'estremità delle viti (22) oppor-tunamente sollevate. Si procede allora all 'attacco
Fig. 2 - Segregometro nella sua forma definitiva.
Fig. 1 - Prototipo dell'apparecchio di misura della segregazione persedimentazione forzata dei calcestruzzi.
filettate, incernierate in (7) e munite di molla ascatto per il loro fermo nella posizione di ribalta-mento verso il fondo del recipiente. Di queste astefilettate tre (8) vengono ad agire mediante i dadi adalette (9) muni t i di controdadi di fissaggio (10) suapposite sedi (11) previste sull 'orlo del coperchiovero e proprio (2), mentre le altre tre (12) agisconomediante i dadi ad alette prolungati (13), munit idi controdadi (14), sulle sedi previste nell 'orlo delmanicotto esterno (5), che può così essere portatoa premere sull 'anello di gomma (6), d e t e r m i n a n d o ,per espansione laterale di quest 'ul t imo, la tenutaermetica del coperchio.
Sulla parete esterna del recipiente cilindricosono saldate due robuste ali di acciaio (15) che pre-sentano sulla loro faccia inferiore delle sedi ripor-tate (16) in acciaio speciale e rettificate.
Quat tro maniglie (17) consentono di t rasportareagevolmente l 'apparecchio.
Il fondo del cilindro è muni to di una coronasporgente (18), munita di quat t ro asole (19) desti-nate al fissaggio dell 'apparecchio durante il tratta-mento dinamico.
Nella posizione di misura il cilindro poggia conle sedi (16) su due coltelli in acciaio speciale retti-ficati (20), portati da un robusto basamento in ghi-sa (21).
Due viti a teste zigrinate (22), site a fianco deicoltelli, valgono a proteggere il filo dei coltelli stessidagli ur t i che potrebbero verificarsi nel momentoin cui si dispone il cilindro sul basamento di mi-sura, nonchè a r idurre il tempo di caricamento deicoltelli alla sola durata dell 'operazione di equili-bramento.
La posizione delle sedi rettificate (20) r ispet toal cilindro è de terminata in modo che l 'apparecchio,funzionando come una bilancia in oscillazione suicoltelli, presenti una elevata sensibilità, senza chesi abbiano per altro a verificare casi di equilibrioinstabile. Per sensibilità s ' intende qui il r appor to
t ra l 'angolo α di cui deve inclinarsi l'asse del
cilindro perchè si ristabilisca l'equilibrio al teratoda uno spostamento orizzontale Al del baricentrodel sistema oscillante, ed il valore Al dello sposta-mento stesso.
La sensibilità è evidentemente tanto più elevataquanto minore è la distanza verticale d tra il bari-centro del sistema oscillante e l'asse di oscillazione.Per contro con l 'aumentare della sensibilità dell 'ap-parecchio ne diminuisce la prontezza di misura, au-mentando il periodo di oscillazione T secondo lalegge :
samento porta un albero (3) montato su bronzine(4) sul quale è calettato un eccentrico (5) con risaltodi 20 mm, di altezza. Detto albero viene messo inrotazione mediante una manovella (6). Nella partesuperiore il basamento presenta una sede cilindri-ca (7) di guida al piatto mobile (2). Il movimentoè impresso al piat to dall 'eccentrico (5) che agiscesulla estremità inferiore dell 'asta di acciaio (8) so-lidale col piatto mobile.
La regolazione dell 'altezza di caduta del piat toda 0 al valore massimo di 18 mm. si effettua avvi-tando più o meno sull 'asta filettata (8) il manicottocilindrico (9). Infatti la corsa di caduta dell ' insiemepiatto (2), asta di comando (8), e cilindro di guida(9), che si determina dopo il superamento del ri-salto dell 'eccentrico (5), è arrestata dalla battuta(10) del basamento che viene a contatto con la fac-cia inferiore del manicotto di guida (9). Per tantoper regolare l 'altezza di caduta basterà far variare,avvitando il manicotto (9) sull 'asta (8), la distanzaesistente tra le due superfici d 'ur to quando il piattosi trova in posizione di massima elevazione.
Per fissare in una determinata posizione il ci-lindro (9) rispetto all 'asta (8) ci si vale di tre vitidi pressione (11) che vanno ad impegnarsi in ap-posite sedi (12) previste sulla superficie superioredel manicotto di guida (9).
È possibile fissare il segregometro sul piatto del-la tavola a scosse valendosi di quat t ro aste filet-tate (13), incernierate in (14) ai bordi del piat to, edei relativi dadi (15).
Le stesse aste filettate disposte orizzontalmentee relativi dadi servono anche a fissare sul piat to (2)una tavola circolare (16) in lamiera di acciaio irri-gidita da nervature, che comparedisegnata a tratteggio in fig. 5.Questa tavola consente di utiliz-zare l 'apparecchiatura come tavolaa scosse per il flowtest (fig. 6) pre-via sostituzione della manovella(6) con una nuova manovella puredisegnata a tratteggio in fig. 5 diminor raggio e munita di pro-lunga.
Il procedimento da seguirsi pe rla determinazione della segregabi-lità di un calcestruzzo a mezzo diuna simile attrezzatura è il se-guente :
1) Fissato il cilindro sullaspeciale tavola a scosse sopra de-scritta o su di una tavola vibrante ,lo si r iempie di calcestruzzo in cin-que strati di circa 10 cm. di altezzaciascuno, e ad ogni strato si scuoteo si vibra il cilindro in modo dadeterminare un costipamento delcalcestruzzo tale da eliminare pra-ticamente i vuoti esistenti. La du-rata dei periodi di vibrazione odel numero di scosse cui convienesottoporre il calcestruzzo ad ogninuovo apporto di materiale di-pende dalla consistenza del calce-
ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE - A. 7 - N. 9 - SETTEMBRE 1953 319
del regolatore di sensibilità (23),e si infilano sul profilo di guida(33) i t re pesi P1 (30), P2 (31) eP3 (32) rispettivamente di 0,5, di1 e di 2 Kg. Abbassando contem-poraneamente le viti (22) si portail cilindro a prendere appoggiocon le sedi (16) sui coltelli di oscil-lazione (20). Si regola quindi , senecessario, la sensibilità del l 'appa-recchio avvitando o svitando il ci-l indro (23) e si equilibria il siste-ma spostando i cursori P1 , P 3 , P 2 ,in modo da portare l ' indice (28) acoincidere con lo zero della scalagraduata (29). Si procede alloraalla lettura delle posizioni l1, 12, 13
dei singoli pesi P1 , P 2 , P3 sullascala mil l imetrata (35).
4) A mezzo delle viti (22) sisolleva il cilindro dai coltelli dioscillazione quindi , allontanati ipesi P1 , P 2 , P3 ed il regolatore disensibilità (23), si toglie il cilin-dro dal basamento, lo si fissa sullaapposita tavola a scosse (fig. 4) osu di una tavola vibrante, e lo sisottopone a un certo numero discosse o ad un certo tempo di vi-brazione.
5) Si dispone poi nuovamenteil cilindro sul basamento e r ipe-tendo le operazioni descritte aln. 3) si procede al suo equilibra-mento ed alla determinazione dellenuove posizioni 1'1, l'2, l '3 assuntadai pesi P 1 , P 2 , P 3 .
A questo punto si potrà consi-derare la prova come ult imata, oprocedere ad altre operazioni dit ra t tamento dinamico e di succes-sivo equi l ibramento, a seconda chesi voglia disporre di un solo va-lore dello stato di segregazioneconseguente a un determinato trat-tamento dinamico, o di più valori ,che possono eventualmente con-sentire il tracciamento del dia-gramma dello stato di segrega-zione in funzione dei tempi di vi-brazione o dei numeri di scosse.
Note le posizioni 11, 12 , 13 deitre pesi P 1 , P 2 , P 3 , relative allapr ima operazione di equilibra-mento (calcestruzzo omogeneo), ele analoghe posizioni 1'1, l '2 , l '3 ,relative alle successive operazionidi equil ibramento (calcestruzzosegregato), noto altresì il peso Pcdel calcestruzzo contenuto nel ci-lindro del segregometro, risultaimmediata la determinazione del-l 'abbassamento ΔhG del baricen-tro del calcestruzzo conseguente al
320 ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE - A. 7 - N. 9 - SETTEMBRE 1953
Fig. 3 - Prospetto e pianta del segregamento con sezioni parziali.
ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE - A. 7 - N. 9 - SETTEMBRE 1953 321
Fig. 4 - Segregometro montato sull'apposita tavola a scosse a saltovariabile visto dal lato superiore e visto dal lato inferiore.
L 'apparecchio sopra descritto consente la deter-minazione dell ' indice S con una sensibilità che siè dimostrata più che sufficiente agli scopi pratici .L 'errore relativo per difetto di sensibilità risulta in-
(1) Allo scopo di rendere palese quale sia l'influenza deisingoli errori di misura sul valore della sensibilità della misuradell'indice S, riteniamo interessante riportarne qui la deter-minazione.
la sensibilità Δ' S ottenibile nella misura di S può esserecalcolata a mezzo della espressione:
fatti del l 'ordine del 6÷7 %, ove si t ra t t i di un 'ope -razione completa di misura su di un calcestruzzo dicaratteristiche medie , sottoposto a normale trat ta-mento dinamico (ΔhG de l l 'ordine di 2 m m . ) . Nelcaso che interessino soltanto le differenze causateda successivi t r a t t a m e n t i dinamici t ra gli indici disegregazione di u n o stesso calcestruzzo, differenzemisurabil i semplicemente mediante successive ope-razioni di equi l ibramento del ci l indro dopo averlosottoposto ai successivi t ra t tament i , l'effettiva sen-sibilità di misura aumenta notevolmente in quanto
i fattori hc e che compaiono nella (1) re-
stano costanti per tut te le misure : l 'errore relativoper difetto di sensibilità, nella determinazione didifferenze di S conseguenti ad abbassamenti delbaricentro del calcestruzzo dell 'ordine di 2 mm. , siriduce a valori de l l ' 1÷1 ,5 % (1).
In tal caso anche la precisione effettivamenteraggiungibile nella determinazione delle differenzedi S si è dimostrata relativamente elevata e del-l 'ordine del 3 %.
Ripetendo invece integralmente (vale a direprocedendo ogni volta a nuove operazioni di riem-pimento e di t ra t tamento dinamico, oltre a quelledi equilibramento) diverse prove su di un mede-simo calcestruzzo si è constatato un errore relativomassimo per difetto di precisione notevolmente piùelevato e dell 'ordine del 15 %. Questi dati di sen-sibilità e di precisione consentono di valutare i ri-sultati numerici delle diverse ricerche sperimentali ,su cui riferiremo nel seguito, nella loro effettivaattendibili tà.
3) Risultat i sperimental i .
a) Segregazione di un calcestruzzo in funzione dei
tempi di vibrazione.
A titolo di esempio r iport iamo integralmente idati e i risultati relativi ad una serie di esperienzedestinate a determinare la legge di variazione degliindici di segregazione di un calcestruzzo in fun-zione dei tempi di vibrazione.
Ponendoci nel caso di calcestruzzi di caratteristiche medie,una normale prova di segregazione (p. es. da 1 a 3 minutidi trattamento su tavola vibrante a 3000 giri/min, ampiezza1 mm.) determina un abbassamento ΔhG del centro di gravitàdel calcestruzzo dell'ordine di 1 ÷ 3 mm. ; poniamo media-mente ΔhG = 2 mm. L'altezza hc del calcestruzzo nel cilindrodi misura è mediamente di 47 cm., il peso specifico del calce-struzzo YC è mediamente dell'ordine di 2,4 Kg/dcm3, quellodegli inerti dell'ordine di 2,7 Kg/dcm3.
Il peso P del cursore (32) e il peso Pa dell'apparecchio
Determiniamo ora di quale errore può essere affetta lamisura del peso specifico γi del calcestruzzo. Detto pesospecifico viene determinato a mezzo della espressione:
Si posseggono così tutti gli elementi per il calcolo della sen-sibilità A'S secondo l'espressione (2), sarà:
Per i valori di ΔhG, hc, γi e γc sopra riportati lo stato disegregazione S vale:
fenomeno di segregazione, si potrà infatti scrivere :
nel cilindro, il peso specifico del calce-
struzzo, ed avendo precedentemente determinato ilpeso specifico γ i degli inerti, si posseggono t u t t i glielementi necessari al calcolo dell 'indice di segrega-zione S del calcestruzzo secondo l'espressione (1)sopra definita:
Determiniamo innanzitutto l'errore di cui puòessere affetta la misura dell abbassamento del baricentro delcalcestruzzo. Detto abbassamento può essere definito, come
si è visto, dall'espressione
dove PC è il peso del calcestruzzo contenuto cilindro di prova,determinato come differenza del peso Pt del cilindro di provapieno di calcestruzzo, che mediamente è di 90 Kg., e delpeso Pa del cilindro vuoto, che col coperchio è di circa 40 Kg. Pcvale dunque mediamente 50 Kg. e se P rappresenta il pesodel cursore (32) di 0,5 Kg. ad uno spostamento ΔhG delbaricentro del calcestruzzo di circa 2 mm. corrisponderà unacorsa (1 — 1') del cursore (32) dell'ordine di 200 mm.
322 ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE - A. 7 - N. 9 - SETTEMBRE 1953
La vibrazione era ottenuta a mezzo di una ta-vola vibrante a 3.000 giri al minuto con ampiezzadi vibrazione di 1 mm. Le caratteristiche del calce--struzzo impiegato e i dati di prova erano i seguenti :Tipo di iner t i : Anfibolite f r an tumata .Peso specifico degU iner t i : γi = 2,916 Kg/dcm 3
Granulometr ia : Continua t ipo Bolomey (Dm a x =
= 40 m m . ) .
Il d iagramma granulometrico a d o t t a t o è rappresen-t a t o in fig. 7 dalla curva 1 a t r a t t o continuo.Dosaggio cemento : 300 Kg/m 3 di cemento Por t landartificiale t ipo 500.
possono essere determinati una volta tanto a meno del
il peso Pt del cilindro pieno viene determinato ad ogni opera-izione a meno del (50 grammi su 100 Kg.). Pertanto
potremo scrivere, esprimendo le lunghezze in mm. ed i pesin gr.:
al di mm.
Kg/dcm3.
dove Ac è l'area del recipiente cilindrico e gli altri simbolihanno il significato già noto.Potremo dunque scrivere:
L'area Ac è di circa 44.000 mm2, l'altezza hc, come si è visto,mediamente di 470 mm., il peso Pt di 90 Kg. ed il peso Padi 40 Kg. Valutando il diametro Dc del cilindro, di circa
235 min.-, a meno del di mm., l'errore ΔAC possibile
nella valutazione dell'area Ac vale:
Si avrà dunque:
Dosaggio acqua : 175 litri/m3
Lavorabil i tà alla prova V E B E :
Altezza del calcestruzzo nel cilindro: hc=43 ,9 cm.
Volume del calcestruzzo nel cilindro : V c = 17,61 dcm 3
Peso del calcestruzzo nel ci l indro: Pc—44,57 Kg .
Peso specifico del calcestruzzo nel cilindro:
= 2,531 Kg/dcm 3
I risultati delle prove di segregazione su questocalcestruzzo sono riportati nella tabella riassuntivadi pag. 325.
Pertanto l'errore relativo di sensibilità nella misura
dello stato di segregazione di un calcestruzzo col metodo sopraesposto risulta:
Nel caso che interessi determinare le differenze, causate dasuccessivi trattamenti dinamici, tra gli indici di segregazionedello stesso volume di calcestruzzo, differenze determinate,come già si è detto, mediante successive operazioni di equili-bramento del cilindro dopo averlo sottoposto ai successivitrattamenti, l'effettiva sensibilità di misura aumenta notevol-
mente in quanto i fattori hc e che compaiono nella
(1) restano costanti per tutte le misure.In tal caso si potrà dunque scrivere:
ma, per le condizioni sperimentali sopra menzionate, si è visto
che e se gli abbassamenti del baricentro
del calcestruzzo conseguenti ai successivi trattamenti sonoancora dell'ordine di 2 mm., l'errore relativo di sensibilitàsi riduce a:
Conoscendo 1 altezza hc del calcestruzzo contenuto
ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE - A. 7 - N. 9 - SETTEMBRE 1953 323
Ciò significa che l'apparecchio è in grado di_ apprezzarespostamenti del baricentro del calcestruzzo di poco superiori
L'errore di cui può essere affetta la misura dell'altezza delcalcestruzzo nel cilindro è dell'ordine di 1 mm.; porremopertanto Δ'hc = 1 mm.
Il peso specifico degli inerti può essere determinato facil-mente con i normali procedimenti della fisica a meno di
Nella pr ima colonna della tabella compaionole durate dei successivi t ra t tamenti dinamici su ta-vola vibrante, nella seconda i tempi progressivi to-tali di vibrazione, nella terza, quarta e quinta le
posizioni lette in cm. sulla scala graduata di rife-r imento dei pesi di equil ibramento P1 , P2 e P3 ri-spettivamente di 2, 1 e 0,5 Kg. , nella sesta e set-t ima colonna rispettivamente i momenti assoluti
TABELLA RIASSUNTIVA
Prove di segregazione per diversi tempi di vibrazione
b) Segregazione di un calcestruzzo in funzione della
quantità d'acqua d'impasto.
È noto come in un calcestruzzo il pericolo dellasegregazione, in particolare della segregazione persedimentazione forzata, sia tanto più sentito quan-
Fig. 6 - Tavola a scosse apparecchiata per il « Flow-Test ».
Fig. 5 - Sezione e pianta della tavola a scosse a salto variabile per lo studio della segregazione dei calcestruzzi.
324 ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE - A. 7 - N. 9 - SETTEMBRE 1953
Ma di detti pesi ed i momenti relativi Mr (diffe-renze tra i vari momenti assoluti ed il momentoassoluto iniziale) in Kg. x cm.
Essendo Pc i l peso del calcestruzzo contenutonel cilindro, gli abbassament i ΔhG del baricentro
del calcestruzzo r isul tano dai r a p p o r t i che
vengono r iportat i nell' o t t a v a colonna. Nella nonacolonna compaiono moltiplicati per 100 i rappor t i
dove hc è, come si è visto, l 'altezza del
calcestruzzo ed infine nella decima colonna, sempremoltiplicati per 100, i valori degli indici di segrega-
zione
Nell 'ult ima colonna della tabella sono r ipor ta t i
i valori delle segregabilità medie dove,
secondo la definizione da ta nel precedente studio« Sulla segregazione delle miscele incoerenti e deicalcestruzzi », T sono i t empi progressivi totali divibrazione cui corrispondono gli indici di segrega-zione S.
La rappresentazione grafica degli indici di segre-
gazione S e della segregabilità media
in funzione dei tempi di vibrazione, è r iportata in
fig. 8.Ripor tando i tempi in scala logaritmica (fig. 9),
i punti rappresentativi di S si allineano abbastanzaregolarmente lungo una ret ta ; S può quindi essereespresso in funzione di T a mezzo di un 'equazionedel t ipo :
dove a e b sono due coefficienti numerici positivi.Tale tipo di espressione in S in funzione del tempodi vibrazione T, è stata riscontrata valida per tu t t ii calcestruzzi sperimentat i , e si trasforma nell 'ana-loga espressione:
quando, invece che ad un certo tempo di vibrazione,il calcestruzzo sia sottoposto a un certo numero Ndi scosse.
ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE - A. 7 - N. 9 - SETTEMBRE 1953 325
Nel caso delle prove qui descritte, gli indici disegregazione S sono esprimibili in funzione del tem-po di vibrazione T a mezzo della equazione :
(4)
ove il t empo T è misurato in minut i primi. Deri-vando r ispet to al t empo ques ta espressione siottiene l'espressione della segregabilità i s tan tanea S'i ,che nel caso della prove sopradet te d iven ta :
Ripor tando de t t a curva sul d iagramma di fig. 8si consta ta , cosa del resto in tui t iva , come essa
risulti ovunque inferiore alla curva della
segregabilità media, la cui espressione in basealla (4) r isul ta :
Gli indici di segregazione misurati risultano dal-lo specchietto seguente, in cui ogni valore rappre-senta la media di tre prove, eseguite nelle t re di-verse riprese, su calcestruzzi aventi tutti la compo-sizione sopra r iportata .
Dosaggi d'acqua
d'impasto l/m3
135150180210240255
Indici di segregazione dopo
5 min. di vibrazione
0,0130,0150,0330,0520,0710,131
Fig. 7 - Diagrammi granulometrici degli inerti impiegati.
to, a par i tà di altre condizioni, è maggiore il volu-me di acqua d ' impasto impiegato.
Una serie di prove è stata condotta allo scopodi studiare la legge di varia-zione della segregazione per se-dimentazione forzata di un cal-cestruzzo tipo in funzione dellequanti tà d 'acqua d ' impasto.
Queste prove sono state con-dotte su di un calcestruzzo taleda rappresentare il t ipo mediodi calcestruzzo da cemento ar-mato comunemente util izzato; siè scelto un calcestruzzo dosatoa 300 K g / m 3 di cemento Port-land artificiale t ipo 500, realiz-zato con inerti di fiume con dia-metro massimo di 25 m m . di cuir iport iamo in fig. 10 il dia-gramma granulometrico secon-do Faury .
Con questo t ipo di calce-struzzo sono state eseguite, int re differenti r iprese, sei provedi segregazione per ogni r ipre-sa, par tendo da un dosaggiominimo di acqua di 135 litriper m3 di calcestruzzo e an-dando di prova in prova aumen-tandolo. Dopo ogni prova ilcalcestruzzo veniva infatti sver-sato dal cilindro, rimescolatoenergicamente, sì da omoge-neizzarlo, con l 'aggiunta diquantitativi d 'acqua tali da rea-lizzare successivamente i se-guenti dosaggi in litri per m3
di calcestruzzo :
135-150-180-210-240-255 l /m 3 .
I calcestruzzi così ottenutisono stati sottoposti ogni voltaad un t ra t tamento dinamico di5 min . di vibrazione su tavolavibrante a 3.000 giri al min . ,con ampiezza di vibrazione di1 m m .
I risultati di queste esperienze sono stati espressigraficamente in fig. 11. Da essa risulta come i punt irappresentativi degli stati di segregazione in funzio-ne della quanti tà d 'acqua d ' impasto si dispongono
con una certa regolarità secondo una curva espri-mibile a mezzo di una relazione del t i po :
log S = k1a — k2
dove S è l ' indice di segregazione, a la quanti tà diacqua d ' impasto espressa in litri per m3 di calce-struzzo e k1, k2 due coefficienti numerici positivi.
Nel caso nostro specifico i risultati delle provepossono essere interpretat i abbastanza fedelmenteponendo k1 = 0,08 e k2 = 4,00, come risulta dallafig. 11 in cui è stata appunto tracciata la curva diequazione :
log S - 0 , 0 8 a — 4,00.
c) Studio dell'effetto di sostanze plastificanti ed ae-
ranti sulla segregazione di un calcestruzzo.
È noto dalla let teratura tecnica part icolarmenteabbondante apparsa in questi ul t imi anni sull 'uso disostanze plastificanti ed aerant i nella confezione deicalcestruzzi come si affermi generalmente che talisostanze hanno , insieme ad altr i benefici effetti, laproprietà di r idurre la tendenza dei calcestruzzi asegregarsi.
Parve interessante controllare sperimentalmentequeste asserzioni, e tale controllo sembrò tanto piùoppor tuno in quanto , mentre gli altri effetti sulleproprietà del calcestruzzo fresco e induri to (au-mento della lavorabilità a par i resistenza mecca-nica; aumento della resistenza meccanica, della re-sistenza al gelo e della impermeabil i tà a pari lavo-rabilità) sono stati già quanti tat ivamente dimostratida numerose prove di laboratorio, a proposito dellaresistenza alla segregazione non esistono, in tutta lapur abbondante let teratura, che affermazioni quali-tative, prive di qualsiasi conferma sperimentale.
Le prove furono condotte su calcestruzzi dosatia 200 ed a 250 K g / m 3 di cemento Port land artifi-ciale t ipo 500, composti da inerti di origine alluvio-nale di 50 mm. di diametro massimo, di cui diamoin fig. 7 (curva 2) il diagramma granulometrico.
La via seguita in questa ricerca fu di confrontarela segregabilità di tali calcestruzzi con quella rela-tiva a calcestruzzi di eguale dosaggio di cemento,di quasi eguale composizione granulometrica (curva3 della figura 7) e di par i o superiore lavorabilità,ai quali era stata aggiunta una sostanza plastifi-cante ed aerante nella sua dose normale .
La leggera differenza (fig. 7) tra la curva granu-lometrica 2, relativa ai calcestruzzi senza sostanzeplastificanti ed aeranti , e la curva granulometrica 3,relativa ai calcestruzzi con aggiunta di dette so-stanze, deriva dal fatto che è stato diminuito ilquantitativo di sabbia passante al crivello D = 0,5mm. di un volume par i al volume di pori deter-minato dal l 'aerante, vale a dire di circa l'8 % delsuo volume iniziale.
La lavorabilità dei calcestruzzi è stata valutata
Fig. 9 - Diagramma degli indici di segregazione di un calcestruzzoin funzione dei tempi di vibrazione in scala logaritmica.
col metodo VEBE, che, fra tutti i metodi in uso,ri teniamo essere quello dotato di maggiore sensi-bilità e precisione per il t ipo di calcestruzzi spe-rimentat i .
A titolo di esempio r iport iamo nelle tabelle suc-cessive i risultati di alcune di queste prove., La prima tabella si riferisce a due calcestruzzi do-
sati a 200 K g / m 3 di cemento; il p r imo con 130 l /m 3
di acqua d ' impasto diede alla prova VEBE un in-dice di lavorabilità di 1/10'' Il secondo calcestruzzo
fu realizzato con soli 110 l / m 3 di acqua d ' impasto econ l 'aggiunta della dose normale di una sostanzaplastificante ed aerante (Frioplast) in proporzionedel 0,5 % del peso di cemento. Quest 'ul t imo im-pasto, p u r comportando un minore quantitativo diacqua, diede alla prova VEBE un indice di lavora-bilità 1/8' ', alquanto maggiore di quello relativo al
pr imo impasto.
L'indice di segregazione relativo al pr imo im-pasto per un tempo di vibrazione di 90" è risultato0,062 e l ' indice di segregabilità 0,041 min. - 1 . Peril secondo impasto, con aggiunta di Frioplast , l ' in-
Fig. 10 - Diagramma granulometrico secondo Faury del calcestruzzo-tipo adottato.
ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE - A. 7 - N. 9 - SETTEMBRE 1953 327
Tempi di vibrazione in min.Fig. 8 - Diagramma degli indici di segregazione e delle segregabilità medie ed ^istantanee di un
calcestruzzo in funzione dei tempi di vibrazione.
ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE - A. 7 - N. 9 - SETTEMBRE 19S3326
PROVE DI SEGREGAZIONE DI CALCESTRUZZI DOSATI A 200 Kg/m3 SENZA E CON SOSTANZEPLASTIFICANTI ED AERANTI
PROVE DI SEGREGAZIONE DI CALCESTRUZZI DOSATI A 250 Kg/m3 SENZA E CON SOSTANZEPLASTIFICANTI ED AERANTI
dice di segregazione è risultato 0,028 e l ' indice disegregabilità 0,019 min. - 1 .
La seconda tabella r iporta i risultati relativi alleprove su due calcestruzzi dosati a 250 K g / m 3 di ce-mento . Il pr imo di questi calcestruzzi fu impastatocon 137,5 1/ m3 d 'acqua e diede alla prova VEBE
un indice di lavorabilità di 1/8' ' Il secondo, di eguale
composizione granulometrica, fu impastato con 117l /m 3 di acqua con aggiunta di Frioplast , sempre inproporzione del 0,5 % del peso di cemento, e diedeancora alla prova VEBE un indice di lavorabilità
di 1/8' ' .
L' indice di segregazione relativo al pr imo im-pasto per un tempo di vibrazione di 90" è risultato
0,042 e l ' indice di segregabilità 0,028 min. '1 , mentreper il secondo impasto, con aggiunta di Frioplast ,l ' indice di segregazione è risultato 0,029 e l ' indicedi segregabilità 0,015 min. ' 1 .
I risultati di queste prove sembrano confermarequanti tat ivamente la sensibile diminuzione di segre-gabilità che, a pari lavorabilità, è possibile realiz-zare nei calcestruzzi mediante l 'uso di sostanze pla-stificanti ed aeranti .
La diminuzione relativa di segregabilità sembre-rebbe alquanto più elevata nel calcestruzzo a minordosaggio di cemento, ma su questo punto non èpossibile pronunciarsi con sicurezza a causa dell 'e-siguo numero di prove effettuato e per il fatto chesi trat ta di differenze dello stesso ordine di gran-dezza della precisione di misura.
(2) R. L'HERMITE, Nouveaux procédés de traitement dubéton - Annales de l'Institut Technique du Batiment et desTravaux Publics, Béton, Béton Armé, n. 17, mars-avril 1951.Vedasi paragrafo: « Influence de l'air entraîné sur les pro-priétés du béton frais ».
all 'aggiunta delle dosi normali di diversi t ipi di so-stanze aeranti e plastificanti ed alla contemporaneadiminuzione della quanti tà d 'acqua d ' impasto.
Confrontando le variazioni di segregabilità con-seguenti ad eguali diminuzioni della quanti tà d'ac-qua d ' impasto per i calcestruzzi normali e per icalcestruzzi con sostanze plastificanti ed aeranti , sipotrebbe giungere a determinare l'effettiva influen-za dei fattori sopra menzionati sulla segregabilitàdei calcestruzzi.
Giovanni Tournon
Politecnico di Torino.
BIBLIOGRAFIA
H. L. KENNEDY, The function of entrained air in concrete -Journal of the American Concrete Institute, giugno 1943.
V. BAHRNER, Anvising for begagnande av Vebe - apparatenfor Konsistens proving - Svenska Cementforeningen,luglio 1945.
J. FAURY, he bèton - Ed. Dunod, 1947.
ROBERT L'HERMITE et GIOVANNI TOURNON, La vibration dubeton frais • Annales de l'Institut Technique du Bati-ment et des Travaux Publics, Beton, Beton Arme, n. 1,febbraio 1948.
M. VALENTA, Nouvelles recherches sur la gelivite des betons -Les Betons aeres - Annales de l'Institut Technique duBatiment et des Travaux Publics, Beton, Beton Armé,n. 3, maggio 1948.
A. AMMAN et BOYRIE, Le beton aere - Genie Civil, 15 giu-gno 1948.
LE MORVAN, Les bètons a entrainement d'air - Cahiers duCentre Scientifique et Technique du Batiment, luglio1948.
M. Ros, Einfluss des Zusatzes von Frioplast auf die bautech-nischen Eigenschaften des Betons - Eidgenossische Ma-terialpriifungs, Zurich, novembre 1948.
BARBEE, What have we learned about air entraining concrete- J. American Concrete Institute, aprile 1949, pag. 601.
ROBERT L'HERMITE, Fabrication et mise en oeuvre du beton- Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Bati-ment, aprile 1949.
M. DURIEZ, Le beton à air occlus1950.
Travaux, aprile-maggio
M. DURIEZ, Traité de Matériaux de Construction, Tome I,Ed. Dunod, 1950.
ROBERT L'HERMITE, Nouveaux procedés de traitement du bè-ton - Annales de l'Institut Teehnique du Batiment et desTravaux Publics, Bèton, Bèton Armé, n. 17, marzo-aprile1951.
ALFONS AMMAN, Luftporen Béonn. 1 e 2, 1952.
Schweiz. Bauzeitung,
M. DURIEZ, Les adjuvants du béton: plastifiants, entraîneursd'air et produits colloidaux - Annales de l'Institut Tech-nique du Batiment et des Travaux Publics, Béton, BétonArmé, n. 23, giugno 1953.
328 ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE - A. 7 - N. 9 - SETTEMBRE 1953 ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE - A. 7 - N. 9 - SETTEMBRE 1953 329
Fig. 11 - Diagramma degli indici di segregazione di un calcestruzzoper 5 min. di vibrazione in funzione delle quantità d'acquad'impasto.
Abbiamo visto nel paragrafo precedente secon-do quale legge la segregabilità di un calcestruzzodiminuisca col diminuire della quanti tà d'acqua diimpasto. È chiaro che la ragione essenziale della di-minuzione di segregabilità dei calcestruzzi otteni-bile con l'uso di sostanze plastificanti ed aeranti vacercata nel fatto che l ' impiego di queste sostanzeconsente di r idurre sensibilmente, a pari lavorabi-lità, la quanti tà d 'acqua d ' impasto.
Potrebbe essere di un certo interesse effettuareuna serie di prove allo scopo di rendersi conto se ladiminuzione di segregabilità, ottenibile con l 'uso disostanze plastificanti ed aerant i , derivi soltanto dalladiminuzione della quanti tà d 'acqua d ' impasto, cheè possibile realizzare a par i lavorabilità, o se in-vece intervengano anche altri fattori, dovuti peresempio alla presenza dei vacuoli sferoidali limitatida membrane dotate di tensione superficiale, at tequindi ad aumentare la coesione del calce-struzzo (2).
Una sperimentazione completa sull 'argomentodovrebbe comportare la determinazione dei dia-grammi di variazione degli indici di segregazionein funzione delle quanti tà d 'acqua d ' impasto perdiversi tipi di calcestruzzi normal i , nonchè la deter-minazione, per gli stessi tipi di calcestruzzi, dellevariazioni degli indici di segregazione conseguenti